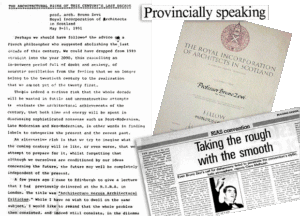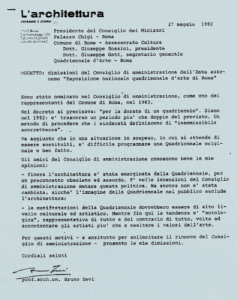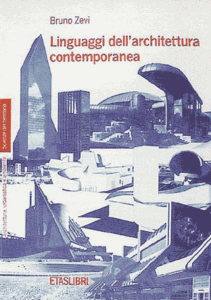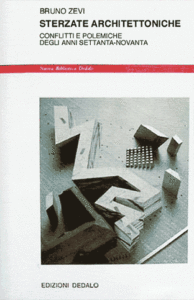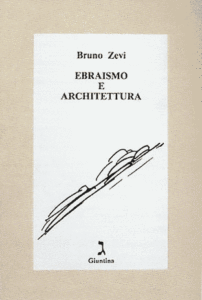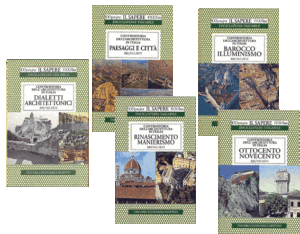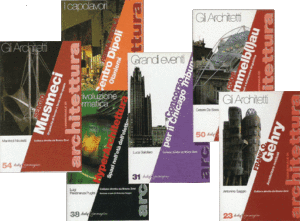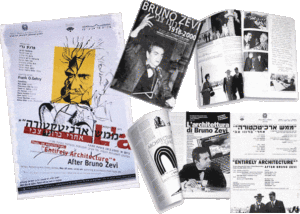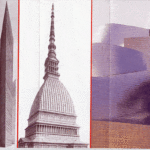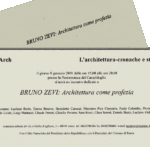Biografia: 1990-2002
1990
-
L’onorificenza “Yakir Bezalel” conferita dall’Accademia delle Arti e del Design di Gerusalemme.
Laurea honoris causa del Technion di Haifa.
Secondo: dopo chi?
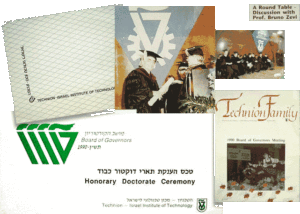 Marzo 1990. La Facoltà di Architettura del Politecnico di Haifa mi conferisce la laurea honoris causa. Con una certa solennità, il rettore mi comunica che io sono il secondo a essere insignito di tale riconoscimento.
Marzo 1990. La Facoltà di Architettura del Politecnico di Haifa mi conferisce la laurea honoris causa. Con una certa solennità, il rettore mi comunica che io sono il secondo a essere insignito di tale riconoscimento.
Ringrazio, mi dichiaro commosso.
Poi mi chiedo: quale architetto sarà stato il primo? Indago, nessuno lo sa. Frank Lloyd Wright? Improbabile. Le Corbusier o Gropius? Forse. Erich Mendelsohn, che è vissuto per vari anni nella Palestina ebraica?
«Nessuno di questi. Lei non lo può immaginare. Il primo, e finora l’unico, a ottenere la laurea honoris causa del Technion è David Ben Gurion, fondatore nel 1948 dello Stato di Israele. Motivazione:
«costruttore, architetto di Israele».
Relatore al Congresso Mondiale degli Architetti a Montréal.
La luce come forma architettonica
 Comitato Internazionale dei Critici d’Architettura (CICA) Congresso Mondiale degli Architetti
Comitato Internazionale dei Critici d’Architettura (CICA) Congresso Mondiale degli Architetti
Montréal, maggio 1990
Al culmine della poesia italiana del XIX secolo, Giacomo Leopardi produce il suo capolavoro: “L’infinito”. In pochi versi, s’identifica prima con il paesaggio circostante, poi con l’intero spazio, un mare di solitudine.
Il poeta dichiara di aver sempre amato il vicino colle e «questa siepe, che da tanta parte dall’ultimo orizzonte il guardo esclude». Il tormento, lo strazio comunicativo e semiologico si addensano su due parole: «ultimo orizzonte». Processo ideativo lungo e complesso. Si parte da «estremo confine»; poi «estremo» diventa «ultimo» e «confine» si trasforma in «orizzonte». Si nota immediatamente che «confine» è qualcosa di materiale e definito, mentre «orizzonte» è ambiguo, polivalente. Sfumature essenziali di significato; «confine» non implica luce, mentre «orizzonte» ne è pervaso. È evidente che Leopardi inietta luce nelle sue stesse parole. Il salto da un mero accidente, quello di non poter scrutare oltre l’estremo confine, alla drammatica tensione esistenziale che esclude dall’ultimo orizzonte viene operato attraverso la luce. Dopo la letteratura, consideriamo un film, “La dolce vita”, il famoso ritratto felliniano di una Roma decadente, corrotta e scandalosa, città-simbolo di uno sfrenato desiderio di euforia e autoannientamento. Nel più affascinante ed erotico episodio del film, l’attrice Anita Ekberg, una notte di gennaio, entra e cammina nella fontana di Trevi, atto che è un trionfo di licenziosità, esplosione sensuale e gioia disperata. Federico Fellini scrive di Anita Ekberg come di una «luminosa primavera» e aggiunge: «ritengo che Anita fosse, ne sono sicuro, fosforescente».
Come nelle parole di Leopardi «dall’ultimo orizzonte», in Anita Ekberg la forza vitale è data dalla luce.
Queste digressioni introduttive dovrebbero essere estese alla musica, al teatro, alla pittura, alla scultura e ad altri campi creativi. Ma, per quale motivo abbiamo scelto il tema specifico «La luce come forma architettonica»?
Si constata che i problemi della luce non sono sufficientemente analizzati nella corrente critica architettonica. Un fondamentale strumento del linguaggio dell’architettura viene dunque sottovalutato. Non solo: l’indifferenza dei critici nei confronti dei valori della luce si riflette automaticamente in quella dei progettisti; gli edifici risultano così privati di uno dei loro più arcani e ipnotici messaggi.
Ci sono molti modi di parlare della luce nelle fabbriche, negli ambienti urbani e nei paesaggi. Qui ometteremo tutti quegli aspetti del tema che, sebbene interessanti in se stessi, appaiono epidermici e secondari. Trascureremo «l’architettura della luce», le decorazioni luminose sovrapposte agli edifici, alle città e alle campagne, scenografie talvolta decenti, ma spesso offensive perché antitetiche alle strutture linguistiche dell’architettura.
«La luce come forma architettonica» è esattamente l’opposto dell’«architettura della luce», in quanto in quest’ultima la luce può essere indipendente dall’architettura e formarne una propria, mentre «la luce come forma architettonica» è inscindibile dai caratteri specifici dell’architettura. E poiché il linguaggio architettonico è qualificato dallo spazio interno, dalle cavità vissute in modo dinamico, «la luce come forma dell’architettura» concerne principalmente lo spazio interno e il suo involucro. Ripercorriamone l’itinerario.
Il periodo preistorico offre ciò che possiamo chiamare «il Grado Zero della luce architettonica». Nel 1981, al Congresso di Varsavia, fu sondato il tema tratto da Roland Barthes «Il Grado Zero della scrittura architettonica»; le conclusioni sono pubblicate nei saggi einaudiani “Pretesti di critica architettonica”. Ebbene, nella preistoria la luce si radica in questo contesto di azzeramento. Non ci sono regole, simmetrie, ripetizioni, assonanze, stabilità, armonie, equilibri e proporzioni, ma piuttosto conflitti e dissonanze di ogni genere e intensità. Assenza di norme prima che nascano dottrine e canoni: qui sta la gloria della preistoria, che sembra incarnare molte delle libertà che oggi stiamo cercando di raggiungere mediante i travagli decostruttivisti. Qui abbiamo un magico mondo precostruttivista dove la luce ignora la grammatica e la sintassi con effetti incantevoli e travolgenti.
Nelle caverne, nei passaggi sotterranei, nei templi e nelle chiese ipogeiche, la luce è più eloquente di quella di ogni altra epoca. Batte su pareti, soffitti e pavimenti che non sono piatti e separati gli uni dagli altri, ma continui, ruvidi, organici, impuri, contaminati, rovinati. Entro questo sistema, il buio gioca spesso un suo ruolo in fogge spettrali, terrificanti.
Per quanto riguarda la luce, l’intera storia dell’architettura può essere interpretata come una serie di tentativi per riconquistare i valori perduti della preistoria.
Nelle età antiche, il destino della luce segue quello dello spazio. Se lo spazio interno non è concepito creativamente, non c’è bisogno che la luce lo qualifichi e lo rafforzi.
Nell’antica Grecia, ad esempio, la luce cade sui volumi e sulle loro componenti, colonne, modanature, cornici. Le Corbusier parla giustamente di «volumi liberi e puri sotto la luce», non della luce attraverso e dentro i volumi.
Qualcosa di analogo accade nell’antica Roma. Quando lo spazio interno esiste, ma è statico, isolato, privo di contatti con lo spazio urbano, la luce resta un’entità fine a se stessa, come nell’oculo del Pantheon. La sfida di un dialogo tra spazio esterno e interno si protrae per secoli. Uno sbocco convincente viene trovato solo in epoca tardoromana, con il cosiddetto mausoleo di Minerva Medica, del III sec. d.C.
Nel Medioevo la luce deflagra, si fa protagonista dell’architettura, specie nei suoi interni stregati. Non di rado, la consistenza tettonica è disintegrata poiché l’involucro è ammantato di mosaici. Ogni profondità è riassorbita, e le pareti si riducono a superfici fluenti.
In questo mondo senza peso, la luce può determinare esiti stupefacenti.
Basti pensare a Santa Sofia di Costantinopoli o a San Vitale di Ravenna. Qui una sequenza di absidi perimetrali dilata il vuoto, attirando brani della cavità dall’interno verso l’esterno. Ma la luce contrasta questo moto e preme dall’esterno all’interno. Alla fine, la luce vince, inonda le superfici mosaicate che l’incorporano e la ritrasmettono tanto che sembra emanare da dentro a fuori. Le pareti sono radianti, assai più delle loro forature.
Uno dei primi monumenti dell’architettura romanica in Europa è Sant’Ambrogio di Milano. Luce eretica, trasgressiva. Essenzialmente, penetra attraverso le aperture della facciata e straripa nella navata centrale, ma per uno scopo particolare e sofisticato: per evidenziare, rasentandole, le fragili cornici emergenti sul fronte delle navate minori.
Non ci sono fonti luminose di rilievo sulle volte a croce, né ai lati. E qui sta il paradosso: la struttura della chiesa domina, imponente. L’espressione architettonica, però, deriva dalla luce. È insieme molto semplice o estremamente complicato cogliere il senso della luce gotica «come forma architettonica». Anzitutto perché, contrariamente a quanto abbiamo visto finora e vedremo dal Rinascimento ai tempi moderni, questa luce non buca le pareti per colorare lo spazio, ma è intrinseca all’involucro edilizio, tessuto da membrature strutturali e setti di luce. Si potrebbe affermare che nel periodo gotico la luce, soggetta com’è all’ideale della trasparenza, risulta sottovalutata. Infatti, dalla preistoria a Sant’Ambrogio, la luce è stata un elemento esorbitante le convenzioni del linguaggio architettonico, tanto da essere spesso considerata mistica e irrazionale. Durante l’età gotica, è catturata in moduli ripetitivi e appartiene a un rigido, spesso meccanico sistema «struttura-luce». Non a caso, ha bisogno di diventare più materiale e tattile, meno luce, mediante vaste vetrate istoriate.
La consequenzialità tra gotico e Rinascimento è confermata. Su basi puramente razionali il ruolo della luce è limitato, e solo pochi grandi architetti – tra cui Brunelleschi, Michelangiolo e Palladio – riescono a esplorarlo con originalità.
Il Manierismo e il Barocco celebrano la luce nelle sue molteplici, ammalianti sfaccettature. La luce della Controriforma, quella di Bernini e dei suoi seguaci, è funzionale all’apparato di propaganda cattolico, batte dunque su statue dorate e marmi sgargianti e preziosi, in una teatrale atmosfera emotiva. Contro questa corrente spettacolare si erge una minoranza guidata da Francesco Borromini e Guarino Guarini. Accade qualcosa di inaudito. La luce non è più diretta su pareti o su oggetti o su vuoti geometricamente strutturati, ma verso lo spazio, cavità informali e fluidificate. Sicché, colpendolo senza mediazioni, la luce rende lo spazio arbitro dell’intera immagine.
Preistoria, bizantino e Barocco: queste sono le tre età in cui la luce viene usata con maggiore fantasia. Seguono l’ibernazione neo classica e il movimento moderno.
Lo scontro tra razionalisti ed espressionisti non può essere analizzato con facili formule: com’è noto, Ludwig Mies van der Rohe è passato attraverso un’esperienza espressionista, mentre Erich Mendelsohn ha progettato edifici razionalisti. Tuttavia, in generale, si può affermare che l’espressionismo, da Hugo Häring e Mendelsohn a Hans Scharoun e Frederick Kiesler, adotta «la luce come forma architettonica», mentre il razionalismo la applica sostanzialmente in senso gotico.
Le Corbusier attesta. Durante gli anni Trenta, come abbiamo visto parlando dell’antica Grecia, ricerca «volumi puri sotto la luce», non una luce che colpisca, rompa e penetri questi volumi per esaltare lo spazio.
La conversione coincide con la Chapelle de Ronchamp, quando, dopo la catastrofe della guerra, Corbu sente l’urgenza di valori alternativi, non-razionali, per sopravvivere, persuadere ed evadere. Nella Chapelle il suono diviene «forma architettonica» e, insieme al suono, la luce che fluttua in guisa barocca, graziosa e terribile, plasma le varie parti e le sconnette.
Alvar Aalto modula l’intero organismo della chiesa di Imatra sulla fonte di luce dell’altare. Questo espediente però potrebbe condurre a un esito retorico. Allora le finestre sono progettate per veicolare calcolate quantità di luce: finestre manipolate, straordinarie, remote dai consueti «buchi nel muro».
Eero Saarinen s’imbatte nella luce disegnando la cappella «laica» del MIT a Boston. Per l’interno voleva un chiarore mutevole e tremulo, non un clima statico e uniforme. Tentò varie vie e, alla fine, scelse di far specchiare la luce esterna nel cerchio d’acqua circostante la cappella e poi di rifrangerla all’interno. Soluzione che apparve artificiosa, ma che resiste al consumo.
Si possono citare molti altri esempi di utilizzazione creativa della luce.
Ci limiteremo a due soli casi: il primo, il più grandioso e ispirato; il secondo, il più recente e provocatorio.
Tutta l’architettura di Frank Lloyd Wright può esser letta in termini di luce perché, sin dall’inizio del secolo, egli identificò il valore architettonico con lo «spazio interno», uno spazio che parla e canta attraverso la luce. Potremmo esaminare tre o dieci Prairie o Desert Houses, notando come soffitti, pareti, pavimenti, vetri decorati delle finestre, in realtà, ogni modanatura o dettaglio è concepito per ricevere, afferrare, trasformare e trasmettere la luce. Potremmo ricordare la luce nella hall centrale del Larkin Building a Buffalo del 1904, o quella dell’Unity Temple a Oak Park, Illinois, del 1906 o, più tardi, nel 1946-59, l’elicoidale del Guggenheim Museum a New York, con il suo dosaggio, magistralmente progettato, di luce naturale e artificiale. È significativo che Wright abbia denominato la sua ultima opera, il Tempio a Elkins Park, Philadelphia, Montagna di Luce.
Si possono passare ore illustrando come Wright manipola la luce e ne impronta tutti gli ingredienti della sua architettura. Conviene però indicare due aspetti della sua ricerca che sembrano più rilevanti.
Il primo viene elaborato durante il periodo californiano, in particolare nella villa La Miniatura a Pasadena del 1923, ma si trova anche in altri edifici, incluso il Florida College a Lakeland del 1938-50. Il problema era – e resta – il rapporto tra pareti e finestre, il modo in cui i buchi delle finestre minano l’integrità delle pareti e, viceversa, le pareti comprimono, stringono e mortificano le finestre. Wright detesta questa antinomia, vuole che la luce, anziché romperla, appartenga alla parete, infiltrandosi così in ogni direzione spaziale. La proposta: una parete di luce, ricca sotto il profilo materico, non-trasparente.
Unico e travolgente è il modo in cui la luce viene usata nel Johnson Wax Building a Racine, Wisconsin, del 1936-39. Non tanto nella torre, ma nell’edificio stesso, all’altezza del cornicione, dove nessuno si aspetterebbe un simile atto eversivo. Wright dichiara sinteticamente che, dopo aver abbattuto lo spigolo verticale, ponendo la luce nel luogo in cui le pareti s’incontravano per chiudere, soffocare lo spazio, ha voluto abbattere lo «spigolo orizzontale», la cerniera tra pareti e tetto. La vecchia scatola è stata così fracassata e decostruita mediante il solo legittimo strumento creativo: la luce. Wright è il genio dell’architettura moderna anche per quanto riguarda la luce-spazio: un’immensa miniera di idee e strategie ancora largamente inesplorata.
Povera, trasandata, avventurosa, imprevedibile, frammentata è l’architettura eli Frank Owen Gehry, l’ultimo eretico di questo ciclo. La sua poetica è diversa da quella di qualsiasi altro architetto contemporaneo, soprattutto perché è differente il contesto. Gehry non agisce sul paesaggio, e neppure sul paesaggio urbano. Il suo interesse si rivolge a ciò che chiama «cheapscape», paesaggio derelitto, di rifiuti, in cui si può intervenire con controversi, transitori «collages» di spazi e materiali. I suoi edifici non tentano nemmeno di compensare ciò che è «cheap», dimesso e volgare. Anzi, intendono appartenere al «cheapscape» senza alcuna idiota ambizione di abbellirlo. In questa poetica la luce è complicata, ambivalente, indeterminata, ancora una volta frammentata. È non-finita, non autosufficiente. Il processo di decostruzione aggredisce spazi, volumi e luce. Forse questa potrebbe essere definita architettura pre-organica perché l’aspirazione all’integrità esiste, ma è coscientemente sconfitta. Lo stesso con la luce: frustrata e ironica, triviale e sofisticata, carente nella tecnica e opulenta negli effetti visuali, sempre carica di invenzioni. Questa è davvero l’ultima tappa de «La luce come forma architettonica».
Una rapida conclusione. È stato un intollerabile errore di Hans Sedlmayr supporre che un’«arte della luce» potesse essere indipendente dall’«arte dello spazio». Nel celeberrimo saggio del 1960 egli parla di «una divinità della luce», una metafisica della luce. E con Goethe dichiara che i colori sono «imprese e sofferenze della luce».
Matrice neoplatonica: un tetro pessimismo sottende l’astratta visione.
Così apprendiamo che «l’uomo moderno ha perso la luce interiore e spirituale». Per fortuna queste idee di Sedlmayr hanno avuto poco peso nella storia dell’arte, e ancor meno nella critica architettonica.
La storia della luce in architettura converge con la storia dello spazio. La libertà dalla scatola significa la libertà dalla repressione. Nei secoli, spazio e luce incarnano e rappresentano le disfatte e le vittorie di questa lotta per la libertà.
Nel linguaggio corrente, oscurantismo sta per tirannia politica e culturale, censura e totalitarismo; mentre luce, chiarezza, trasparenza, perestroika stanno per società emancipata, civile, democratica. Si tratta di sconfiggere l’eclisse e la morte della luce.
-
Honorary Fellow del Royal Architectural Institute of Canada.
-
Membro dell’International Advisory Board della Postgraduate School o Architecture del Berlage Institute di Amsterdam.
Il Comune di Ferrara offre la cittadinanza onoraria.
La cittadinanza mancata
 Ricevo una lettera del Sindaco di Ferrara, Roberto Soffritti, datata 17 febbraio 1990:
Ricevo una lettera del Sindaco di Ferrara, Roberto Soffritti, datata 17 febbraio 1990:
«Gli studi approfonditi e appassionati che da decenni Ella ha dedicato alla storia urbanistica ferrarese, contribuendo in modo decisivo a farla conoscere nel mondo, e l’apporto critico e scientifico che ci viene dalla Sua partecipazione alla Commissione Consultiva per il Parco e le Mura, costituiscono ormai una ragione di relazione così stretta e organica con la cultura ferrarese, che ci pare un logico e gradito corollario la proposta di attribuirLe la cittadinanza onoraria. Voglio sperare che accolga quest’idea con la stessa simpatia che animano la Giunta e il Consiglio che l’hanno formulata».
Sono felice, aspetto che fissino la data della cerimonia che alcuni ipotizzano di posporre nel quadro delle celebrazioni del 1992. Ma… Fulmine e tempesta. Giunge la notizia che la Soprintendenza ai Monumenti sta massacrando il famoso Palazzo dei Diamanti sul corso Ercole d’Este. Una peculiarità estetica saliente di quest’opera progettata da Biagio Rossetti è quella di inserire, tra il manto lapideo delle facciate e il cornicione, una fascia in laterizio di straordinaria originalità. Ebbene, le addette alla Soprintendenza stanno brutalmente cancellando questo segno artistico, imbiancano i mattoni e appiattiscono l’immagine non si sa per quale insana e perversa ragione.
Scrivo subito al Sindaco: se il Comune resta passivo di fronte a un delitto di questa portata, un massacro gratuito e insulso, frutto solo di tracotanza da parte di coloro che dovrebbero salvaguardare i monumenti, io non posso accettare la cittadinanza onoraria. Ne soffro.
Risposta: silenzio.
1991
Consulente di “Lettera Internazionale”.
Il futuro dell’urbanistica
intervista a Bruno Zevi, “Lettera internazionale”
 Bruno Zevi è entrato a far parte del Comitato di consulenza di questa rivista. Già segretario generale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e ordinario di Storia dell’Architettura nelle Università di Venezia e Roma, è attualmente direttore del mensile “L’architettura – cronache e storia”, e presidente del Comitato Internazionale dei Critici d’Architettura. È inoltre presidente onorario e deputato del Partito Radicale. Alla sua ricca esperienza internazionale ci siamo rivolti, per un sommario bilancio del recente passato e per una valutazione del prossimo futuro dell’urbanistica.
Bruno Zevi è entrato a far parte del Comitato di consulenza di questa rivista. Già segretario generale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e ordinario di Storia dell’Architettura nelle Università di Venezia e Roma, è attualmente direttore del mensile “L’architettura – cronache e storia”, e presidente del Comitato Internazionale dei Critici d’Architettura. È inoltre presidente onorario e deputato del Partito Radicale. Alla sua ricca esperienza internazionale ci siamo rivolti, per un sommario bilancio del recente passato e per una valutazione del prossimo futuro dell’urbanistica.
Per inquadrare la situazione; qual è l’evento più rilevante del pensiero urbanistico degli ultimi venti anni?
Quello che ebbe luogo a circa 4000 metri di altezza, il 12 dicembre 1977, alle ore 14,30 sul Machu Picchu, lo spiazzo più elevato del rudere incaico peruviano. Di fronte ad un vasto pubblico decine di studiosi ed artisti firmarono una nuova Carta urbanistica, a distanza di quarantaquattro anni da quella formulata da Le Corbusier ad Atene nel 1933. Un documento fondamentale, che segna il passaggio fra epoche diverse.
Quali sono i punti sostanzialmente nuovi?
Quattro: città-regione, polifunzionalità, comunicazione e architettura. Nel 1933 il rapporto tra città e territorio era di interdipendenza fra ambiti differenti, che oggi invece si fondono nella città-regione. Nel 1933, l’intento era di separare le funzioni, distinguere tra abitare, lavorare, ricrearsi e circolare; oggi soffriamo i guasti della settorializzazione urbana e il nostro impegno consiste nel reintegrare. Inoltre, nel 1933 l’abitazione sembrava essere la chiave di volta della vita urbana; ora, la sopravvivenza degli aggregati sparsi sul territorio dipende dall’efficienza della rete delle comunicazioni. Infine, la Carta di Atene trascurava gli aspetti linguistici del problema, poiché la statura predominante di Le Corbusier faceva presupporre che l’architettura si esaurisse nella sua poetica, cioè nel «gioco sapiente dei volumi puri sotto la luce». La Carta del Machu Picchu afferma che la sfida non consiste più nei volumi puri, ma negli spazi sociali in cui si vive.
Queste sono le motivazioni essenziali. Poi conta l’animus…
In che senso?
Cito un brano della Carta: «Atene 1933, Machu Picchu 1977. I luoghi significano. Atene incarnava la culla della civiltà occidentale. Il Machu Picchu simbolizza il contributo culturale di un altro mondo. Atene implicava la razionalità di Platone e di Aristotele, l’illuminismo. Il Machu Picchu rappresenta tutto ciò che sfugge alla mentalità categorica dell’illuminismo e non è classificabile nella sua logica. I nostri interrogativi sono infinitamente più numerosi e complessi di quelli affrontati dagli autori della Carta di Atene. Alcuni forse non hanno risposta…».
Ma quale influenza ha avuto in concreto, nell’operatività urbanistica, la Carta del Machu Picchu?
Molta sul terreno critico, scarsa su quello inventivo. Dal 1977 i principi razionalistici sono stati smentiti e rifiutati. In particolare, la rigida zonizzazione funzionale, la divisione tra quartieri residenziali, industriali, direzionali, ricreativi è caduta in disgrazia. Il linguaggio riduttivo degli anni Venti-Quaranta è ormai esautorato, anche se il nuovo non è pienamente sorto, perché risulta arduo ragionare senza formule e modelli. Del resto, non fu così nel passaggio tra il Rinascimento e il Barocco, tra l’ortogonalità del primo e la libera spazialità tempestata dalla luce del secondo?
Prima di entrare nell’attualità, nei temi dell’inchiesta sulla città trattati in questo numero della rivista, sarebbe utile accennare ai contributi da lei apportati all’urbanistica e alla sua critica storica.
Secondo me, l’architettura s’identifica con l’urbanistica, tanto che spesso ho adottato il termine «urbatettura». Spazio interno, da un lato; spazio esterno (rispetto alle case, ma interno al tessuto urbano), racchiuso e scoperto, dall’altro. Il rapporto è già esplicito in “Saper vedere l’architettura” del 1948, il mio libro di maggior successo. Nel libro “Biagio Rossetti, architetto ferrarese, il primo urbanista moderno europeo”, del 1960, ho ripercorso l’autocostruzione di Ferrara avvenuta a partire dal 1492, circa cinque secoli fa. Nodo linguistico cruciale: una concezione rinascimentale nutrita di pulsioni medievali, e quindi non ancora ibernata, produce l’immagine di un abitato allo stesso tempo pianificato ed umano, accentuatamente gestito e flessibile. Il caso è talmente sintomatico che nel 1971 ho ripubblicato il libro con il titolo “Saper vedere l’urbanistica”, premettendo una panoramica della storia degli insediamenti dall’età delle caverne a quella dei grattacieli. Il mio interesse si è poi concentrato sull’urbanistica del manierismo e, in modo specifico, su quella di Michelangiolo. La rivoluzionaria Roma michelangiolesca (incrementata poi da quella borrominiana) è documentata nel volume “Michelangiolo architetto” del 1964, e in “Pretesti di critica architettonica”, del 1983. Mi fermo qui.
L’esperienza della cultura americana nella Harvard University e la frequentazione di Frank LIoyd Wright, esponente dell’architettura organica, sono stati fondamentali nella sua formazione…
Certamente. A mio giudizio, il Rinascimento sta al razionalismo cartesiano, tipologico e tecnocratico di Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, come il Barocco di Pietro da Cortona e Francesco Borromini (non quello scenografico di Bernini) sta al linguaggio organico di Wright, Alvar Aalto, Hugo Häring, Hans Scharoun e discepoli. Si cambia modo di scrivere e di parlare: crolla l’ideologia dell’elementarismo geometrico, delle scatole bianche e «pure» allineate, degli angoli retti, delle iterazioni ossessive. La complessità sconfigge la semplificazione, la dinamica dell’informale travolge le morfologie armoniche, cristalline. Rispetto al pensiero di Le Corbusier, quello di Wright, malgrado la cronologia, è più avanti di cinquant’anni. Lo ha capito a fondo un solo studioso, Lewis Mumford.
Mezzo secolo più avanti anche in urbanistica?
Senza dubbio, benché il fenomeno sia più evidente in architettura.
Wright ha offerto due soluzioni opposte e complementari: «Broadacre City», l’insediamento orizzontale, espanso sul territorio, e «The Illinois», il grattacielo vertiginoso per Chicago, alto un miglio, 528 piani serviti da scale mobili e 56 ascensori, un organismo per 130.000 abitanti con parcheggio per 15.000 auto e terrazze per 100 elicotteri.
Espansione o concentrazione verticale: questo è tuttora un dilemma calzante, da approfondire. Invece ci si diverte almanaccando sulla fine dell’urbanistica o sulla rinascita della cosiddetta «città europea» esaltata dall’internazionale degli accademici e dei retrogradi non solo nazi-fascisti e stalinisti.
Ma l’idea di mettere sotto processo l’intera operatività urbanistica non nasce proprio negli Stati Uniti?
Nel 1961 esce il libro di Jane Jacobs “The Death and Life of Great American Cities” che traumatizza la cultura urbanistica fino a rovesciarne gli orientamenti. Anziché pianificare, si postula «una vita sociale disordinata, instabile, spontanea», come dice Richard Sennet. Si rigetta sia l’urbanistica razionalista sia quella organica di Wright. Ma con la terapia del non-intervento, i problemi delle città non vengono affatto risolti; dilagano gli sprechi, gli istinti gregari, i comportamenti sclerotizzanti. Si constata insomma che tutelare, conservare, restaurare e magari riciclare non basta. Occorrono nuove politiche e nuove strategie.
Entriamo in pieno nel dibattito che riguarda le città storiche, monumentali, artistiche, da Venezia a Cambridge, da Barcellona a Cracovia.
Fortunatamente i sostenitori della città mummificata, depressa e frustrata, schiava del proprio passato, sono diminuiti (restano comunque troppi); mentre i post-moderni, i pasticcioni e i dementi ludici che volevano esprimersi coniugando frammenti e sgrammaticature pseudo-antiche, e si vantavano di aver sottratto l’architettura all’egemonia politica, sono finiti nel grottesco e nella vergogna.
In conclusione, quali sono le forze in gioco?
La speranza è riposta negli architetti che hanno respinto l’immondezzaio post-moderno e sono in grado di ripensare la città. Citiamone alcuni: Halprin, Gehry, Johansen, Erskine, De Carlo, Hadid, Hejduk, Piano, Hertzberger, Libeskind, Tschumi, Rogers, Foster, Behnisch, Krool. Le forze ci sono. Occorre coagularle intorno ad un progetto politico-culturale che non riguarda solo gli architetti.
Va anche considerato che presto potremo avvalerci di nuovo degli apporti urbanistici ibernati per decenni del mondo sovietico.
Dimissioni da presidente del Partito Radicale e nomina a presidente d’onore.
Professione: dimissionario
Dalla Gescal, perché non volevano utilizzare i fondi Ina-casa per la ristrutturazione degli edifici esistenti. La mania delle costruzioni nuove, magari nell’estrema periferia, sembrava inguaribile.
Da ”L’Espresso”, nel 1967, perché un articolo del direttore Eugenio Scalfari sembrava eccessivamente pro-palestinese e antisionista. Ripresi a collaborare solo dopo alcuni mesi di assenza.
Dall’università, nel 1979, per i motivi ampiamente documentati, malgrado l’affettuosa insistenza del rettore Antonio Ruberti. Dal gruppo progettuale della 161 a Roma, nel 1984, perché il piano dei nuovi insediamenti approvato dall’Assessore Vincenzo Pietrini era chiaramente sbagliato.
Dal Partito Radicale, due volte (per 24 ore, ciascuna): quando optarono per il simbolo di Gandhi che detesto (il simbolo, s’intende); e quando fu eletto un «quadriumvirato» che sembrava destinato a liquidare il partito, e di cui non volli far parte. Dimessomi da presidente del partito, fui nominato presidente d’onore.
Dal comitato dell’Auditorium a Roma, nel 1986, perché sostenevo e sostengo che una «città della musica» deve sorgere a Pietralata o a Centocelle, comunque lungo l’Asse dei nuovi centri direzionali, e non nel nucleo storico, a piazza Cavour o al Borghetto Flaminio.
Dal consiglio di amministrazione della Quadriennale d’Arte nel 1992, perché non condividevo il criterio «antologico», acritico di numerose mostre dirette a soddisfare le ambizioni di molti artisti a scapito dei valori dell’arte.
Polemica sul restauro del Palazzo dei Diamanti a Ferrara.
“Che arbitrio!” E rifiuta la cittadinanza onoraria.
“il Resto del Carlino”, 2 agosto 1991
 “Soprintendenti assassini di monumenti” è il titolo violentissimo ed emblematico di una polemica tornata rovente: “L’architettura”, periodico nazionale diretto da Bruno Zevi, dedica nel numero di luglio-agosto un editoriale al vetriolo sul restauro di Palazzo dei Diamanti e accusa pure gli amministratori cittadini. «A un biografo di Biagio Rossetti era stata conferita la cittadinanza onoraria di Ferrara, l’ha rifiutata perché il Sindaco e il consiglio comunale non hanno difeso con la necessaria energia il capolavoro del Palazzo dei Diamanti» si legge nella chiusura dell’editoriale, ricordando il gran rifiuto dell’onorificenza da parte dello stesso Zevi. Il ripristino del celebre edificio rossettiano -diretto dalle Soprintendenze di Ravenna e Bologna – è stigmatizzato con acredine: «Si tratta di uno scandalo inconcepibile, forse dell’arbitrio più assurdo nella storia già così macchiata delle Soprintendenze ai monumenti». Senza mezzi termini la denuncia di cecità intellettuale e di arroganza burocratica: «Lo splendore dei Diamanti è dovuto, tra l’altro, ad un elemento di somma originalità: un’alta fascia laterizia che sormonta la tessitura lapidea immettendo un valore cromatico unico, remoto dall’uniformità rinascimentale, per esempio, del fiorentino Palazzo Strozzi. La Soprintendenza, – continua il j’accuse – pretende di cancellare questo segno dovuto al genio di Biagio Rossetti, l’urbanista della città estense. Tutto va brutalmente imbiancato, in omaggio a considerazioni stilistiche arzigogolate quanto fasulle». Da qui gli attacchi agli amministratori del Comune, imputati di scarsa attenzione per le sorti del palazzo simbolo. L’accesa diatriba ritrova ospitalità anche sulle pagine del Bollettino nazionale di “Italia Nostra”, l’associazione che si schierò fin dall’inizio contro la scialbatura del fascione sottotetto. Ma proprio “Italia Nostra” pubblica l’intervento del direttore vicario dell’Istituto Centrale del Restauro, Pio Baldi, che difende il recupero «condotto in modo scrupoloso, con studi storici e tecnici approfonditi, da funzionari di valore». E rassicura: la contestata imbiancatura è sicuramente rimovible.
“Soprintendenti assassini di monumenti” è il titolo violentissimo ed emblematico di una polemica tornata rovente: “L’architettura”, periodico nazionale diretto da Bruno Zevi, dedica nel numero di luglio-agosto un editoriale al vetriolo sul restauro di Palazzo dei Diamanti e accusa pure gli amministratori cittadini. «A un biografo di Biagio Rossetti era stata conferita la cittadinanza onoraria di Ferrara, l’ha rifiutata perché il Sindaco e il consiglio comunale non hanno difeso con la necessaria energia il capolavoro del Palazzo dei Diamanti» si legge nella chiusura dell’editoriale, ricordando il gran rifiuto dell’onorificenza da parte dello stesso Zevi. Il ripristino del celebre edificio rossettiano -diretto dalle Soprintendenze di Ravenna e Bologna – è stigmatizzato con acredine: «Si tratta di uno scandalo inconcepibile, forse dell’arbitrio più assurdo nella storia già così macchiata delle Soprintendenze ai monumenti». Senza mezzi termini la denuncia di cecità intellettuale e di arroganza burocratica: «Lo splendore dei Diamanti è dovuto, tra l’altro, ad un elemento di somma originalità: un’alta fascia laterizia che sormonta la tessitura lapidea immettendo un valore cromatico unico, remoto dall’uniformità rinascimentale, per esempio, del fiorentino Palazzo Strozzi. La Soprintendenza, – continua il j’accuse – pretende di cancellare questo segno dovuto al genio di Biagio Rossetti, l’urbanista della città estense. Tutto va brutalmente imbiancato, in omaggio a considerazioni stilistiche arzigogolate quanto fasulle». Da qui gli attacchi agli amministratori del Comune, imputati di scarsa attenzione per le sorti del palazzo simbolo. L’accesa diatriba ritrova ospitalità anche sulle pagine del Bollettino nazionale di “Italia Nostra”, l’associazione che si schierò fin dall’inizio contro la scialbatura del fascione sottotetto. Ma proprio “Italia Nostra” pubblica l’intervento del direttore vicario dell’Istituto Centrale del Restauro, Pio Baldi, che difende il recupero «condotto in modo scrupoloso, con studi storici e tecnici approfonditi, da funzionari di valore». E rassicura: la contestata imbiancatura è sicuramente rimovible.
Saggio "La città-territorio wrightiana".
1992
-
Accademico emerito dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.
Membro della giuria del premio della Fondazione Wolf, che sceglie tre architetti: il danese Jörn Utzon, l’inglese Denys Lasdun e il californiano Fran Gehry.
Frank Gehry a Gerusalemme
Non potevamo incontrarci a Los Angeles o a Roma – che senso avrebbe avuto? Gli dico: «Lei è l’architetto che più mi interessa e attrae, oggi al mondo». Il
Premio WoIf 1992 risponde affermando che la lettura dei miei libri è stata fondamentale per lui:
“Architecture as Space” quando era studente, “The Modern Language of Architecture” più tardi, ma specialmente i saggi raccolti in “Bruno Zevi on Modern Architecture” da Andrea Oppenheimer Dean. «L’ho divorato, l’ho ingerito tutto d’un fiato.. Non volevo, non potevo interrompere. Mia moglie me lo ha strappato dalle mani perché la cena era pronta».
«E Wright che ruolo ha avuto nella sua formazione, che ruolo ha adesso?» «Un ruolo decisivo, e crescente». «Ma lo ha conosciuto?» «No, e me ne pento. È successo questo. Viaggiavo con la famiglia verso la California, quando ho deciso di sterzare verso Phoenix, Arizona, proprio per incontrare Wright. Una digressione faticosa, compiuta con giovanile entusiasmo. Ebbene, giungiamo finalmente a Taliesin West.
All’ingresso mi chiedono un dollaro per entrare. “Al diavolo!”, pensai e tornai indietro».
Contro le posizioni conservartici del principe Carlo d'Inghilterra.
I “colleghi” d’accordo. Ma Zevi: «Non ha il senso del ridicolo».
“La Stampa”, 1 febbraio 1992
 «Esautorato in patria, dove nessuno lo ascolta, il principe Carlo cerca eco in Italia per propugnare una risibile accademia pseudorinascimentale che la Gran Bretagna non ha mai avuto. Il principe possiede tutte le virtù regali ma non ha il senso del ridicolo»: il giudizio secco e duro mi viene dato da Bruno Zevi, lo storico dell’architettura moderna che più tenacemente si è battuto contro i tentativi di ritorno a linguaggi del passato, magari sotto etichette post-moderne.
«Esautorato in patria, dove nessuno lo ascolta, il principe Carlo cerca eco in Italia per propugnare una risibile accademia pseudorinascimentale che la Gran Bretagna non ha mai avuto. Il principe possiede tutte le virtù regali ma non ha il senso del ridicolo»: il giudizio secco e duro mi viene dato da Bruno Zevi, lo storico dell’architettura moderna che più tenacemente si è battuto contro i tentativi di ritorno a linguaggi del passato, magari sotto etichette post-moderne.
Ma la battuta fulminante di Zevi contro il principe che accusa gli architetti di aver provocato «più danni dell’aviazione di Hitler» rimane isolata nei commenti di altri critici e architetti progettisti i quali mostrano una certa comprensione, pur rifiutando di condividere le scelte stilistiche di Carlo d’Inghilterra. Ecco il parere di Giancarlo De Carlo: «Mi sono incontrato col principe a Londra: mi è sembrato sincero nelle sue denunce dei guasti causati da dissennate operazioni immobiliari. Quella dei Docks di Londra è un autentico disastro. Trovo esemplare il fatto che un erede al trono si occupi dei problemi sociali originati dalla speculazione edilizia, che punti il dito contro l’imbecillità di alcuni architetti, che in tv mostri i labirinti mostruosi di cemento, come lui definisce certe opere firmate. Ma non concordo quando dalla critica passa alle proposte architettoniche».
Questa sembra proprio l’ambizione della scuola fondata da Carlo d’Inghilterra: «Condurre a un’architettura che rispetti le caratteristiche più antiche» contrastando il degrado delle città. Il modello dell’urbanistica voluta dal principe è «quella splendida città che è Siena». Forse per questo motivo aveva chiamato a Londra Giancarlo De Carlo, il quale ha fama internazionale per l’opera che svolge da anni a Siena come studioso e docente, nonché per il piano di Urbino. «Ma avere come modello Siena non significa farne la copia in Inghilterra. Il principe Carlo non è soltanto un romantico. Ha studiato, è una persona intelligente e colta. Però rischia di cadere quando propone il ritorno a linguaggi del passato, anche all’architettura vernacolare. Sarebbe una confessione di impotenza».
C’è un architetto inglese di origine toscana, Richard Rogers, duramente attaccato dal principe, al quale ha replicato non meno duramente. È autore, tra l’altro, del discusso Palazzo dei Lloyd’s di Londra. Rimprovera al principe, più delle sue scelte stilistiche, una certa tendenza a usare il suo prestigio e il suo potere per orientare le giurie dei concorsi, per bloccare progetti che non rispondono ai suoi gusti.
Ne parlo con Renzo Piano, il quale fu associato a Rogers nell’avventura del Beaubourg: «So che il principe mi ha perdonato quello che gli sembra un peccato di gioventù. Ne ebbi la sensazione a Londra quando la regina Elisabetta mi consegnò la Gold Medal del Royal Institute of British Architects. Sinceramente, da architetto, non riesco a combatterlo. Mi sembra che abbia imboccato una strada un po’ da ingenuo, avendo però molte giustificazioni per le sue critiche. Le trasformazioni pesanti subite da Londra e da altre città inglesi hanno creato un malessere urbano reale. Gli architetti avevano nobili cause e nobili aspirazioni; il movimento moderno ci aveva dato in eredità il rifiuto della decorazione e il culto della razionalità. Dobbiamo riconoscere che l’interpretazione dei canoni moderni è stata fatta da troppi in modo banale, impoverendo l’architettura e rinunciando a ogni riferimento alla memoria, all’eredità del passato.
Pubblicazione di "Sterzate architettoniche".
1993
-
Presidente emerito del Comité International des Critiques d’Architecture (CICA).
-
Il Ministero dei Beni Culturali ferma lo scempio del palazzo dei Diamanti a Ferrara.
-
Confermata la presidenza d’onore del Partito Radicale nel congresso tenutosi a Sofia.
Mostra su Richard Meier e Frank Stella al Palazzo delle Esposizioni di Roma.
Tributo anomalo a Richard Meier
 Quando osservo le sue opere e tento di scrutarne l’enigmatica personalità, stupisco poiché mi vien fatto di rievocare, spontaneamente e senza ombra di erudizione (indovinate che?), il complesso monumentale di Baalbek in Siria, del III secolo d.C. Come si spiega questo strano avvicinamento?
Quando osservo le sue opere e tento di scrutarne l’enigmatica personalità, stupisco poiché mi vien fatto di rievocare, spontaneamente e senza ombra di erudizione (indovinate che?), il complesso monumentale di Baalbek in Siria, del III secolo d.C. Come si spiega questo strano avvicinamento?
Il motivo è abbastanza semplice. Baalbek rappresenta l’estremo, eroico, acrobatico tentativo di svolgere un discorso nuovo, moderno, efferatamente eversivo adottando un lessico e una sintassi tradizionali.
Un minuto di riflessione. Siamo nel III secolo. A cominciare dall’età adrianea il “modo del narrare continuo” ha preso il posto della visione paratattica, della sequenza di quadri indipendenti e anche dell’illusionismo proprio del mondo ellenistico. Roma si è finalmente liberata degli stili classici, delle regole compositive, degli inceppi accademici: ha generato una sua specifica lingua, fondata su archi, volte, conglomerati atti ad involucrare spazi grandiosi e personalizzati, quelli delle terme, delle basiliche, dei teatri e degli anfiteatri, nonché dell’edilizia popolare, quella che sta dietro le muraglie e le facciate.
Con questi strumenti linguistici si affronta il tema vertiginoso di Baalbek, il gigantesco atrio esagonale, il Tempio di Giove, il più vasto del mondo antico, e quello di Nettuno che disimmetrizza in guisa clamorosa l’insieme.
Anche ad una prima analisi, l’effetto è sbalorditivo. Non un arco, non una volta, non un centimetro cubo di conglomerato cementizio entrano nel gioco estetico. L’immagine è inedita, irruente, straboccante, ma rifiuta una tecnica e un codice formale atti a recepirla e a veicolarla. E allora cosa avviene?
L’incredibile: con un anticipo di tredici secoli, un gesto michelangiolesco. L’interno del Tempio di Nettuno è invaso da un manierismo incontenibile e furente, analogo a quello del ricettacolo della Laurenziana fiorentina.
L’orientamento di Meier, volendo decodificarlo, appare simile a quello degli artefici di Baalbek. Infatti, sin dall’immediato dopoguerra fu per tutti evidente che il linguaggio del razionalismo era consumato; per chi non l’avesse capito, lo aveva urlato lo stesso Le Corbusier con l’anatema informale di Ronchamp. Era sorto un linguaggio alternativo, spaziale ed organico, quello lanciato da Frank Lloyd Wright, uno dei massimi geni creativi, forse il più grande, dell’intera vicenda architettonica.
Allora, quale strada seguire per Meier e la sua generazione? Quella del vecchio discorso, quella opposta dettata da nuovi mezzi espressivi, o quella di Baalbek, discorso nuovo nell’ambito di un codice linguistico consolidato?
Non ho mai parlato di questi problemi con Richard Meier, se non una sera, molti anni fa, in un recesso della Villa Aurelia al Gianicolo, dove penetrava, malgrado tutto, l’atmosfera esiziale, da lager culturale, dell’Accademia Americana a Roma. Ma questo era e resta il dilemma sostanziale del nostro linguaggio, anche se negli anni sono state avanzate altre ipotesi, come quella della “de-architetturazione”. Tra i primi a comprendere il dilemma razionalismo/organico fu un grande storico e critico, Lewis Mumford che, sin dal 1943, si pose un interrogativo che Meier, io, tutti noi ancora ci poniamo: dove va l’architettura?
Ebbe luogo un dibattito nell’Auditorium del Museum of Modern Art di New York.
Cosa voleva Mumford, su quale indirizzo puntava? In sintesi, su un’architettura organica, wrightiana, ma affrancata dalle ipoteche psicologiche e stilistiche del genio di Taliesin.
Un’architettura affidata agli spazi dinamici e all’articolazione volumetrica nel paesaggio, ma sganciata dalla sua fonte creativa. Quasi un paradosso, un’utopia. Dove trovarla? Mumford annaspava.
Alla fine la scoprì o, meglio, immaginò di scoprirla in California, incarnata da William W. Wurster, compagno di Catherine Bauer, sua stupenda collaboratrice. A tale corrente, come molti ricorderanno, dette il nome di “Bay Region Style”.
Credo che il processo di Meier non sia remoto da quello di Lewis Mumford. Ragiona che la statura di Wright è travolgente e quindi occorre diffidarne. Come a Baalbek, è meglio attenersi ai linguaggi razionalisti, a Le Corbusier, Mies, magari Schindler e Aalto.
Tra i colori, meglio optare per il bianco. Il risultato è però tutto diverso da quello programmato.
Le Corbusier, Mies e Aalto sono mere coperture, dietro le quali vibrano con dolcezza o violenza spazi rigonfi o rarefatti di matrice wrightiana, luci tenui o chiassose, ma comunque qualificanti. L’Athenaum di New Harmony, Indiana, è un testo fondamentale di poesia dissonante, autentica, magica e complessa. E chiudo. Meier ha vissuto queste drammatiche decadi afferrato a pochissime certezze e molti dubbi, ad un manierismo intellettualizzato fino allo spasimo, a un “discorso sul discorso” dei maestri. Se il finlandese Pietilä, per sfuggire allo storicismo e all’abietto post-moderno, s’aggancia al X secolo, cioe alla scrittura architettonica di grado zero dell’Alto Medioevo, e Frank O. Gehry alla rinascita romanica dei secoli XII e XIII, di fronte al puzzle del III secolo Richard Meier é lì, è qui con i suoi collages e le sue città in miniatura, perplesso, angosciato e gioioso, naufrago anche nella vittoria. E noi con lui.
1994
Relatore al Convegno “International Style Architecture Conference”, Tel Aviv.
Intervento alla “International Style Architecture Conference”
Tel Aviv, 23 maggio 1994.
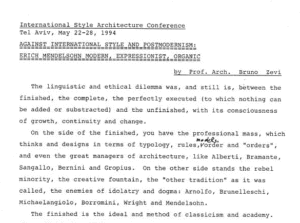 Il dilemma linguistico ed etico era, ed è tuttora, tra il “finito”, il completo, l’eseguito a perfezione (cui nulla si puoi aggiungere o sottrarre) e il “non-finito” con la sua coscienza di crescita, continuità e mutamento.
Il dilemma linguistico ed etico era, ed è tuttora, tra il “finito”, il completo, l’eseguito a perfezione (cui nulla si puoi aggiungere o sottrarre) e il “non-finito” con la sua coscienza di crescita, continuità e mutamento.
Dal lato del “finito” troviamo la massa dei professionisti, che pensa e progetta in termini tipologici, secondo regole, modelli, ordine ed “ordini”, e persino i grandi managers dell’architettura, Alberti, Bramante, Sangallo, Bernini e Gropius. Sull’opposta sponda sta la minoranza ribelle, la fontana creativa, l’”altra tradizione” come è stata denominata, quella dei nemici dell’idolatria e del dogma: Arnolfo, Brunelleschi, Michelangiolo, Borromini, Wright e Mendelsohn.
Il “finito” è l’ideale e il metodo del classicismo, dell’accademia
e del potere. Il “non-finito” qualifica il comportamento del genio. Il “finito” incorpora il mito dell’uguaglianza. Il “non-finito”, quello dell’emancipazione del diverso.
Negli anniVenti, due figure si ergevano ai poli estremi della cultura architettonica. La prima era l’artista e intellettuale olandese Theo van Doesburg, che elaborò una grammatica e una sintassi per la lingua cubista, sempre a rischio di ricadere nel classicismo, nelle scatole statiche, anche se sospese su pilotis. La seconda era Erich Mendelsohn, che apprezzava van Doesburg più della Scuola di Amsterdam, ma non poteva condividere la meccanica operazione di de-costruire il volume edilizio in lastre bidimensionali, e poi di riassemblarle in modo che producessero un oggetto quadridimensionale.
Lo scontro verteva chiaramente sul destino della terza dimensione, la profondità. Il fronte del “finito” sosteneva che occorreva distruggerla, poiché derivava dalla prospettiva rinascimentale, da una visione contemplata da un punto di vista immobile. Il cubismo aveva scoperto che questo punto di vista poteva essere dinamico, che l’uomo poteva
muoversi intorno, sotto, sopra, dentro e attraverso la scatola edilizia.
La terza dimensione perciò poteva e doveva essere eliminata.
Il fronte opposto, benché in modi non troppo articolati, disse NO.
Concordava sul dinamismo, sul movimento, anche sullo spazio-tempo, ma sentiva che il nuovo impeto rivoluzionario doveva investire non solo l’osservatore, l’uomo che cammina intorno e dentro l’edificio, ma anche la natura, la struttura genetica dello stesso edificio.
Nella fase più drammatica della ricerca di un nuovo linguaggio architettonico, un incontro-chiave ebbe luogo a Parigi poco prima della grande guerra. I cubisti francesi, gli espressionisti tedeschi e i futuristi italiani erano presenti. Umberto Boccioni propose un’alleanza fra i tre gruppi al fine di svolgere un’azione comune dell’avanguardia europea negli Stati Uniti. Fu raggiunto un accordo e pubblicato un manifesto firmato da molte personalità di rilievo, prima delle quali Guillaume Apollinaire. Ma poi seguì un arresto di attività e scambi, e non solo a causa della guerra e della scomparsa di Boccioni.
Tre concetti di spazio-tempo erano a confronto: quello cubista, basato sul cambiamento del punto di vista; quello futurista, che voleva semplicemente applicare elementi cinetici, quali ascensori e tapis-roulants, fuori e dentro gli edifici; e infine quello espressionista, che sosteneva il movimento, la quarta dimensione, a condizione che appartenesse alla realtà intrinseca dell’edificio e da questa emanasse. La tesi cubista negava la terza dimensione. I futuristi, in particolare Antonio Sant’Elia, erano più o meno indifferenti. Invece gli espressionisti legittimavano l’intero impianto scatolare, ma contorcendolo e torturandolo, come negli schizzi di Finsterlin e di Mendelsohn, e nella Torre Einstein.
Si giunge così al nodo del linguaggio architettonico. Qual è il motivo di plasmare pareti, soffitti e pavimenti in modo che sembrino di plastica, elastici, pronti ad assumere qualsiasi forma? È evidente.
In un edificio scatolare si trovano vuoti scatolari, spazi insignificanti, privi di fluenze. Ma in un volume dove pareti, pavimenti e soffitti sono stati forgiati in maniera creativa, le cavità sono tutte diverse, non derivano dall’involucro, anzi determinano il proprio guscio, in altre parole divengono quello che devono essere: protagonisti dell’architettura.
Certo, lo spazio può essere magnificamente incanalato con il lessico e la sintassi “De Stijl” di Theo van Doesburg: basti pensare al Padiglione di Barcellona di Mies van der Rohe o, in un altro linguaggio, alla Villa Savoye di Le Corbusier. Ma per realizzare spazi creativi nella loro piena significanza ed articolazione, la sfida di plasmare un vero vuoto umano richiede una filosofia progettuale espressionista.
Superfluo osservare che l’espressionismo, come il suo nemico, il cosiddetto “Stile Internazionale”, può essere usato per i peggiori propositi. L’espressionismo architettonico è, insieme, difficile e raro. Prima della seconda guerra mondiale è stato incarnato da pochissimi artisti, Antoni Gaudì, Mendelsohn, Hugo Häring, Hans Scharoun, e solo Gaudì e Mendelsohn erano sensibili ai valori materici incandescenti. Gli altri erano pseudo-artisti. Anche nelle decadi successive all’ultima guerra, troviamo pochi autentici espressionisti, dal Le Corbusier di Ronchamp e del Philips a Bruxelles a Pietilä, Utzon, Bruce Goff, talvolta Eero Saarinen, Behnisch, Domenig e Frank Gehry.
La maggioranza dei cosiddetti “neo-espressionisti”, specie negli anni Ottanta, è stata fatua e fasulla, vergognosamente inconsistente, tanto che spesso è tornata indietro alla pseudo-rinascenza, allo pseudo-gotico, allo pseudo-Art Nouveau, ad un palladianesimo idiota, insomma ad un passato che non conosceva e quindi misinterpretava.
Ormai, fortunatamente, il Post-Modern è morto e decomposto; benché il suo cadavere sia ancora occasionalmente nauseante, non vale la pena di perdere tempo a parlarne.
È noto che Einstein, quando vide a Potsdam la struttura che Mendelsohn aveva progettato, pronunciò una sola parola: «organico».
Non disse «espressionista», ma «organico» perché organico significa espressionista applicato non solo a pareti, soffitti, pavimenti e volumi, ma anche all’obiettivo architettonico dominante: lo spazio, gli spazi viventi e vissuti, gli spazi per l’uso individuale e collettivo, per il comportamento e l’azione democratica.
Lo stesso sul terreno urbanistico. Esiste un metodo cubista, razionalista, International Style, codificato nella Carta di Atene del 1933. Gli espressionisti non hanno formulato una “philosophy” della pianificazione se non in imprese di scala modesta. Ma gli organici hanno modificato e integrato la Carta di Atene nel 1977, elaborando la Carta del Machu Picchu, un documento rilevante e spesso sconosciuto.
Erich Mendelsohn era organico per natura, per valori atavici, come dimostrano centinaia di schizzi di originalità inaudita. Egli non seguì alcuna scuola, sicché non fu costretto a dimenticare quello che aveva imparato a scuola, come tutti gli architetti decenti hanno dovuto fare con notevole fatica. Egli non ebbe alcun maestro, ma ne scelse uno lontano, e nel 1924, dopo la Torre Einstein, partì per incontrarlo a Taliesin. Questi passi di una lettera scritta alla moglie Louise da Chicago, il 6 novembre 1924 incarnano il più convincente messaggio dell’architettura organica:
“Ho trascorso due giorni a Taliesin con Frank Lloyd Wright, due giorni nella corrente meravigliosa, esigente e generosa, tersa e riposante. Siamo diventati amici immediatamente, ammaliati dallo spazio, muovendo le mani uno verso l’altro nello spazio. Lo stesso cammino, lo stesso traguardo, la stessa vita, credo… Eravamo a Taliesin, in alto sulla collina…
“Wright dice che l’architettura del futuro sarà, per la prima volta nella storia, totalmente architettura, spazio in se stesso, senza modelli
precostituiti, movimento in tre e quattro dimensioni… Una joie de vivre espressa nello spazio… Questo è il suo genio. E nessun altro si avvicina a lui”. Questo era il 5 novembre 1924, oltre settanta anni fa. E suona come se fosse dopodomani.
Intervento al simposio “Frank Lloyd Wright: Beyond conventional boundaries” nell’ambito della mostra su Wright organizzata dal Museum of Modern Art di New York.
Frank Lloyd Wright, l’Europa e oltre: il caso Italia.
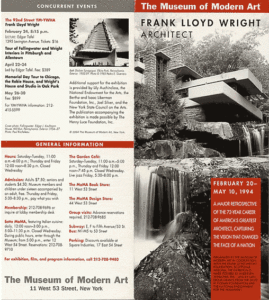 Poco prima che la American Academy di Roma decidesse che non lo poteva più tenere qui, negli Stati Uniti (parlo ovviamente del Rinascimento italiano) e che andava rispedito là da dove era venuto, nella Penisola abbiamo goduto di una breve, splendida, stagione di vera cultura architettonica.
Poco prima che la American Academy di Roma decidesse che non lo poteva più tenere qui, negli Stati Uniti (parlo ovviamente del Rinascimento italiano) e che andava rispedito là da dove era venuto, nella Penisola abbiamo goduto di una breve, splendida, stagione di vera cultura architettonica.
Stagione dominata da Frank Lloyd Wright, il genio del XXI secolo. E quando, nel 1951, venne in Italia per ricevere la cittadinanza onoraria di Firenze a Palazzo Vecchio e la laurea honoris causa a Palazzo Ducale di Venezia, ci sembrò di raggiungere l’acme di un itinerario sublime nello spazio. Eravamo euforici, pieni di gioia e di entusiasmo, e non avremmo mai potuto sospettare quello che ci aspettava col ritorno del falso Rinascimento, filtrato dalle Accademie Beaux-Arts francesi e americane, e con la successiva esplosione del più stupido degli eclettismi che prese il nome di Post-Modern.
La mia storia comincia a Torino il 21 gennaio del 1935. Un grande critico dell’architettura ancora pressoché sconosciuto negli Stati Uniti, Edoardo Persico, tenne una conferenza dal titolo “Profezia dell’Architettura”. Si era in pieno fascismo e Persico, naturalmente, era un antifascista convinto. Era solito leggere l’architettura come un termometro del grado di civiltà o inciviltà di un Paese. Parlò della visione di Wright come della radice stessa del movimento moderno e come incarnazione unica della disperata ricerca di libertà, individualità, e del diritto alla diversità della società contemporanea.
Così il maestro di Taliesin divenne un riferimento nella lotta contro la dittatura. E questo non solo in Italia, ma anche per esempio nella Graduate School of Design dell’Università di Harvard, dove nel 1941 un gruppo di studenti, per la maggior parte stranieri, pubblicò un pamphlet in cui si celebrava la statura di Wright contro gli insegnamenti scettici di Walter Gropius.
E di fatto, fu grazie al pensiero e all’esortazione di Persico che l’Italia fascista realizzò tre capolavori di architettura anti-fascista: la Casa del Fascio di Giuseppe Terragni a Como, la magnifica stazione di Giovanni Michelucci e del suo gruppo a Firenze, e Sabaudia, la città democratica a scala umana, progettata da Luigi Piccinato e dal suo gruppo. Con ciò non voglio affermare che queste opere siano state ispirate direttamente da Wright, no, ma che fu possibile realizzarle perché in Italia si respirava un’atmosfera rivoluzionaria fomentata da Edoardo Persico e da Giuseppe Pagano, direttore della rivista “Casabella”, morto in un lager nazista.
Ma passiamo al 1945: il primo libro di architettura pubblicato nell’immediato dopoguerra fu “Verso un’Architettura Organica”. Mancava la carta patinata e così l’unica fotografia era quella della copertina. Si trattava di Fallingwater a Bear Run. Per mesi e mesi, gli architetti italiani vissero di quell’immagine, capace di vitalizzarli.
Nel 1945 fu fondata a Roma l’A.P.A.O. [Associazione Per un’Architettura Organica], seguita dagli avamposti di Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo. Il gruppo di Milano, pur non avendo una sede locale, era federato all’Associazione.
Tre edifici riflettono lo spirito di quel momento: il Memoriale delle Fosse Ardeatine alla periferia di Roma, in ricordo delle 335 vittime della criminalità nazista, forse il miglior monumento del suo genere a livello mondiale; l’atrio della Stazione Ferroviaria di Roma, che rischiava di concludersi con un orribile portico colonnato in stile fascista, e che riuscimmo a far sostituire con una corretta soluzione moderna; e infine, un piccolo monumento, quasi trasparente, nel cimitero di Milano, progettato dallo studio B.B.P.R.
Erano gli anni della ricostruzione del dopoguerra, e dei conflitti su come gestirla. Noi, architetti organici e wrightiani, non vincemmo. Nel 1946 fui invitato a tenere il discorso di apertura al primo congresso dell’Istituto Americano di Urbanistica [A.T.I.], e scelsi un tema polemico: “Urbanistica come strumento di una politica estera americana”. Si trattava di un problema urgente. Le autorità americane in Italia si erano comportate in modo tale da danneggiare gli sforzi tesi al rinnovamento democratico del paese. Nel Sud, in particolare, avevano coordinato le loro iniziative con le istituzioni ufficiali del Governo italiano, il cui apparato burocratico era ancora quello fascista. E, sulla questione dell’Ambasciata Americana a Roma, avevano offerto uno scandaloso esempio di atteggiamento anti-culturale: invece di realizzare un coraggioso edificio moderno, per esempio progettato da Frank Lloyd Wright, avevano comprato un palazzo reale a via Veneto, rovinandolo poi, per renderlo funzionale.
Insomma, alla fine dei conti, ne uscimmo sconfitti. Ma quando combatti senza quartiere, senza una seconda linea di difesa, non sei mai del tutto sconfitto. In quegli anni, non solo abbiamo realizzato un buon numero di edifici concepiti secondo lo spirito organico ma soprattutto, e questo è d’importanza cruciale, programmi urbanistici e un nuovo approccio organico informò gli insediamenti rurali (come La Martella presso Matera). Esso penetrò persino nell’architettura industriale, come la fabbrica Olivetti a Pozzuoli, vicino Napoli: l’autore era un ingegnere, associato per un breve periodo a Bernard Rudolfsky, non un architetto e, ancor meno, un professore di progettazione. Amava Wright e plasmò una fabbrica, forse unica, dove l’industria e la natura si sarebbero incontrate.
Ma veniamo al favoloso 1951. Una splendida mostra delle opere di Wright fu organizzata a Palazzo Strozzi, a Firenze, da Oscar Stonorov, l’architetto di Philadelphia del sindacato dei lavoratori CIO, e dallo storico dell’arte Carlo Ludovico Ragghianti, un leggendario capo anti-fascista che nel 1944, attraversando di notte la galleria superiore di Ponte Vecchio, minato dai tedeschi, aveva garantito il contatto tra gli Alleati, fermi dall’altra parte dell’Arno, e i partigiani che erano all’interno della città.
La mostra del 1951 a Palazzo Strozzi non fu così grande ed esaustiva come quella del 1994 al MOMA, ma il suo fascino non era inferiore. Non era solo l’Italia, ma l’Europa intera, a riconoscere la grandezza incommensurabile di Wright; era il vecchio mondo che ringraziava il nuovo per la sua inaudita creatività. Con un enorme plastico di Broadacre City al centro e le gigantografie che occupavano intere pareti si aveva l’impressione di trovarsi all’interno degli edifici e di muoversi fluidamente attraverso i loro spazi. Quando Wright, poche ore dopo il suo arrivo a Firenze, visitò la mostra e suggerì alcune piccole variazioni, Oscar Stonorov gli disse gentilmente ma con fermezza che niente sarebbe stato modificato perché quella era stata concepita come la sua prima mostra postuma, con il cadavere ancora in vita.
Il mattino seguente, il conte Carlo Sforza, uno dei capi anti-fascisti rifugiatosi negli Stati Uniti durante la guerra, e in seguito Ministro per gli Affari Esteri del governo democratico, conferì la cittadinanza onoraria al maestro. Quando i trombettieri dei Medici diedero fiato ai loro strumenti, la figlia di Wright Iovanna svenne. Vorrei che foste stati lì. Non sarebbe potuto accadere in nessun’altra parte del globo. A Palazzo Vecchio, capolavoro dell’architettura medievale, in un’immensa sala tappezzata da pitture manieriste, l’Italia celebrava una delle più grandi, se non la più grande, personalità della storia dell’architettura.
Sono stato con lui dal mattino presto fino a sera tarda. Non una parola sui mesi passati a Fiesole nel 1910, non un commento sulla cupola di Brunelleschi nel Duomo, o sulla cappella di Michelangelo a San Lorenzo. Lo interessavano solo le vedute della città dalla cima della torre, alta 94 metri, progettata nel XIV secolo da Arnolfo di Cambio.
Subito dopo, Venezia, in un clima decisamente diverso. In realtà a Firenze, eccettuate alcune centinaia di persone venute da ogni parte della penisola, nessuno aveva dato importanza a Wright. Ma a Venezia il maestro di Taliesin era un mito popolare perché la facoltà di architettura, dal preside Giuseppe Samonà a Carlo Scarpa, professore di progettazione, al giovane insegnante di storia dell’architettura, era tutta costituita di appassionati ammiratori di Wright. Quindi, mentre girava per le calli o attraversava le piazzette o si spostava in gondola, Wright veniva riconosciuto da veneziani di tutte le classi sociali che lo salutavano e lo applaudivano. Sorpreso e felice per un’accoglienza mai ricevuta prima, Wright l’apprezzò molto più della solenne cerimonia a Palazzo Ducale, cerimonia in cui io lessi le motivazioni della laurea honoris causa.
Altri tre episodi del viaggio a Venezia. A Torcello c’è un piccolo ponte senza parapetti proprio di fronte alla basilica; Wright ci salì da solo e, malgrado il rischio, danzò a lungo in maniera deliziosa. Poi andammo a Murano a visitare la fabbrica del vetro. Nel vestibolo era in mostra una raccolta di oggetti iniziata molti anni fa. Wright si guardò intorno distrattamente, poi disse che voleva comprare questo, questo, e quello, cinque o sei pezzi. È da non crederci, ma erano tutti stati disegnati molto tempo prima da Carlo Scarpa.
A Venezia Wright scoprì il messaggio del barocco. Avevo scelto per lui una stanza all’Hotel Gritti, proprio di fronte a Santa Maria della Salute, di Baldassarre Longhena. Fu stupefatto dall’ottagono, dalla corona di volute esplosive, in particolar modo, dalle due cupole. Le sue mani seguirono lentamente i profili, dalla cima alla laguna. Per la prima volta afferrò quello che aveva rifiutato a priori, senza conoscerlo.
Alla fine giungemmo a Roma. Nessun impegno ufficiale, in pratica niente da fare. Olgivanna, sua moglie, decise di visitare il Vaticano. Lui riteneva di non doverlo fare. Dunque eravamo liberi. Passammo la giornata prima nello studio del pittore-scrittore Carlo Levi, che gli fece un ritratto, poi pranzando ottimamente al Gianicolo, ma lontani dall’American Academy, con lo storico dell’arte bizantina Sergio Bettini. Il resto del pomeriggio ce ne andammo in giro per Roma, in modo che potesse incontrare l’architetto che io amo di più dopo Wright, il maestro del barocco Francesco Borromini.
Questa relazione su Wright e l’Italia potrebbe essere molto più ricca. Per la famiglia di uno dei suoi allievi, morto a New York in un incidente automobilistico, aveva progettato il Masieri Memorial sul Canal Grande. Per anni abbiamo lottato perché fosse costruito, ma abbiamo perso quella battaglia, come anche quella per il leggiadro ospedale di Le Corbusier, e per la Biennale di Louis Khan. Gli anni Sessanta e Settanta, come ricorderete, hanno assistito al processo contro il movimento moderno deliberatamente confuso con il suo opposto, vale a dire l’International Style. I critici che avevano sostenuto l’International Style contro Wright, accusandolo di essere romantico, sognatore, utopista, cominciarono ad attaccare l’International Style con gli stessi argomenti usati da Wright per decenni, senza che ciò, tuttavia, generasse un maggior riconoscimento della creatività di Wright.
Poi è stata la volta degli anni Ottanta, Philip Johnson e Michael Graves, Aldo Rossi e Ricardo Bofill, ovvero la nausea post-moderna, finita solo nel 1988 con la mostra “Deconstructivist Architecture” al MOMA.
Senza dubbio, la vergogna neo-accademica e post-modernista ha toccato anche l’Italia, ma la reazione organica, wrightiana, è stata decisiva. Per quanto ne so non c’è stato nessun Istituto di Architettura come l’In/Arch in Italia, non c’è stato nessun mensile come “L’architettura-cronache e storia”, pronti a lottare costantemente, costi quel che costi, conto il Neo-Accademismo e il Post-Modernismo. Solo in Italia, se non vado errato, la statura di Wright è apparsa nel suo splendore michelangiolesco, di cent’anni avanti rispetto all’oggi. Sappiamo che dovremo lavorare duro e con entusiasmo per raggiungere, tra cento anni, l’Architettura come Spazio, creata da Wright.
Per concludere questa relazione menzionerò altre due cose; una di importanza minore, relativa ai mobili, e un’altra, d’importanza cruciale per la teoria dell’architettura.
Il fatto che i mobili di Wright vengano prodotti in Italia è un segno ulteriore del suo duraturo, intrinseco radicamento in un terreno umanistico. Qui ha prodotto un poeta, Carlo Scarpa, indietro rispetto a Wright non di un secolo, come la maggior parte di noi, non di mezzo secolo come i decostruttivisti, ma forse solo di venti o trenta anni.
A livello teoretico, Wright ha colto il significato e ha sviluppato tutti gli aspetti dell’architettura moderna. In Italia, per combattere il linguaggio classico dell’architettura, è stato codificato un linguaggio anticlassico, basato su sette invarianti,o principi, o anti-regole:
1. Elenco dei contenuti e delle funzioni, derivato da William Morris e dal movimento Arts and Crafts, al quale Wright ha aderito in chiave della macchina.
2. Asimmetria e dissonanza. Invero il maestro di Taliesin è l’Arnold Schönberg dell’architettura.
3. Tridimensionalità antiprospettica, intesa a rifiutare l’edificio come scatola, osservato da un punto di vista statico rinascimentale.
4. Scomposizione quadrimensionale. Wright è il padre del movimento olandese De Stijl.
5. Strutture in aggetto, a guscio e a membrana, ovvero la fine dello scisma tra ingegneria e architettura.
6. Spazi vivi, dinamici, fluidi: l’essenza stessa dell’identità wrightiana.
7. Continuità tra interno e esterno, edificio, paesaggio e tessuto urbano.
Sette invarianti, tutte dominate da Wright. Nessun architetto è mai stato altrettanto potente e sublime.
[il testo originale è pubblicato in Frank Lloyd Wright. Europe and Beyond, a cura di A. Alofsin, Berkeley- Los Angeles – London, 1999]
Rifondazione del Partito d'Azione.
Per la ricostruzione del Partito d’Azione
Roma, 7 dicembre 1997
 Alle quattro di mattina di martedì 21 ottobre del ’47, dopo una drammatica notte spesa nel sotterraneo del Lungotevere ove si era tenuto l’ultimo comitato centrale del partito, attraversavo Ponte Garibaldi diretto verso l’Argentina. Ero disperato.
Alle quattro di mattina di martedì 21 ottobre del ’47, dopo una drammatica notte spesa nel sotterraneo del Lungotevere ove si era tenuto l’ultimo comitato centrale del partito, attraversavo Ponte Garibaldi diretto verso l’Argentina. Ero disperato.
Nessuno aveva propugnato in modo convincente l’autonomia del PdA; la discussione verteva sul modo di sopprimerlo. Riccardo Lombardi aveva preparato una dichiarazione fiera ed energica, drasticamente critica dell’ideologia e della politica socialista. Voleva entrare nel PSI a testa alta. Ma i suoi amici tentavano di evirare, frase per frase, il contenuto eretico della dichiarazione, ragionando che, per confluire nel PSI, era inopportuno apostrofarlo. Lombardi s’infuriò, lasciò la sala indignato, gridando: “Entrate voi!
Io resto fuori!”. Fu risucchiato e, alla fine, si pervenne a un compromesso onorevole.
Traversai Ponte Garibaldi, disperato. Lo confesso, anche perché non mi è più capitato: piangevo disperatamente. Il mio partito annientato, Carlo Rosselli era stato assassinato per la seconda volta, crollava la prospettiva di un’Italia moderna, post-fascista. Tornavamo al pre-fascismo, ai partiti sconfitti, all’inerzia corrotta. Nuova amputazione.
Prima, gli amici, i fratelli della cospirazione antifascista, militanti, quasi tutti, nel Partito Comunista. Adesso, quelli del Partito d’Azione dispersi tra socialisti e repubblicani.
Con le uniche eccezioni dell’esaltante parentesi di “Unità Popolare” del ’53 e dei vari coinvolgimenti nelle lotte radicali, da quella mattina del 21 ottobre 1947 sono stato sempre solo e isolato. Tuttavia, canta Georges Moustaki: «Je ne suis jamais seul avec ma solitude (nella fattispecie, con il PdA), et si je préfère l’amour d’une autre courtisane (PSI, PSDI, PRI ecc,), elle (il PdA) sera à mon dernier jour ma dernière compagne».
Da allora infatti tutto il mio lavoro è stato condotto nello spirito del Partito d’Azione, riflesso del pensiero liberal-socialista di Rosselli nello specifico urbanistico e architettonico. I martiri di “Giustizia e Libertà”, del Partito d’Azione, della Resistenza fondono con i sei milioni dei campi di sterminio.
Sono solitario del PdA, sono ebreo – per loro. Aggiungo: credo nello spazio come protagonista dell’architettura, come fonte di gioia e matrice di comportamenti individuali e sociali alternativi – per loro. Odio l’accademia, il classicismo, la simmetria, i rapporti proporzionali, le cadenze armoniche, gli apparati scenografici e monumentali, la retorica e lo spreco degli “ordini”, i vincoli prospettici, gli impianti edilizi statici, non dinamizzati e quindi non plasmati in chiave di fruizione – per loro. Di più – per loro – apprezzo e subisco richiami contraddittori: l’impegno nella programmazione economica e urbanistica dall’alto e, insieme, l’attrazione per l’advocacy planning, per la pianificazione dal basso, alla Danilo Dolci. Amo la modanatura sottile e tremula, e il kitsch scatenato; Schönberg e Moustaki. Detesto il conformismo, ma non i rituali. È cristallino, proprio nella latitudine delle sue dissonanze: sono sempre stato, sono e sarò sempre del Partito d’Azione.
Del resto, non sono affatto originale. Vittorio Foa racconta che, nel 1980, quando un suo volume di scritti fu presentato all’Università di Catania, il preside di Lettere gli pose una domanda: «Io credo che tutto questo lavoro sia fortemente ispirato a una tradizione culturale preziosa, quella azionista; tu cosa ne dici?» e Vittorio: «Io risposi semplicemente: Sì».
Ma fu Riccardo Lombardi a dire: «Quando si è stati in “Giustizia e Libertà” e nel Partito d’Azione, si porta per tutta la vita il marchio di questa appartenenza. Noi siamo come i cattolici che, quando hanno ricevuto uno solo dei sacramenti, non lo perdono più, anche in caso di apostasia. Gli azionisti che sono usciti dal partito portano e porteranno quest’abito mentale ovunque essi siano. E molti compagni che si sono allontanati da noi, ovunque vadano, se all’inizio sono stati veramente azionisti, rimarranno tali per sempre».
Per cinquant’anni, almeno una volta al mese, abbiamo ipotizzato di ricostituire il PdA. Specie in circostanze eccezionali, quali furono nel 1953 la battaglia contro la «legge truffa» o, più tardi, quella radicale per il divorzio. Non riuscirò mai a capire perché abbiamo aspettato mezzo secolo per ricostituirlo. Ma è certo che solo oggi, con il centro-sinistra al potere, vibra e palpita un contesto degno di un atto rischioso. E noi ci buttiamo con ottimismo, sicuri che i conti tornino.
Ci buttiamo per due fondamentali motivi: a) per un risarcimento storico, b) per una politica mossa dalla cultura.
Risarcimento storico. Io ricordo l’ostracismo dato al Partito d’Azione sul fronte dell’organizzazione sindacale. Prima ancora della liberazione della capitale, a Napoli, Dino Gentili aveva elaborato un nostro contributo originale alla Confederazione del Lavoro. Ma l’esclusione del PdA dalla costruzione della CGIL unitaria nel 1944 fu un colpo durissimo infertoci dai partiti di sinistra che optarono per un’alleanza strutturale con la Democrazia Cristiana.
E ricordo l’insofferenza, l’aria di superiorità, il disprezzo di De Gasperi e di Togliatti per il governo Parri, il cinismo e l’indifferenza di tutte le altre forze politiche di centro e di sinistra. Del resto, Carlo Levi, in “L’orologio”, ha descritto la seduta surrealista che ebbe luogo al Viminale. Tra il cinico vicino di sinistra, che faceva, come era suo dovere, gesti di assenso, perché si deve applaudire alla virtù, e il vicino di destra, “quel vecchio e navigato serpente”, Ferruccio Parri “pareva impastato della materia impalpabile del ricordo, costruito col pallido colore dei morti, con la spettrale sostanza dei morti, con la dolente immagine dei giovani morti, dei fucilati, degli impiccati, dei torturati, con le lacrime e i freddi sudori dei feriti, dei rantolanti, degli angosciati, dei malati, degli orfani, nelle città e sulle campagne. Il suo corpo stesso pareva fatto di questi dolori, essi scorrevano nel suo sangue; la sua pelle aveva il colore delle ossa biancheggianti nei campi. Dicevano che non fosse un uomo politico, che non rappresentasse nessuna forza reale, che non sapesse destreggiarsi nel gioco avviluppato degli interessi, che non fosse altro che un personaggio simbolico e neutrale. Ma egli rappresentava, o piuttosto ne era costruito, qualche cosa che non è negli schemi politici; una cosa nascosta e senza nome, uguale in tutti e indeterminata, ripetuta milioni di volte in milioni di modi eternamente uguali: i morti freddi sotto la terra, la sofferenza di ogni giorno e il coraggio che la nasconde”.
Levi conclude: «La diagnosi era dura ed esatta: ritorno di un vecchio mondo, tentativo di annullare tutto quello che era stato fatto». Non si voleva un partito nuovo, di sinistra ma pregno di idealità liberali. Il liberal-socialismo veniva irriso. L’idea delle due economie o quella della repubblica presidenziale, formulate da alcuni azionisti, erano schernite. Principalmente era ritenuto intollerabile il non-classicismo del PdA, antidottrinario e aperto al pluralismo. Non corrispondevamo alle regole del pre-fascismo; dovevamo essere eliminati.
Oggi, dopo cinquant’anni, è tutto diverso. Alcuni confrontano D’Alema a La Malfa, il che è plausibile evidenziando che Ugo la Malfa era meglio di D’Alema. Ciampi ricorda Calogero e parla dell’«etica dell’azionismo». C’è persino chi rievoca l’«eleganza trasandata» degli azionisti, che anticipa di mezzo secolo l’attuale moda maschile. Insomma, infrante l’ideologia di sinistra e quella di destra, crollati i miti sia della statizzazione che della privatizzazione a oltranza, riesumato il liberal-socialismo in libri, saggi, convegni, il Partito d’Azione torna all’ordine del giorno, rioccupa la scena decretando un dovuto, lungamente atteso risarcimento storico.
Ben più complesso è il tema del rapporto politica-cultura. Ne accennerò in modo telegrafico. Tutti i partiti, persino quello radicale, considerano strumentalmente la cultura.
Cinquant’anni fa, intellettuali come Mario Alicata, Aldo Natoli, Paolo Bufalini, dovevano smettere di essere intellettuali per dedicarsi totalmente al Partito Comunista. Più tardi, e oggi, il vincolo è meno costrittivo, vige un’estraneità tra politica e cultura, con la duplice conseguenza che la politica è largamente incolta e la cultura è largamente disimpegnata. Il governo di centro-sinistra non ha ancora saputo afferrare il problema, s’illude di detenere il potere culturale insieme a quello politico. Ciò avviene anche per molti sindaci, a cominciare da Francesco Rutelli, la cui allergia all’urbanistica rischia di mandare a rotoli la capitale nel giro di 24 mesi.
È compito urgente del nuovo Partito d’Azione riformulare in modo originale, creativo, lo scambio dinamico tra cultura e politica. Se non lo facciamo noi, nessuno lo farà.
Io parlo a voi, ma penso ad altri. Questa anonima sala la vedo animata e agitata da colossi simili agli “schiavi” michelangioleschi. Rappresentano “i cavalieri dell’umanità”:
Gaetano Salvemini, Carlo Rosselli, Ferruccio Parri, Emilio Lussu, Ugo La Malfa, Piero Calamandrei, Riccardo Lombardi, Carlo Ludovico Ragghianti, Enzo Sereni, Francesca Fancello, Tristano Codignola, Guido Calogero, Adolfo Omodeo, Carlo Levi, Guido Dorso, Leone Ginzburg, e tanti altri più piccoli come, ad esempio, Sergio Baldacci, Bruno Pierleoni, operaio della Galilei a Firenze, emigrato in Francia, poi in Messico, che ci raggiunse a Londra insieme a Leo Valiani, quando tornammo volontari in Europa, Alberto Cianca, Alberto Tarchiani, Aldo Garosci e io, per combattere il nazi-fascismo dall’interno. E tanti altri che non sono stati iscritti al Partito d’Azione perché ancora non c’era, ma furono giellisti, azionisti ante-litteram, e ne citerò uno solo: Mario Angeloni, il primo dell’eroico, leggendario gruppo Rosselli a cadere in Catalogna.
Dieci anni fa, Leo Valiani chiudeva il convegno su “L’azionismo nella storia d’Italia 1946-53”, organizzato dalla società operaia di Porto San Giorgio, l’unica cittadina ad essere amministrata, subito dopo la guerra, da uomini del partito d’Azione. «Dobbiamo tener duro», disse Valiani, «questo è il senso, il succo dell’insegnamento di Gaetano Salvemini, del Partito d’Azione, finché non potrà esserci un superamento non dico dei blocchi, ma del pericolo di un conflitto tra i blocchi, tale che veramente si possa riprendere la marcia in avanti della politica democratica europea… Rosselli scriveva nel 1929, nel 1986 siamo più vicini a vedere la realizzazione della sua previsione. Ma la vedremo per intero? Ci sono vischiosità, ostacoli, avversari, nemici da combattere», ma non c’è più Stalin, non c’è più Pio XII. E ora possiamo aggiungere: non c’è più Andreotti, non c’è più Craxi.
E concludo. Abbiamo tenuto duro, perciò siamo ancor più vicini alla profezia di Carlo Rosselli. Quindi possiamo ripetere quanto gridò Piero Calamandrei, abbandonando cinquant’anni fa il comitato centrale. Gridò: «Viva il Partito d’Azione!».
-
“Architettura concetti di una controstoria”, 1994.
-
“Architettura della modernità”, 1994.
-
“Controstoria dell’architettura in Italia: paesaggi e città”, 1995.
-
“Controstoria dell’architettura in Italia: Preistoria – Alto Medioevo”, 1995.
-
“Controstoria dell’architettura in Italia: Romanico – Gotico”, 1995.
-
“Controstoria dell’architettura in Italia: Rinascimento – Mnierismo”, 1995.
-
“Controstoria dell’architettura in Italia: Barocco – Illuminismo”, 1995
"Controstoria dell'architettura in Italia: Ottocento -Novecento", 1996. "Dialetti architettonici", 1996.
1995
Contro Largo Bottai
Sit-in anti Rutelli per Bottai
“Corriere della sera”, 18 settembre 1995
 Pressioni, proteste, appelli e ora anche sit-in e annunci a pagamento sui quotidiani: tutto contro il Sindaco progressista che ha voluto intitolare uno slargo al gerarca fascista Giuseppe Bottai. E adesso anche se la decisione è stata già presa dalla giunta comunale, Francesco Rutelli tenta di ricucire lo strappo con una serie di incontri riservati. Prima si è visto con i consiglieri della maggioranza di centro sinistra, che oggi dovrà comunque affrontare in consiglio, e poi con un pezzo importante della comunità ebraica, che non ha un buon ricordo del Ministro dell’Educazione Nazionale corresponsabile dell’applicazione delle leggi razziali del ’38. Per questo, ieri sera, il primo cittadino ha varcato il portone dell’Istituto Pitigliani di Trastevere, per tentare una mediazione con i membri del “Benè Berith”, un antico sodalizio internazionale. E al termine della riunione con gli ebrei, forse una svolta. Rutelli promette: «Ci penserò molto attentamente».
Pressioni, proteste, appelli e ora anche sit-in e annunci a pagamento sui quotidiani: tutto contro il Sindaco progressista che ha voluto intitolare uno slargo al gerarca fascista Giuseppe Bottai. E adesso anche se la decisione è stata già presa dalla giunta comunale, Francesco Rutelli tenta di ricucire lo strappo con una serie di incontri riservati. Prima si è visto con i consiglieri della maggioranza di centro sinistra, che oggi dovrà comunque affrontare in consiglio, e poi con un pezzo importante della comunità ebraica, che non ha un buon ricordo del Ministro dell’Educazione Nazionale corresponsabile dell’applicazione delle leggi razziali del ’38. Per questo, ieri sera, il primo cittadino ha varcato il portone dell’Istituto Pitigliani di Trastevere, per tentare una mediazione con i membri del “Benè Berith”, un antico sodalizio internazionale. E al termine della riunione con gli ebrei, forse una svolta. Rutelli promette: «Ci penserò molto attentamente».
Tra gli associati al “Benè Berith” c’è anche l’architetto Bruno Zevi, che ieri mattina ha partecipato assieme ad altre duecento persone al sit-in di protesta organizzato davanti alla Galleria d’arte moderna di Valle Giulia: lì, nei pressi dell’esedra che presto si chiamerà «Largo Giuseppe Bottai», i consiglieri pidiessini Victor Magiar ed Enzo Foschi hanno apposto una targa con su scritto «Largo delle vittime del razzismo In Italia 1938-1995». Poi Zevi ha
usato, a titolo personale parole di fuoco contro il Sindaco: «Con questo gesto lui sputtana Roma in tutto il mondo. È bello, simpatico e sorridente, ma è un nanerottolo rispetto ai suoi colleghi Cacciari e Bassolino. Io dico che qui a Roma dovremmo trovarci un nuovo leader della sinistra». Ieri si è anche riunito il Consiglio delle comunità ebraiche italiane che ha stilato un documento al vetriolo contro il Sindaco: «Il Consiglio ricorda che singoli meriti familiari (Rutelli si era difeso dicendo che sua madre e suo nonno hanno salvato la vita a un ragazzo ebreo durante l’occupazione tedesca di Roma, ndr) non consentono ad alcuno di educare i giovani di oggi all’assoluzione del razzismo di ieri.
Il Sindaco? Bravo, anzi, venduto
Il deluso: «Ora la città deve trovare un nuovo leader della sinistra».
Deluso è dire poco, l’urbanista-architetto Bruno Zevi sprizza amarezza da tutti i pori. «Francesco Rutelli è un mio fraterno amico ma ha avuto un colpo di follia. Io non so cosa gli è preso con questa via a Bottai. So solo che sta sputtanando Roma in tutto il mondo. Perché la comunità ebraica è in Italia, ma anche negli Stati Uniti, in Francia, in Inghilterra. Ovunque. Avrà anche fatto un calcolo politico. Ma ha sbagliato clamorosamente».
Zevi non ha mezze misure e critica anche il Pds. «Ci dicono che non lo dobbiamo attaccare altrimenti che fine si fa? È una follia. Ci rendiamo conto che gli assessori di sinistra non gli hanno votato contro altrimenti andavano a casa? È una logica da piccoli politici di provincia attaccati alla poltrona. E Roma ha un problema in più: sostituire Rutelli. La sinistra ora dovrà trovare un altro leader per guidare la capitale».
Pubblicazione di "Controstoria dell'architettura in Italia".
1996
Intervento “La chiesa del 2000” all’Università Lateranense.
La Chiesa del 2000
Università Lateranense, Roma, 22 ottobre 1996
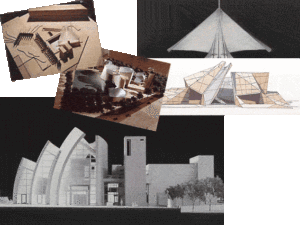 Not quite architecture, “non proprio architettura”, come dicono gli inglesi; oppure, come vaticinava Edoardo Persico all’acme della sua ispirazione, “oltre l’architettura”. Ecco: in un punto imprecisato tra “non proprio architettura” e “oltre l’architettura” sta il taglio di questo mio brevissimo intervento che molti, ne sono certo, giudicheranno almeno in parte fuori tema.
Not quite architecture, “non proprio architettura”, come dicono gli inglesi; oppure, come vaticinava Edoardo Persico all’acme della sua ispirazione, “oltre l’architettura”. Ecco: in un punto imprecisato tra “non proprio architettura” e “oltre l’architettura” sta il taglio di questo mio brevissimo intervento che molti, ne sono certo, giudicheranno almeno in parte fuori tema.
Mi accingo a commentare non il progetto vincitore, testè esaustivamente illustrato, ma il contesto culturale in cui è nato, il concorso
internazionale, il suo messaggio che trascende largamente la cronaca.
Tento di rievocarne il clima. Questa nostra città si trascina in un quotidiano dominato da un’arsura di significati, disilluso, smarrito e disorientato dal crollo delle ideologie, dagli scandali di Tangentopoli, da un doppiogiochismo mercificato, soprattutto dalla mancanza di un’immagine del suo futuro, di una prospettiva etica e creativa.
Vige uno stato di confusione e di allarme, che gli architetti registrano in modo bruciante, confrontando quanto accade negli altri paesi, in Francia, in Gran Bretagna, in Germania, ma anche in Spagna e Portogallo, con l’inerzia, la stasi, l’insensibilità della classe politica italiana per l’ambiente e per l’arte.
In questo quadro stagnante s’innesta l’iniziativa del Vicariato:
un concorso ad inviti per una chiesa da erigersi nell’ambito della più squallida e degradata periferia. La scelta del luogo è in sé sintomatica. Si rifiutano le alternative del centro storico e della fascia edilizia che lo circonda, ma anche quelle delle borgate e di siti lontani.
L’opzione è incisiva, mordente, coinvolta nel problema del riscatto dell’area metropolitana della capitale.
Vengono selezionati sei architetti, tra i nomi più prestigiosi dello scenario internazionale: uno spagnolo, Calatrava; un giapponese, Ando; un tedesco, Behnish; e tre nord-americani, Eisenman, Gehry e Meier.
Certo, sostituzioni erano possibili: basti citare Utzon, Johansen, Rogers, Foster. Ma quello che va sottolineato è la novità di questa impostazione che include tra gli invitati architetti ebrei.
Non credo che nessuno di noi se ne renda conto. Un fenomeno del genere sarebbe stato inconcepibile fino a qualche anno fa, quando si verificò un evento di straordinaria portata, che riempì ovviamente le prime pagine di tutti i giornali e l’informazione radiotelevisiva, eppure non credo che sia calato nelle nostre coscienze al punto da avere un transfer nel campo architettonico. E qui vado consapevolmente fuori tema.
Voi ricorderete che, per secoli e millenni, gli ebrei sono stati definiti, nel caso migliore, “perfidi”. Erano accusati di assassinio, di aver procurato la morte del simbolo dell’umanità, del figlio dell’Uomo, del figlio di Dio. L’infamante accusa di popolo “deicida” ha accompagnato la storia ebraica per oltre duemila anni, legittimando qualsiasi persecuzione, pogrom ed eccidi, emarginazione ed esilii forzati. Fino al giorno in cui un pontefice, mosso da una visione universalistica senza precedenti, decise di compiere un atto imprevedibile, inaudito, di rilievo epocale. Decise di far telefonare al rabbino capo della comunità ebraica, e gli chiese di essere ricevuto in sinagoga, per riprendere contatto, disse, con i suoi “fratelli maggiori”. Il rabbino rispose: “sia il benvenuto!”.
Io stento ancora a crederci, ma questo è storicamente avvenuto. Cadute le condanne di deicidio e di perfidia, dopo duemila anni di spesso feroce antisemitismo, la Chiesa segna una svolta radicale che, a distanza di un decennio, rende possibile l’invito ad alcuni ebrei ad ideare una cattedrale per l’area metropolitana di Roma.
È evidente, a questo punto, il significato del concorso: si tratta di riconfigurare e riplasmare l’idea della chiesa. Non lo si proclama per giustificabile prudenza, ma s’intende voltare pagina. Qui termina un itinerario dell’architettura cristiana e ne comincia un altro, di cui il concorso è insieme testimonianza e profezia.
Quanto ci volle e quanto costò l’emergere della prima architettura cristiana? Le opinioni variano, ma sostanzialmente da otto a dieci secoli. Se consideriamo come inizio il tempio pagano sotterraneo di Porta Maggiore e come esito Sant’Ambrogio di Milano, ecco un arco di secoli durante il quale si manifesta un drammatico conflitto tra due concezioni architettoniche, tra due cristianesimi: quello ufficiale, burocratico, monumentale che si dà carico dell’eredità del mondo romano imperiale, e quello antitetico, spoglio, non-violento, linguisticamente di “grado zero”, che va dalle catacombe al Sacro Speco di Subiaco, proponendo una non-architettura, una visione non-spaziale ma solo temporale, che scalza e recide alle radici le scenografie classiche sovrastanti.
Nel romanzo “Il ribelle” Carlo Cassola ha descritto le due anime contrastanti dell’etica cristiana, la sua bipolarità linguistica, un pendolarismo incessante tra metafisica bizantina e riappropriazioni materiche, da Tuscania a Subiaco.
Il protagonista del romanzo, Severiano, è un sessantottino del IV secolo, che lotta disperatamente contro il “compromesso storico” tra cristianesimo e impero. Teme che la cristianizzazione del mondo si riduca a un mero cambiamento di facciata, che l’abbraccio della romanità sia mortale per la nuova religione, che lo sfavillare di marmi ed ori dei templi pagani vinca sulla luce delle fiaccole nelle catacombe, che è la luce dell’anima.
Ebbene, c’è da chiedersi: se tale è stato il tormento per generare la prima architettura cristiana, quali fatiche e sofferenze creative saranno necessarie per dare un volto espressivo alla seconda, introdotta dal concorso vinto da Richard Meier?
E, per concludere, alcuni appunti sul progetto vincitore. Ho già avuto occasione, qualche anno fa, di parlare dell’architettura di Meier.
L’ho confrontata con quella del Tempio di Bacco a Baalbek: furibondo e profanatore anticlassicismo, controllato però da un apparato che mantiene ancora aspetti tradizionali. Il progetto della Chiesa del Duemila, mi pare, conferma questa poetica, e la spinge in avanti, al limite di rottura. Mentre un Gehry, un Libeskind, un Hecker frantumano il linguaggio a priori, per svincolarsi da ogni subordinazione al passato, Meier ha un modo quasi bramantesco di agire: arriva a San Pietro, apre il cantiere, opera per settori, si occupa di nodi, cerniere, più che della definizione globale.
L’iconografia di Meier è controllata, senza eccessi enfatici nella volumetria, nella distribuzione degli spazi e nel dosaggio delle luci.
Che “la tenda sia l’archetipo del luogo sacro” è considerato arbitrario. La relazione parla di “un recinto in parte sacro e in parte laico, per aiutare la popolazione a ri-collocarsi nel mondo”; parla di gioco e di rituali, di “movimento non legato a nessun obiettivo”.
Diversamente da quello di altri concorrenti, l’approccio di Meier è quello della massima latitudine progettuale, un gettar semi ancora esitante, in attesa che l’uno o l’altro germoglino indicando un itinerario. È il metodo “aperto” dell’architettura moderna, quello sgorgato dalla lezione di William Morris, dal canto di Horta ed Olbrich, dall’intransigenza di Loos, dal genio di Wright, dagli apporti linguistici di Le Corbusier, Mies, Mendelsohn, Scharoun, Aalto e Pietilä, Goff.
È la via maestra, difficile, in sistematica crisi esistenziale, che ogni giorno rimette in gioco sulla roulette l’intero proprio patrimonio.
Meier ha vinto giustamente il concorso, perché impersona la modernità, cioè la vocazione quotidiana di tramutare la crisi in valore.
Ho finito. Ci rivediamo tra quattro anni, per l’inaugurazione della chiesa. Saranno organizzati cortei e convogli che partiranno da vari punti di Roma in direzione di Tor Tre Teste. Se qualcuno vuol venire con me, l’appuntamento è a Campo dei Fiori, davanti alla statua di Giordano Bruno, di cui cade – coincidenza stranissima – il quarto centenario della morte. Da lì, “ove il rogo arse”, partiremo alla volta della chiesa di Meier, dove uomini di tutte le religioni e laici saranno di casa.
1997
Pubblicazione di “Storia e Controstoria dell’architettura in Italia”
“Storia e controstoria dell’architettura in Italia”
 Newton Compton, Roma,1997. Riedizione di “Architettura concetti di una controstoria”, Newton Compton, Roma 1994; “Architettura della modernità”, Newton Compton, Roma 1994; “Controstoria dell’architettura in Italia”, 7 voll., Newton Compton, Roma 1995-1996; ripubblicato come “Controstoria e storia dell’architettura”, 3 voll, Newton Compton, Roma 1998.
Newton Compton, Roma,1997. Riedizione di “Architettura concetti di una controstoria”, Newton Compton, Roma 1994; “Architettura della modernità”, Newton Compton, Roma 1994; “Controstoria dell’architettura in Italia”, 7 voll., Newton Compton, Roma 1995-1996; ripubblicato come “Controstoria e storia dell’architettura”, 3 voll, Newton Compton, Roma 1998.
Convegno di Modena. Pubblicazione di “Il manifesto di Modena”
“Il Manifesto di Modena”
 «…Eravamo in alto, sulla collina di Taliesin … Wright dice che l’architettura del futuro sarà, per la prima volta nella storia, interamente architettura, spazio in se stesso, senza modelli prescrittivi, movimento in tre e quattro dimensioni … una joie de vivre espressa nello spazio». Così scriveva Erich Mendelsohn da Chicago, il 5 novembre 1924, alla sposa Louise.
«…Eravamo in alto, sulla collina di Taliesin … Wright dice che l’architettura del futuro sarà, per la prima volta nella storia, interamente architettura, spazio in se stesso, senza modelli prescrittivi, movimento in tre e quattro dimensioni … una joie de vivre espressa nello spazio». Così scriveva Erich Mendelsohn da Chicago, il 5 novembre 1924, alla sposa Louise.
Questo convegno di Modena è stato indetto per annunciare al mondo che, dopo 73 anni, l’architettura del futuro profetizzata da Wright è divenuta l’architettura del presente. Abbiamo vinto una battaglia millenaria.
Dopo il primo “grado zero” dell’età informale delle caverne, con il suo matrimonio insuperato tra natura e spazio reificato da luci arcane, dove la vita è fasciata in un continuum che non ammette cesure tra pianciti, pareti e soffitti, come nei disegni onirici di Finsterlin; dopo il secondo “grado zero” dell’età a-spaziale, temporalizzata, tutta percorsi ipogeici, delle catacombe, che minano alle radici le tronfie scenografie marmoree dei romani; dopo il terzo “grado zero” dell’Alto Medioevo, che recupera, contro le folli ebbrezze dei rivestimenti musivi bizantini, il senso e la tattilità della materia. Non a caso, Reima Pietilä, completato nel 1968 il club studentesco Dipoli a Otaniemi, dichiarò: «Lasciamo il XX secolo e procediamo avanti, verso il X» – dopo queste tre età, siamo giunti alla stagione moderna del “grado zero” della scrittura architettonica, che non teme cedimenti, compromessi o regressi.
Ormai siamo collaudati, sappiamo cosa e come fare. Quando morì Brunelleschi, nel 1446, si celebrò la sua grandezza con un solenne e fastoso funerale, dopo il quale non solo il suo linguaggio non fu prolungato, ma i suoi edifici furono massacrati, offesi, sfigurati dai suoi stessi osannanti discepoli. Quando scomparve Michelangiolo, nel 1564, fu esaltato come genio titanico, supremo, gigantesco, ma l’accademia avvertì subito: nessuno tenti di imitarne le licenze e le eresie, era un’eccezione straordinaria che tale deve rimanere, in archivio. Quando si suicidò Borromini, nel 1667, analogo rituale: era sommo, sublime sebbene un po’ svoltato di cervello; portiamolo in trionfo e poi dimentichiamolo al più presto.
Lo stesso si è tentato di fare con Frank Lloyd Wright. In un primo tempo, l’International Style lo ha tacciato di romanticismo ottocentesco, inclinazione rurale inadatta alla civiltà industriale e di individualismo contrario allo standard collettivo; più tardi, il nauseante, lurido Post-Modern ha fatto di tutto per assimilarlo, cancellandone l’identità e la memoria.
Questa volta, però, l’esecrabile gioco non è riuscito. È bastata la presenza di cinquanta architetti e critici nel mondo, forse meno, per impedire il crimine e lo spreco inaudito.
Trentotto anni dopo il 1446, cioè nel 1484, di Brunelleschi da tempo non si parlava più. Trentotto anni dopo il 1564, cioè nel 1602, l’apporto di Michelangiolo architetto era quasi totalmente obliato. Trentotto anni dopo il 1667, cioè nel 1705, il borrominismo non esisteva neppure a livello epidermico e decorativo. Ma trentotto anni dopo il 1959, cioè nel 1997, Wright è rimasto illeso nella sua incalcolabile statura creativa, e la sua pressante ispirazione ha spinto il linguaggio architettonico anche più avanti di lui, nel senso che ha affiancato, integrato e sostenuto la sua poesia con una prosa articolata, variegata, polidirezionata, versatile.
È la prosa di Reima Pietilä, che dal centro Dipoli passa alla Residenza presidenziale di Helsinki senza alterare minimamente il suo modo di scrivere architettura. Jörn Utzon aggredisce e calamita il cielo per rovesciarlo nell’Opera House di Sidney.
Jean Renaudie, nel centro di Ivry, esclude qualsiasi ortogonalità. Günther Behnisch dalle Olimpiadi di Monaco passa all’asilo di Stoccarda. Zvi Hecker, dalle cellule di Gerusalemme alle spirali intrecciate della scuola a Berlino. Daniel Libeskind nella spezzata e nelle riseghe dell’ala ebraica del museo berlinese. Frank O. Gehry in ogni sua anomalia, e soprattutto nell’American Centre a Parigi. E altri, tra cui annoveriamo Günther Domenig, Hans Hollein, Claude Parent, Henri Ciriani, Rem Koolhaas, Kiyonori Kikutake, Gunnar Birkerts, James Wines, e altri ancora. A essi va ascritto questo grandissimo merito: hanno strutturato un linguaggio che consente lo scambio intenso e fluido tra il messaggio irripetibile del genio e gli apporti democratici e popolari.
Il tramonto del secolo assiste così al trionfo del movimento moderno e dell’architettura tout court. Il ciclo del manierismo, persistente dal 1527 a ieri sera, è finalmente esaurito. Non abbiamo più bisogno di mimare il classicismo per insultarlo e distruggerlo. Non servono più le mode pendolari tra umanesimo e romanticismo, tra regole e deroghe. Quanto è accaduto nell’ultimo decennio ha persino rovesciato la prospettiva storica. Prima, valevano le norme dottrinarie, punteggiate dalle eresie di rari, autentici spiriti creativi. Oggi, la storia ci appare innervata da gesti creativi, che rendono idoli, dogmi, canoni armonici, tabù proporzionali, vitelli d’oro simmetrici non solo obsoleti, ma anche ridicoli. Il fronte della rivoluzione, della modernità, ha prevalso.
A questo punto, scruto nel vostro e nel mio animo un’obiezione: ammesso che quanto si è detto sia vero, per quanta gente lo è? Per cinquanta architetti? Per cento? E gli altri, come possono captare, con il cervello e con lo stomaco, la scrittura di “grado zero”? Come estendere a tutti le conquiste dell’avanguardia?
Una risposta la fornisce Roland Barthes, il teorico del “grado zero”, che precisa: «Nello sforzo di liberazione dal linguaggio letterario, ecco un’altra soluzione: creare una scrittura bianca, svincolata da ogni servitù … La scrittura di grado zero è in fondo una scrittura indicativa, se si vuole amodale … Si tratta di superare la Letteratura (con la l maiuscola) affidandosi a una lingua basica … Allora, lo strumento non è più al servizio di un’ideologia … è la maniera di esistere del silenzio… Se la scrittura è veramente neutra, la Letteratura è vinta». Possiamo traslare: se la scrittura architettonica è veramente neutra, l’Architettura del potere, classica, autoritaria, accademica, postmoderna, è vinta.
Certo, gli atti di rottura linguistica, i gesti veramente eversivi si trasmettono con estrema difficoltà. Si dice che l’architettura è fruita distrattamente, ma gli architetti stessi sono disattenti, indifferenti, non si accorgono nemmeno di quel che succede, tirano a campare nell’indifferenza.
Più ancora dei committenti, i professionisti oppongono una pervicace resistenza contro ogni novità, ogni suggestione alternativa. Quanti di loro apprezzano davvero, fino in fondo, il club Dipoli di Pietilä, le case popolari prive di qualsiasi angolo retto di Renaudie, lo stupefacente progetto di estensione del Victoria & Albert Museum a Londra di Libeskind? Perché meravigliarsi che il “grado zero” della scrittura architettonica non abbia ancora varcato le barriere dell’incultura e della pseudocultura universitaria?
Gli esempi di dilapidazione culturale si accumulano. Come ricorderete, per decenni il libro più diffuso e autorevole sull’architettura moderna è stato “Space, Time and Architecture” di Giedion. Ignorava William Morris e il movimento Arts & Craft, Gaudì, Mendelsohn, Häring e tutto l’espressionismo; nella prima edizione, non nominava neppure Mies van der Rohe e Alvar Aalto. La cecità critica di Giedion ha tuttora, a distanza di oltre mezzo secolo, deleterie conseguenze. Nel giugno scorso, parlando a Parigi nella sede dell’Unesco, mi sono accorto che molti pregiudizi di Giedion persistono: ben pochi in Francia amano Gaudì, Häring, Mendelsohn e Scharoun. L’operazione auspicata da Umberto Boccioni nel 1914 – unire le forze dei cubisti francesi, degli espressionisti tedeschi e dei futuristi italiani – fallì, sì che il futurismo soffocò in un ambito provinciale, e l’espressionismo tedesco è approdato in Italia solo pochi giorni fa, con l’esposizione appena inaugurata di Palazzo Grassi a Venezia. Non c’è scampo: se si vogliono salvare i valori, come siamo riusciti a fare con Wright, bisogna proclamarli senza timidezze e senza stancarsi.
Ho accennato alle sfortune critiche di Brunelleschi, Michelangiolo e Borromini, poi a quelle di Gaudì, Mendelsohn e Scharoun. Ma qui a Modena dovete concedermi una digressione sull’eredità dilapidata di Lanfranco, il genio della cattedrale.
Ecco, siamo nel 1099, neanche un secolo dall’inizio del millennio, il cui linguaggio è stato segnato a Milano dall’impianto della basilica ambrosiana.
Lanfranco ne afferra la rivoluzionaria originalità, il modo nuovo di pensare l’architettura per quantità tridimensionali, massicce campate poggianti su pilastri compositi che sostengono archi longitudinali e trasversali, con volte a crociera cupoliformi innervate da robusti costoloni.
A contatto diretto delle ultime manifestazioni del “grado zero” altomedievale, date dal presbiterio e dall’abside, risuona, traballante ma non balbettante, la nuova lingua romanica con i suoi “pregnanti plessi di energie”, scrive Ragghianti, con la “tesa nervatura elastica della forma” carezzata da una luce proveniente solo dalla facciata. Al cospetto dell’armatura dinamica dell’organismo lombardo, Lanfranco subisce il fascino di «un’autorità senza pari, di quell’austerità vitale, erompente, che contrassegna questi uomini della prima età comunale».
Lanfranco, però, non a caso denominato mirabilis artifex e mirificus aedificator, non intende ribadire le formule milanesi. Si pone un problema linguistico di capitale portata: quello di integrare la scoperta delle campate tridimensionali con un involucro adeguato che analizzi, scomponga, ritagli, affetti il muro tradizionale, onde inverare un rapporto interno/esterno o dentro/fuori, affatto trascurato a Sant’Ambrogio. Opina Ragghianti che, allo “spirito lirico e contemplativo” di Lanfranco, Sant’Ambrogio doveva fare l’effetto di “una belva accucciata, repressa ma pronta allo scatto”, per realizzare il quale urgeva il gesto di un “estro indipendente”. Al limite, in questa fase, le crociere sono secondarie; bastano gli archi trasversali che scandiscono i ritmi di San Minato a Firenze. La sfida sostanziale della cattedrale modenese è di natura espressionista: si tratta di recuperare, elaborandola, la terza dimensione materica. Ed ecco il colpo di genio, «la cintura di arcature includenti loggette trifore praticabili, che circonda e fascia l’intero corpo inferiore dell’edificio, comprese le absidi e la facciata».
Un’ossatura, “una muscolatura plastica”, insisto, praticabile.
L’ossessivo scavo nello spessore, nella stratificazione del muro, non è mosso da mere esigenze estetiche, come accadrà nei loggiati sovrapposti dell’architettura pisana, aretina e lucchese. A Modena l’ecclesia è “munita”, non appartiene solo a Dio e al clero, si laicizza, serve alla difesa dei cittadini che possono rifugiarsi nella cattedrale, nei suoi spazi e anche nelle sue mura, trasformandone le gallerie in cammini di ronda, sorvegliando il territorio da ogni lato, con un controllo urbano a 360 gradi.
Una cattedrale democratica, funzionale anche rispetto all’al di qua.
Quando, dopo sette anni, nel 1106, Lanfranco ha compiuto il suo lavoro, lo scenario dell’architettura è cambiato. Vige una libertà di moduli spaziali, tanto che si possono abolire i matronei dando luogo a sovrapposizioni prospettiche ancora stupefacenti. La luce può invadere l’interno. Il dentro e il fuori s’identificano. La materia si arricchisce, abbandona la monotonia per avvalersi dell’arenaria e della pietra d’Istria o del bianco di Verona. Caratteristica inconfondibile è, per Quintavalle, la “reinvenzione delle emicolonne addossate, legate da arcate che chiudono in alto una trifora, emicolonne che non hanno precedenti nella zona, né fuori, e che escono da una coscienza storica delle funzioni e del rapporto con il centro urbano”.
Questa lunga digressione era indispensabile per porsi l’interrogativo: dopo tale eversione linguistica, cosa accade?
Quale è stata l’eredità di Lanfranco?
Nessuna, o quasi. A seguito del terremoto del 1117, il duomo di Modena divenne paradigma della costruzione delle cattedrali di Parma, Piacenza, Cremona, dell’abbazia di Nonantola e, poco più tardi, delle cattedrali di Ferrara e Borgo San Donnino e di San Zeno a Verona. Risultato? Nessuno sembra aver neppure afferrato la tecnica del messaggio lanfranchiano.
Al duomo di Modena è mancato un convegno di Modena simile a questo, che ne proclamasse l’immagine. Dieci anni fa, nell’atmosfera puteolente del Post-Modern, nessuno poteva credere a un rilancio vigoroso ed esplosivo della modernità, quale si è verificato nel 1988 con la mostra del decostruttivismo a New York. Nessuno, salvo cinquanta architetti e critici, forse meno, decisi a “non mollare”. È sbalorditivo anche per chi ne è stato uno dei protagonisti: questo convegno sancisce una vittoria epocale, la sconfitta della viltà accademica, scolastica, classicista e/o postmoderna.
Si riapre, dopo oltre un millennio, il binomio perfetto/imperfetto, che risale alla preistoria e precisamente alla civiltà nuragica, la quale esclude un habitat geometrizzato, armonico, simmetrico, chiuso aprioristicamente nel proprio assetto. La vita nelle grotte e negli insediamenti nomadici aveva insegnato lo splendore dell’irregolarità, della contaminazione, delle luci intercettate e riflesse in mille tagli arcani. Il mondo sardo non vuole disperdere questi valori: perciò il suo disegno non è precostituito, ma scandito da successive aggregazioni, dettate dal gusto per la linea curva.
Linguaggio “casual”, quello nuragico, alieno dalla rifinitura e dal compiuto, aderente all’impulso del momento, a un metodo di frantumare corrispondente all’etica che dissocia l’abitato in microcosmi.
Dopo il 238 a.c., con l’occupazione romana della Sardegna, il valore del disordine e dell’imperfetto è stato costantemente censurato nell’edilizia ufficiale, per essere riscoperto solo alla fine degli anni Ottanta, quando i decostruttivisti rivendicarono il diritto degli architetti di non aspirare più al puro, all’immacolato, al perfetto, per cercare la creatività nel disagio, nell’incertezza, nel disturbato. Un valore linguistico rinato, di straordinari riflessi.
Di fronte al perfezionismo dei templi ellenici e delle colonne filmate romane, alle frustranti teorie “ideali” del Rinascimento e al rigore cartesiano dei razionalisti, il contributo di Pietilä, Libeskind, Koolhaas e soprattutto Gehry è consistito nel complementare il mito millenario della perfezione con la forza e l’irruenza dell’imperfetto. La poetica dell’imperfetto recupera il brutto, i rifiuti, il trasandato, gli stracci e i sacchi di Burri, il paesaggio derelitto, il cheapscape.
E dall’architettura si propaga nei comportamenti e nella moda.
Quando, negli ultimi mesi, è stata annunciata la moda maschile dell’imperfetto, abbiamo segnato un altro goal; non già seguendo la moda, ma determinando indirettamente il gusto degli stilisti. Siamo, all’un tempo, intellettuali sofisticati ed ermetici, e artisti popolari e gergali.
Ricapitoliamo il percorso del secolo, il cui senso appare capovolto rispetto a quello di dieci anni fa. Allora, l’espressionismo appariva una deroga conclusa nel 1924 con il trionfo del razionalismo. Oggi la prospettiva storica è invertita, l’espressionismo occupa l’intero secolo sfociando in quell’action-architecture che qualifica anche il nostro operare.
Abbiamo tre stagioni dell’espressionismo architettonico. La prima, pionieristica, è dominata dal genio di Antoni Gaudì. La seconda, storica, è impersonata da Bruno Taut, Mendelsohn, Häring, Finsterlin e Scharoun, con apporti di Poelzig, Behrens, Gropius e Mies. L’espressionismo non muore nel 1924, entra in letargo per risvegliarsi nei tardi anni Trenta, in funzione di critica e superamento dell’International Style.
Alvar Aalto, nel padiglione finlandese di New York nel 1939, riapre clamorosamente i temi dell’espressionismo e li conferma nell’impianto ondulato e ascendente dei dormitori studenteschi del MIT a Cambridge, Mass. Ma è Le Corbusier che, nell’urlo blasfemo di Ronchamp, fracassa principi, grammatica e sintassi razionalisti. Con una generosità che non ha riscontro nella storia, smentisce se stesso, le teorie elaborate dal 1921, i pilotis come i tetti-giardino, la griglia e il Modulor; straccia norme e codici senza sostituirli, lasciando attoniti e smarriti i suoi discepoli, Niemeyer, Candilis, Wogenscky e migliaia di seguaci nel mondo. Il terremoto informale ed espressionista di Ronchamp, reiterato nel padiglione Philips di Bruxelles 1958 riesplode a intermittenze, nel TWA Terminal di Eero Saarinen a New York, nella Endless House di Kiesler, nei lavori di Pietilä, Utzon, Renaudie, Michelucci, Ricci, D’Olivo, nel “brutalismo” inglese e in quello di Viganò, in mille rivoli ed episodi degli anni Sessanta e Settanta.
Nei primi anni Settanta sono formulate le “sette invarianti” del linguaggio moderno. Respinte dall’accademia, vengono largamente applicate nella professione.
Rovesciano la prospettiva didattica. Prima, il linguaggio architettonico si basava su regole, ordini, paradigmi, codici, da cui eccettuavano gli atti creativi, generatori di parole e sistemi di comunicazione nuovi.
Adesso, norme, precetti, tabù sono gettati nell’immondizia, le “invarianti” sono antiprescrittive, riguardano le deroghe, i No ai programmi edilizi fissati a priori, i No alle simmetrie e alle assonanze, alla tridimensionalità da un punto di vista privilegiato, alle scatole chiuse e isolate, alle strutture tradizionali, allo spazio statico, contemplato e non vissuto, alla discontinuità tra edificio, città e paesaggio.
Le “sette invarianti” scaturiscono da precise esperienze: di William Morris (elenco dei contenuti e delle funzioni), dell’Art Nouveau e del Bauhaus (asimmetria e dissonanze), dell’espressionismo di Gaudì e Mendelsohn (tridimensionalità antiprospettica), del movimento De Stijl di Theo Van Doesburg (scomposizione quadridimensionale), delle strutture in aggetto, a guscio e membrana dell’ingegneria più avanzata, del genio di Wright (spazio temporalizzato), delle moderne acquisizioni urbanistiche (continuum territoriale).
Alla fine degli anni Settanta eravamo alla vigilia di una stagione di “grado zero”, di quell’“architettura d’azione” che sgorga dagli eventi e non dalla loro mera rappresentazione. Il processo fu bloccato dal dilagante rigurgito Post-Modern, estremo tentativo di fermare il corso della modernità.
Quasi dieci anni perduti tra evasioni e cinismi, luridume ideologico e imbrogli storico-critici. È per questo che il decostruttivismo del 1988 ha assunto una eccezionale importanza: nel giro di ventiquattro ore, ha liquidato il Post-Modern, recuperando le conquiste del primo e secondo espressionismo, da Gaudì a Bruce Goff, e inaugurandone la terza stagione.
Il percorso del secolo si conclude in modo inaspettato, splendido. Eravamo un’infima minoranza di individui isolati.
Oggi guidiamo la maggioranza vincente.
Quando Frank Gehry è scelto per costruire il Guggenheim di Bilbao, quando Daniel Libeskind vince il concorso indetto dal Victoria & Albert Museum con un progetto strabiliante, non abbiamo più il diritto di recitare la parte dei soccombenti e dei rassegnati. Le vittorie di Hecker, Koolhaas, Eisenman e altri non riguardano solo gli autori dei progetti, ma le giurie, i committenti, l’opinione pubblica che plaude a verdetti una volta giudicati scandalosi. Ormai non ci sono alibi: se in Italia questo non avviene, è perché gli architetti non ci sanno fare.
Wright resta il genio sovrastante le tre stagioni dell’espressionismo, ma i decostruttivisti si sono liberati dal suo paternalismo rivendicando la vocazione all’impuro, al contaminato, all’angosciato, all’imperfetto nuragico, insomma a una scrittura democratica, “bianca”, amodale, basica, applicabile da parte di tutti. Una scrittura anti-autoritaria, antitetica a quella del potere.
Procediamo. Il discorso nuragico dell’imperfetto ci porta a un altro aspetto di quella civiltà: l’impulso anti-urbano, testimoniato da settemila unità turrite sparse nell’isola. Città-territorio a vastissima scala, in un certo senso riedita da Wright nel progetto di Broadacre City. Approdiamo così al tema della paesaggistica.
Urbanistica = Mondrian. Paesaggistica = Pollock. Se gli architetti avessero registrato il significato dell’espressionismo astratto americano, avrebbero evitato di sprecare qualche anno. Non solo lo zoning, ma tutta la metodologia del piano urbanistico è in crisi, poiché l’architettura di “grado zero” preme, batte infuriata, chiede e pretende libertà, non sopporta più di essere incasellata, coartata, stretta entro confini, determinata dal di fuori.
Già cinquant’anni fa, nel 1947, Giuseppe Samonà muoveva all’urbanistica l’accusa di fermarsi a indirizzare traffici, anelli di circolazione e arroccamento, spazi verdi e lottizzazioni, dimenticando gli edifici, la casa che, scriveva, «sarà quel volume che sarà, alto, lungo e profondo come prescritto nel regolamento, ove la casa è niente altro che un profilo, un fantasma di casa». Samonà denunciava «una frattura tra il piano organico e il suo nucleo fondamentale» dato dalle case che, «a rigor di termini, avrebbero dovuto formare materia a priori di analisi». E insisteva: «si cade nell’errore che vincoli pregiudiziali condannino le case entro una trama antiumana, che darà aspetto antiumano al paesaggio di case costituito come ambiente per l’uomo moderno»; o, peggio, condannerà gli organismi di quelle case a «vizi di sostanza che li rendono antiumani».
Le proteste contro la struttura attuale della disciplina urbanistica si moltiplicano in migliaia di libri, saggi e congressi. Il piano s’illude di governare l’ambiente, ma in effetti è travolto perché svincolato da previsioni architettoniche di qualità. Nasce così spontanea la tendenza, incarnata dall’espressionismo, di liquidare il piano urbanistico restituendo piena libertà all’edilizia.
Tanto più in considerazione del fatto che, da Bomarzo a Disneyland, le più capricciose licenze individualistiche non hanno mai provocato danni paragonabili a quelli degli ordini astratti, degli standard e delle normative generali.
Lo iato fra architettura e urbanistica è stato da tempo colmato mediante il concetto di “urbatettura”, ma questo serve scarsamente se non si effettua il trapasso di scala alla paesaggistica, all’impegno creativo sul territorio. Se finora, per convenzione, l’urbanistica ha preceduto l’architettura, adesso dobbiamo invertire la sequenza, affinché gli assetti territoriali scaturiscano dal basso, democraticamente, senza più distinzioni conflittuali tra istanze collettive e private, senza fughe evasive nelle nozioni di luogo e contesto.
La nuova progettualità territoriale non può appagarsi di un’autoproclamazione; deve trovare i suoi agganci legislativi e operativi. Forse non poteva prevalere prima dell’affermazione dell’architettura di “grado zero”; ma, ora che questa è consolidata, la lotta per la libertà creativa del paesaggio e del territorio non ha alcun motivo di essere procrastinata.
Le idee in materia sono assai confuse.
La paesaggistica ricerca una sua identità, diversa dall’arte dei giardini e della pianificazione regionale. Faccio due esempi: il “Congress for New Urbanism”, che si è tenuto a Toronto limitandosi a discutere di quartieri suburbani, e l’inno alle nuove città estremo-orientali fatto da Rem Koolhaas in tono più fideistico che motivato. La confusione è notevole ovunque nel mondo.
Anche in questo campo, gli sprechi sono innumeri e devastanti. Ometto per brevità di parlare del pauroso depauperamento del linguaggio urbanistico nel passaggio dall’epopea medievale all’impotente arroganza della “città ideale” del Rinascimento; o del masochismo neoclassico rispetto alla dinamica dell’urbanistica barocca. Preferisco accennare a sperperi vicini a noi. Il più evidente porta il nome di Frederick Law Olmsted, eccellente paesaggista convinto della necessità di inventare una nuova città americana, contrapposta a quella autoritaria e repressiva europea. Ne discuteva con un grande architetto suo amico, H.H. Richardson, che aspirava a un linguaggio di “grado zero”. Quando Richardson morì, Olmsted rimase solo, orfano, e nel 1893, pur malvolentieri, collaborò con gli accademici convenuti per la nefanda esposizione di Chicago. L’alternativa alla città europea restò così un’ipotesi in sospeso, un mito frustrato, ma sempre vivo e diffuso fra gli americani, in parte riemerso nel binomio wrightiano Broadacre City -Grattacielo alto un miglio e, in chiave compensatoria, nelle Disneyland.
Tra gli altri sprechi, elenco telegraficamente:
– Jackson Pollock. Senza la tecnica del dripping, delle scolature, è arduo rappresentare una paesaggistica fluida;
– la Pop Art, che ha incentivato la comprensione della cacofonia urbana, colmando la separazione, come disse Rauschenberg, tra vita e arte;
– l’architettura dei paesaggi derelitti, barriadas, favelas, bidonvilles, baracche, slums e via dicendo, l’universo respinto dalla cultura ufficiale;
– l’edilizia anonima, dialettale, vernacolare e gergale, l'”architettura senza architetti” di Bernard Rudofsky;
– l’advocacy planning, pronta a difendere e rivalutare le sotto culture urbane e territoriali;
– infine, l’action-architecture che, l’abbiamo già detto, come l’espressionismo astratto, nasce sugli eventi e non sulla loro rappresentazione.
Tutti questi valori vanno reinterpretati e aggiornati, rilanciati in nuove versioni se vogliamo che la paesaggistica graffi e non sia solo consolatoria. L’unico tentativo valido di superare la Carta di Atene del 1933 è stato la Carta del Machu Picchu del 1977, snobbata da tutti i professori di urbanistica e da quasi tutti gli urbanisti, ma riscattata l’anno scorso in un congresso dell’Unione Internazionale Architetti.
Cari amici, questo è un convegno sperimentale, ostile ai parametri di comportamento dei convegni istituzionali, accademici e professionali: convegni sonniferi e sbadigliosi, in cui ognuno recita un monologo preconfezionato e poi segue un dibattito su relazioni che nessuno ha ascoltato attentamente, in un dialogo fra sordi e indifferenti.
Questo è un convegno che non serve a far carriera nelle nostre università soporifere, né negli ordini e nelle associazioni professionali, né serve a trovare clienti. Convegno senza regole e formalità, privo di programmi e ordini del giorno, in cui può valere anche il silenzio in un’atmosfera disturbata, inquieta e lieta.
Un convegno comunque di tipo inedito, atto a suscitare curiosità, diffidenza e sospetti. Un convegno rischioso, di cui chiedo scusa ai nostri ospiti stranieri che, in questi mesi, mi hanno tempestato di lettere e telegrammi per sapere cosa dovevano preparare, e a cui ho risposto: niente, e meno che mai conferenze.
La finalità del convegno è chiaramente politica. I convegni si fanno per modificare la situazione politica, o non si fanno. Se indugiamo su temi estetici, linguistici, espressivi è perché l’arte anticipa e prefigura il panorama sociale, e noi dobbiamo essere culturalmente ferratissimi per lottare efficacemente sul terreno politico.
Proprio mentre osserviamo le immagini del cantiere di Bilbao, che ci porta esattamente tra un mese, il 19 ottobre, quando il Guggenheim sarà inaugurato, sul terreno politico, in Italia siamo davvero non al grado, ma all’anno zero.
Continua a mancare una classe dirigente conscia dei drammi e delle sfide del territorio, delle città e dell’architettura. Tra i nostri politici, parlamentari o meno, si annoverano appassionati di letteratura, di pittura, di musica, di sport, ma nessuno appassionato di architettura come sono stati in Francia un Pompidou o un Mitterand. Tanto per fare dei nomi, l’on. Veltroni, Ministro dei Beni Culturali, di tutto si occupa, di musei come di danze del ventre, ma non di architettura. Il Ministro dei Lavori Pubblici è una persona stimabile e autorevole proveniente dalla veneziana Ca’ Foscari, ma di sensibilità alla qualità architettonica non ha dato ancora alcun segno. In Parlamento ci sono uomini vivi e colti, ma nessuno ha ritenuto conveniente coinvolgersi nella paesaggistica e nell’architettura d’azione.
È nostro compito mobilitarci per mutare questa incredibile arretratezza rispetto al mondo. Abbiamo motivo di nutrire fiducia perché, grazie al governo di centro-sinistra, siamo in Europa e possiamo agire a livello europeo per colmare le lacune italiche.
Nell’immediato dopoguerra, l’APAO (Associazione per l’Architettura Organica) vinse battaglie fondamentali: quelle del Memorial alle Fosse Ardeatine e del blocco frontale della stazione Termini a Roma, quella del rinnovamento dell’Istituto Nazionale di Urbanistica poi presieduto da Adriano Olivetti, quelle di una significativa presenza nei programmi dell’INA-Casa e dell’UNRRA-Casas, e nell’insegnamento universitario. Nelle APAO eravamo in pochi, ma dietro di noi spiravano il vento e il profumo del Partito d’Azione e di nuclei comunisti e cattolici decisi a non farsi burocratizzare.
Nel 1959 nacque l’In/arch (Istituto Nazionale di Architettura) che, per trentotto anni, ha tenuto viva la cultura architettonica con riunioni settimanali – gli ormai celebri “lunedì dell’architettura” – mostre, concorsi, convegni, congressi, una pluralità di iniziative; e ora è in fase di espansione, affiancato da riviste, collane di tascabili, rubriche in settimanali. L’In/arch si è sviluppato all’insegna di una collaborazione tra forze culturali e forze economiche; si può ben dire che questo convegno, sponsorizzato generosamente dall’industria Mirage, sia frutto indiretto dell’azione dell’In/arch. Quando ai Lavori Pubblici c’era un leader come Fiorentino Sullo, con Ugo La Malfa Ministro della Programmazione, la Conferenza Nazionale dell’Edilizia gestita dall’In/arch maturò una strategia di interventi che dovremmo riesaminare e aggiornare.
Va aggiunta un’osservazione. I “gradi zero” della storia, a parte il primo dell’età cavernicola, coincidono con periodi di disastrose crisi economiche e sociali. Il secondo “grado zero”, quello delle catacombe, è accompagnato dal crollo dell’impero e da una filosofia tutta rivolta all’aldilà, all’oltretomba. Il terzo “grado zero”, quello dell’Alto Medioevo, è caratterizzato dal disfacimento etico-politico che precede la lenta formazione del romanico. Ma il
“grado zero” della modernità, quello che oggi gestiamo, non coincide affatto con un periodo di crisi. L’action-architecture, il linguaggio neoespressionista, decostruttivista e organico ha abbandonato i temi dello Sturm und Drang, l’attesa spasmodica della guerra, l’orrore e la disperazione delle trincee, il vuoto morale e la fame del dopoguerra. Siamo al servizio di un mondo drammatico ma vitale e lieto, in crisi ma carico di valori. Il trionfo dell’architettura è simultaneo al rilancio della produzione edilizia. Il nostro compito consiste nel gestire la prosperità calamitando gli industriali e gli imprenditori più illuminati, le forze sindacali più disponibili al nuovo, gli uomini politici determinati a creare una classe dirigente di livello europeo.
Noi chiediamo:
– una legge-quadro sull’architettura, almeno pari a quelle vigenti in Francia e nei più progrediti paesi europei;
– una reinvenzione del Ministero dei Lavori Pubblici, che è un pachiderma accovacciato su se stesso;
– un radicale ripensamento delle funzioni delle Soprintendenze, monarchie assolute capaci di rovinare capolavori come il Palazzo dei Diamanti a Ferrara, e incapaci di affrontare il restauro di un monumento come il Colosseo;
– una presa di coscienza dei temi ambientali, architettonici e territoriali da parte del Ministero dei Beni Culturali, degli enti locali, regioni, province e comuni, la cui attività – vedi il caso di Roma, fortunatamente salva dalle Olimpiadi del 2004 – è caratterizzata dalla mancanza di fantasia, dall’inabilità a creare una visione globale, un’immagine dinamica del futuro;
– un riesame degli slogan, delle frasi fatte, dei pregiudizi diffusi, dalla pedonalizzazione indiscriminata dei centri storici all’esclusione di interventi moderni nei loro tessuti. È ora di denunciare l’attacco forsennato alle macrostrutture, come le Vele di Napoli o Corviale a Roma. Quando l’Assessore all’Urbanistica di Napoli dichiara che “nelle Vele gli ascensori non hanno mai funzionato”, il discorso è chiuso, perché una macrostruttura senza ascensori è un’assurdità, una contraddizione in termini.
Resta un mistero perché si decida per la demolizione prima di tentare di rendere gli ascensori funzionanti.
Chiediamo tutto questo e siamo convinti di poterlo ottenere. Lungi da noi, dopo la tragica esperienza dei paesi dell’Est e l’ambigua politica dei comunisti, identificare la sinistra con la cultura, ma è certo che la presenza della sinistra nel governo offre spunti e incentivi nuovi.
A questo convegno mancano tre persone: Frank O. Gehry trattenuto in California da un processo contro la Disneyland; François Barré, capo dell’architettura nel Ministero della Cultura francese, riconfermato ora nel suo incarico con l’aggiunta della responsabilità di capo del patrimonio;
e lord Richard Rogers, laburista, rappresentante del governo di Tony Blair. Tutti e tre hanno aderito alla nostra iniziativa e collaborano con noi.
Concludo in chiave personale. Ho quasi ottant’anni, sto benissimo, con la “Controstoria dell’architettura in Italia” ho completato il mio programma di lavoro, gioco a tennis tutte le mattine. Dal 1943 mi considero un sopravvissuto, essendo sfuggito senza motivo allo sterminio della mia gente. Quindi penso alla morte serenamente, al modo di Benedetto Croce il quale narrava che, quando gli capitava di pensare alla morte, si ricordava di un suo amico, chirurgo napoletano che, mentre operava, sentendosi mancare, prese il bisturi, lo consegnò a un suo aiuto e disse: “continua tu”.
Io sono felice perché so che, in qualsiasi momento, sentendomi mancare, posso rivolgermi a voi, dicendo: continua tu, tu, tu, tu. Grazie.
Cittadinanza onoraria del comune di Ferrara.
Zevi, ferrarese senza rancori
“il Resto del Carlino”, luglio 1997, di Eleonora Rossi.
 «Nessun rancore. Merito questa cittadinanza onoraria per il prolungato ostracismo, per la lunga e sistematica esclusione da questa città, per il cumulo di insulti e scherni di cui sono stato oggetto durante congressi, convegni e riunioni organizzati e svoltisi qui senza neppure invitarmi.» Con queste parole, pronunciate in tono provocatorio, ieri pomeriggio Bruno Zevi, professore, studioso, esperto di Ferrara ha accettato la cittadinanza onoraria consegnatagli dal Sindaco Roberto Soffritti.
«Nessun rancore. Merito questa cittadinanza onoraria per il prolungato ostracismo, per la lunga e sistematica esclusione da questa città, per il cumulo di insulti e scherni di cui sono stato oggetto durante congressi, convegni e riunioni organizzati e svoltisi qui senza neppure invitarmi.» Con queste parole, pronunciate in tono provocatorio, ieri pomeriggio Bruno Zevi, professore, studioso, esperto di Ferrara ha accettato la cittadinanza onoraria consegnatagli dal Sindaco Roberto Soffritti.
«Alcuni sospettano che la cittadinanza onoraria venga attribuita a personalità in stato di avanzata arteriosclerosi -incalza Zevi con ironia- io sono qui ad attestare che il consiglio comunale mi conferisce la cittadinanza non come premio ma come incentivo per occuparmi di temi scottanti che mi interessano».
Architetto, urbanista, appassionato conoscitore di Ferrara, a partire dagli anni ’50 Zevi ha dedicato approfonditi studi alla nostra città e in particolare all’opera dell’allora quasi sconosciuto Biagio Rossetti. “Biagio Rossetti, architetto ferrarese, il primo urbanista moderno europeo” del 1969, “Saper vedere l’urbanistica” del ’71 e l’ultima riedizione del ’97 “Saper vedere la città” rappresentano «studi fondamentali, animati dal rigore dello storico e dallo slancio del politico che interpreta il passato come stimolo del presente, in un’organica fusione tra urbanistica e architettura», spiega Giovanna Marchianò, Presidente del Consiglio Comunale. «Ferrara deve moltissimo a Zevi –aggiunge Paolo Ceccarelli, preside dell’ateneo di architettura- poiché ha saputo promuovere studi intelligenti e originali impegnandosi a fondo sul piano etico e civile». Il Presidente della Provincia Paolo Siconolfi riconosce a Zevi e a Roberto Longhi il merito di aver inventato Ferrara come «città d’arte». Si vorrebbe proseguire l’opera intrapresa da Zevi -sottolinea il Sindaco- in collegamento con i progetti elaborati dall’Unione Europea per dare a Ferrara una dimensione internazionale moderna, ma integrata con le sue radici e la sua cultura, valorizzando il centro storico e recuperando la dimensione ‘umana’ della città. Ma Zevi attacca l’inconsistenza o la mediocrità di progetti che dovrebbero essere rielaborati, riportando i risultati della ricerca sulla cultura svolta da Umberto Eco e Roberto Grandi: «L’urbanistica è in crisi. Il ruolo di Piet Mondrian è stato occupato da Jackson Pollock. La trama ortogonale è stata sostituita dal ‘dripping’, dalle scolature.» Zevi appare critico e provocatorio, ma non si esime dal proporre soluzioni inedite:«Ha mai pensato, signor Sindaco, di chiamare un genio come Frank Lloyd Wright a progettare sia pure un canile per Ferrara? Un atto del genere avrebbe portato questa città all’avanguardia della cultura internazionale. Si è optato invece per la via opaca, per un’architettura corretta, vagamente ispirata, sostanzialmente anodina». Zevi non rispolvera la vecchia questione del Palazzo dei Diamanti, ma denuncia lo scempio del Palazzo di Ludovico il Moro, il non-finito più significativo e affascinante della vicenda architettonica italiana, assassinato in omaggio ad una concezione accademica e livellatrice. Ma, dopo aver spezzato una serie di lance, ammette: «In questa città mi sento a casa mia e la cittadinanza onoraria che mi conferite è un po’ la legittimazione ufficiale di un’acquisizione interiore».
Intervento “Le Corbusier e il grado Zero della scrittura architettonica” alla “Fondation Le Corbusier” all’Unesco, a Parigi.
Le Corbusier e il grado zero della scrittura architettonica
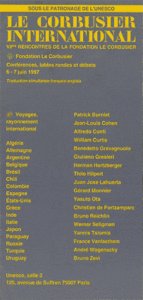 Mi sono laureato in architettura con Walter Gropius all’università di Harvard, ma la mia predilezione, sempre più appassionata, è andata a Frank Lloyd Wright, che considero come uno dei più grandi geni creativi di tutti i tempi, e a Erich Mendelsohn, l’architetto dell’espressionismo.
Mi sono laureato in architettura con Walter Gropius all’università di Harvard, ma la mia predilezione, sempre più appassionata, è andata a Frank Lloyd Wright, che considero come uno dei più grandi geni creativi di tutti i tempi, e a Erich Mendelsohn, l’architetto dell’espressionismo.
Ho insegnato per trent’anni Storia dell’Architettura, prima a Venezia, poi a Roma. Ho scritto una ventina di libri ma, se mi domandate quali sono i miei contributi veramente originali, rispondo: solamente tre. Forse, tenuto conto di ciò che dirò oggi, tre e mezzo.
Eccoli:
1. Lo spazio, in quanto protagonista dell’architettura. Certamente, non sono io che ho inventato lo spazio. Esiste una vasta letteratura, soprattutto tedesca, su questo argomento. Ma essa confonde sempre lo spazio con la “spazialità”, che si realizza anche nella pittura e nella scultura. Io ho affermato la specificità dello spazio architettonico nel quale l’uomo vive e si muove. Spazio da vivere e non solo da contemplare.
2. L’identità tra architettura creativa e storiografia o critica dell’architettura. Di contro alla visione accademica che vorrebbe il presente adattato al passato, io sostengo che il passato si deve adattare al presente. Ogni movimento di innovazione comporta un cambiamento, una rivoluzione nel modo di interpretare e di giudicare la storia. In altri termini, la storia non deve costituire un limite, ma uno stimolo alla libertà dell’architettura. È per questo che mi sono dedicato soprattutto alla storia e alla critica dell’architettura.
3. Il linguaggio architettonico. Ogni lingua ha un codice che serve a trasmetterla. Ma in architettura un solo codice è stato teorizzato e trasformato in dottrina: quello classico, che ha codificato anche il gotico e il barocco. La lingua moderna si oppone al codice classico, ma anche a qualsiasi codice, poiché ogni codice implica autorità, dogmi, regole, tabù come la proporzione, costrizioni come la geometria. Quello che si pone è il problema di un linguaggio fondato non sulle regole o sui paradigmi, ma sulle deroghe, sulle eccezioni alle regole. Bisogna dunque codificare questo anti-codice per ottenere, come dice Roland Barthes, una “scrittura bianca”, di grado zero.
Ecco praticamente tutto ciò che ho fatto. Ed è ciò che mi permette di essere, al contrario della maggior parte degli storici e dei critici, che sono molto preoccupati, molto pensierosi e molto perplessi, del tutto ottimista ed entusiasta riguardo al presente e al futuro dell’architettura. Io credo che il secolo che si chiude ha segnato la vittoria non solo dell’architettura moderna, ma dell’architettura tout court, e che è in grado di trasmettere al prossimo millennio una scrittura architettonica di grado zero, opposta al potere, all’autorità, democratica, capace di fare poesia, ma anche di essere popolare e di esprimersi in prosa. E questo rappresenta forse il mio ultimo mezzo contributo.
Cosa ha a che vedere Le Corbusier con tutto questo?
Lo choc linguistico fu causato proprio da Le Corbusier. Il salto incredibile compiuto all’epoca del passaggio folgorante dalla poetica razionalista dei «volumi puri sotto la luce» all’informale neo-espressionista della Cappella di Ronchamp fu, tanto per la professione quanto per la critica, un vero terremoto. Tutti cercavano di esorcizzare lo spettro di un linguaggio senza codice di grado zero, attribuendolo a cause esteriori, la depressione del dopoguerra, la psicoanalisi liberatrice di forze irrazionali, o anche una vaga reviviscenza religiosa. Io stesso ho spiegato questo rovesciamento con una percezione estremamente sensibile degli eventi: la guerra aveva oltraggiato e annientato ogni illusione razionale. Le Corbusier era il solo al mondo che aveva avuto il coraggio di dichiararlo, anche al rischio di smentirsi.
Oggi, a distanza, ci si rende conto dell’enorme importanza di quel gesto. Nel corso della storia, molti architetti hanno cambiato strumenti di espressione: basta pensare a Bramante «dalla luce lombarda all’oscurità romana», a Michelangelo, a Bernini. Ma nessuno ha avuto l’arditezza di Le Corbusier nel rifiutare all’improvviso i «cinque principi» del 1921, il minimalismo degli anni Trenta, la griglia, il modulor. A Ronchamp non troviamo alcuna traccia del piano libero, dei pilotis, della facciata in aggetto, delle finestre a nastro, del tetto-giardino, e non troviamo neanche le modanature seducenti, gli «oggetti a reazione poetica» delle opere francesi fino all’Unità di Abitazione di Marsiglia.
Le Corbusier non modifica il suo linguaggio. Lo rigetta in blocco senza sostituirlo. Lascia i suoi discepoli, Candilis e Niemeyer compresi, nel più completo smarrimento. A partire da quel giorno, il maestro non parla più agli altri, ma solo a se stesso. Non insegna più, canta.
La cultura internazionale non era in grado di captare il segnale. Cercò di non tenerne conto, di dimenticarlo. Andò avanti con difficoltà, ritornò indietro, attardandosi nel ristagno del post-moderno. Ronchamp restò là, tragico monumento nel deserto.
Alla fine degli anni Ottanta, la crisi sembrava dilagante, senza limiti. E tuttavia bastò l’esposizione decostruttivista al MoMA di New York per uscirne dall’oggi al domani. La professione, più che la critica, ebbe una reazione immediata, riprendendo il cammino della modernità, vale a dire trasformando la crisi in valore.
Ed eccoci arrivati al periodo recente. Siamo ora nell’«architettura d’azione», una architettura d’azione, in un espressionismo astratto, un linguaggio di grado zero. Tra i numerosi protagonisti che potremmo citare, fermiamoci a sette: Pietilä, Utzon, Renaudie, Hecker, Behnisch, Libeskind, Gehry.
Cosa fanno? Qual’è il loro contributo?
Alvar Aalto concepisce la scuola di Otaniemi in forma di sezione. Ma Reima e Raili Pietilä, modellando il centro Dipoli per gli studenti (nel 1968, una coincidenza) ritornano al grado zero dell’alto medioevo, associando gli elementi in tutta libertà, rifiutando ogni grammatica e sintassi. Un linguaggio prodotto per gli studenti, ma adottato anche per la residenza del presidente della Finlandia.
La giuria del concorso per l’Opera di Sidney aveva già espresso un giudizio sul progetto di Jörn Utzon, ma Eero Saarinen lo rivede, lo recupera per proporlo di nuovo. È una costruzione intricata e molto costosa, al punto che l’autore è obbligato a dimettersi dalla direzione dei lavori. Ma l’organismo si slancia e vibra nella baia, assorbe il cielo, lo concentra e lo riflette, trasmettendo gli impulsi dinamici all’interno. Regole? Norme? Proporzioni? Codice? Sono fuori questione.
Jean Renaudie detesta gli angoli retti, che condannano la fantasia all’inerzia. L’obliquo diviene così un metodo duttile, elastico, suscettibile di infinite variazioni.
Zvi Hecker parte dalle teorie cristallografiche del suo maestro Alfred Neumann. Poi si consacra alla spirale. Ma, nella scuola di Berlino, il gioco delle spirali scompare o è nascosto nel vortice di movimenti più complessi e informali.
Günther Behnisch è differente dagli altri, esercita la professione serenamente, e ottiene una rinomanza internazionale grazie alle strutture trasparenti delle Olimpiadi di Monaco. Ma, in seguito, rifiuta il semplicismo, piega gli edifici come se dovessero crollare, rende contrastanti gli interni con una sovrapposizione e un pluralismo di temi in prospettiva.
Straordinario il cammino percorso da Daniel Libeskind. Nell’ala ebraica aggiunta al museo di Berlino sceglie la linea spezzata e i vuoti, i muri smontati, una miriade di punti, di luci sfalsate, di scarti altimetrici. Al concorso per l’ampliamento del Victoria & Albert Museum di Londra, arriva al grado zero con una densità e un radicalismo sconosciuti. Il codice è assente, non c’è modo di rifiutarlo perché non esiste.
Quanto a Frank Owen Gehry, il suo linguaggio è così libero e così pieno di fantasia che sembra una sorta di prosa corrispondente alla poesia di Frank Lloyd Wright. Celebra il disordine e l’arte povera. Parla di «cheapscape», del paesaggio negletto, come di un contesto privilegiato. Il Centro Americano a Parigi rappresenta forse l’espressione più avanzata dell’«architettura d’azione».
Ecco i sette protagonisti della ricerca in corso; prima di essi ce ne sono molti altri: Frederick Kiesler, John Johansen, Hans Scharoun, Erich Mendelsohn e Hugo Häring, Antoni Gaudì, Borromini e Pietro da Cortona, Buontalenti e Brunelleschi, soprattutto Arnolfo di Cambio, l’epopea urbana medievale e, più lontano nel tempo, attraverso i secoli e i millenni, fino alle caverne capolavoro dell’informale. A dire il vero, tutta la storia dell’architettura è rovesciata: piuttosto che essere piena di dogmi e punteggiata di eccezioni, sembra segnata da eccezioni che annullano i codici.
Alla vigilia del terzo millennio, l’architettura trionfa: ha conquistato lo spazio senza condizionamenti. L’ispirazione è wrightiana, ma il gesto di rottura è segnato da Le Corbusier.
Per concludere, ho pensato a due possibilità, Wright o Barthes. E ho deciso di chiudere con entrambe.
1924. Erich Mendelsohn scrive alla moglie Louise il giorno dopo aver visitato Taliesin: «Wright dice che l’architettura del futuro sarà, per la prima volta nella storia, totalmente architettura, spazio in sé, senza alcun modello prescritto, movimento in tre e quattro dimensioni … Una gioia di vivere espressa nello spazio…».
Era il 5 novembre del 1924. Dopo 73 anni, la profezia di Wright è divenuta realtà.
Rimasto fino a oggi nel limbo dell’utopia, il sogno di Roland Barthes sembra concretamente realizzato. Chiudo citandolo:
«In questo stesso sforzo di affrancamento dal linguaggio letterario, ecco un’altra soluzione: creare una scrittura bianca, liberata da ogni servitù […]. La scrittura di grado zero è in fondo una scrittura indicativa, o, se si vuole, amodale […]. Si tratta di sorpassare la Letteratura [con la L maiuscola] affidandosi ad una sorta di lingua di base […]. Questa volta, lo strumento non è più al servizio di una ideologia […], è il modo d’esistere del silenzio […]. Se la scrittura è veramente neutra, allora la Letteratura è vinta».
Si può aggiungere: «Se la scrittura è veramente neutra, allora l’architettura del potere, classica, accademica, post-moderna, è vinta». Grazie.
Pubblicazione di "Leggere, scrivere, parlare architettura".
“Leggere, scrivere, parlare architettura”
 Marsilio, Venezia 1997. riedizione di “Architettura e storiografia”, Libreria Editrice Politecnica Tamburini, Milano 1950; “Architettura e storiografia” Le matrici antiche del linguaggio moderno, Einaudi, Torino 1974; “Poetica dell’architettura neoplastica”, Libreria Editrice Politecnica Tamburini, Milano 1953; “Poetica dell’architettura neoplastica” Il linguaggio della scomposizione quadridimensionale, Einaudi, Torino 1974; “Il linguaggio moderno dell’architettura” Guida al codice anticlassico Einaudi, Torino 1973.
Marsilio, Venezia 1997. riedizione di “Architettura e storiografia”, Libreria Editrice Politecnica Tamburini, Milano 1950; “Architettura e storiografia” Le matrici antiche del linguaggio moderno, Einaudi, Torino 1974; “Poetica dell’architettura neoplastica”, Libreria Editrice Politecnica Tamburini, Milano 1953; “Poetica dell’architettura neoplastica” Il linguaggio della scomposizione quadridimensionale, Einaudi, Torino 1974; “Il linguaggio moderno dell’architettura” Guida al codice anticlassico Einaudi, Torino 1973.
1998
Intervento “Spazio e non-spazio ebraico” al convegno della comunità ebraica di Venezia.
Spazio e non-spazio ebraico
Confronto del compositore jazz Uri Caine con la musica di Mahler
Comunità Ebraica di Venezia, 29 novembre 1998
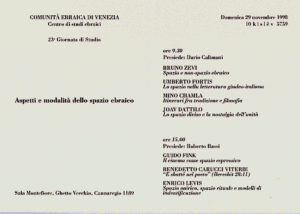 Inizio con un episodio vero, che suona come una storiella umoristica yiddish. L’ala ebraica del museo di Berlino, progettata dall’architetto Daniel Libeskind, doveva essere inaugurata già da vari mesi, dalla fine dello scorso anno. Perchè l’evento tanto atteso è ancora procrastinato? Perchè il museo è vuoto, non vi è stata allestita alcuna mostra. Il materiale è lì ma, dice il direttore: «Dalla mattina alla sera, migliaia di visitatori pagano il biglietto d’ingresso, si aggirano nelle sale deserte, non vedono niente poiché non c’è niente da vedere, ed escono pienamente soddisfatti». In realtà, non vedono quadri, statue, documenti, cimeli, ma vivono in cavità inedite, altimetricamente sfalsate, travolgenti e inebrianti, in bilico tra decine di ponti e centinaia di rabbiose feritoie diagonali che tagliano a zig zag, feriscono pareti, soffitti e pianciti. Sono spazi geometricamente indefinibili, ignari d’ogni impianto codificato, privi di angoli retti e di linee e piani paralleli, emancipati da ogni norma, da ogni tabù tradizionale. Questi spazi che sfuggono ad ogni definizione stereometrica, questi non-spazi rievocano i caratteri della lingua yiddish descritti da Kafka: «Espressioni brevi e nervose. Non ha grammatica. Alcuni tentano di scrivere delle grammatiche, ma lo yiddish viene parlato senza sosta e non trova pace. Il popolo non lo cede ai grammatici… Lo yiddish si compone solo di parole straniere, che però non riposano nel suo seno, ma conservano la fretta e la vivacità con cui sono state accolte. Lo yiddish è percorso da un capo all’altro da migrazione di popoli… Nelle sue strutture linguistiche, impastate di arbitrio e regole fisse, si riversano ancora i dialetti, perché tutto lo yiddish non si compone che di dialetto, compresa la lingua scritta».
Inizio con un episodio vero, che suona come una storiella umoristica yiddish. L’ala ebraica del museo di Berlino, progettata dall’architetto Daniel Libeskind, doveva essere inaugurata già da vari mesi, dalla fine dello scorso anno. Perchè l’evento tanto atteso è ancora procrastinato? Perchè il museo è vuoto, non vi è stata allestita alcuna mostra. Il materiale è lì ma, dice il direttore: «Dalla mattina alla sera, migliaia di visitatori pagano il biglietto d’ingresso, si aggirano nelle sale deserte, non vedono niente poiché non c’è niente da vedere, ed escono pienamente soddisfatti». In realtà, non vedono quadri, statue, documenti, cimeli, ma vivono in cavità inedite, altimetricamente sfalsate, travolgenti e inebrianti, in bilico tra decine di ponti e centinaia di rabbiose feritoie diagonali che tagliano a zig zag, feriscono pareti, soffitti e pianciti. Sono spazi geometricamente indefinibili, ignari d’ogni impianto codificato, privi di angoli retti e di linee e piani paralleli, emancipati da ogni norma, da ogni tabù tradizionale. Questi spazi che sfuggono ad ogni definizione stereometrica, questi non-spazi rievocano i caratteri della lingua yiddish descritti da Kafka: «Espressioni brevi e nervose. Non ha grammatica. Alcuni tentano di scrivere delle grammatiche, ma lo yiddish viene parlato senza sosta e non trova pace. Il popolo non lo cede ai grammatici… Lo yiddish si compone solo di parole straniere, che però non riposano nel suo seno, ma conservano la fretta e la vivacità con cui sono state accolte. Lo yiddish è percorso da un capo all’altro da migrazione di popoli… Nelle sue strutture linguistiche, impastate di arbitrio e regole fisse, si riversano ancora i dialetti, perché tutto lo yiddish non si compone che di dialetto, compresa la lingua scritta».
Chiusa a premessa. Molti anni fa, in occasione di un congresso dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, tenni a Roma, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, una prolusione sul tema: “Ebraismo e concezione spazio-temporale dell’arte”. Pubblicata in varie lingue, è tuttora citata da chiunque si occupi di questo argomento. Mi identifico in questo discorso in cui il mio essere orgogliosamente ebreo e appassionatamente sionista coincide con la lotta antifascista, di “Giustizia e Liberta’” e del Partito d’Azione, che ha qualificato tutta la mia vita, e con le quotidiane battaglie per l’architettura organica, per un ambiente atto a promuovere la felicità umana.
Tutto quanto dirò oggi è legato a quel discorso, lo commenta e verifica. E, poiché non posso pretendere che voi l’abbiate letto e lo ricordiate, lo riassumo in cinque punti nodali, anche a rischio di rendere schematica un’ottica critica che mira ad essere duttile e flessibile.
l. L’ebraismo è una concezione del tempo. Mentre le divinità di altri popoli sono associate a luoghi e cose, il Dio di Israele è il Dio degli eventi. La vita ebraica, scandita sul Libro e commentata dal Talmud, è permeata di storia, cioè da una coscienza temporalizzata dei compiti umani. Tra i grandi pensatori, Filone, Maimonide, Spinoza, Michelstaedter, proposero mediazioni sincretiche tra ontologismo e relatività, anche per evitare qualsiasi dogma o feticcio del tempo. Ma in nessun caso l’ebraismo è riducibile ad una concezione spaziale.
2. Nel sabato s’individua la santificazione del tempo, di Dio, dell’esistenza: «I sabati sono le nostre grandi cattedrali», afferma Heschel. Noi privilegiamo la crescita sull’essere, la formazione rispetto alla forma come entità conclusa. La nostra storia è antistatica e antispaziale. Comincia da una diaspora, dall’esilio in Egitto, con una migrazione verso la Palestina. La diaspora si ripete dopo la distruzione del secondo tempio e continua nei secoli. Nomadi ai primordi, poi erranti fino alla realizzazione del sogno di Teodoro Herzl, nel “galuth”, notava Nachum Goldmann, «si esprime il carattere specifico della nostra storia».
3. La coscienza dello spazio alimenta l’idolatria. Quella del tempo contrassegna l’eresia. In arte, nel mondo antico, l’atteggiamento iconoclasta è un atto eretico. Costantemente, l’ebraismo si oppone a tre concezioni: a) al classicismo, b) all’illuminismo, c) al cubismo analitico. NO AL CLASSICISMO, perché punta sull’ordine a priori. NO ALL’ILLUMINISMO, perché propugna idee universali, assolute e assolutiste. NO AL CUBISMO, perché astrae dalla materia, riguarda il montaggio di forme e non l’autofarsi della forma. L’ebraismo in arte punta sull’anticlassico, sulla destrutturazione espressionista della forma; rigetta i feticci ideologici della proporzione aurea e celebra la relatività; smentisce le leggi autoritarie del bello ed opta per l’illegalità e la sregolatezza del vero.
4. I grandi ebrei, da Einstein a Freud, da Schönberg a Kafka a Soutine a Erich Mendelsohn, sono dissacratori di miti, tenacemente avversi agli idoli sempre ricorrenti dei vitelli d’oro. «L’insegnamento dell’ebraismo», dice Heschel, «consiste nella teologia dell’azione comune».
L’interesse di Dio è per il vivere di ogni giorno. La sfida non sta nell’organizzare grandi sistemi dimostrativi, ma nel modo in cui gestiamo il luogo comune”. Per l’artista ebreo, cos’è l’ansia del tempo?
Riflette un’angoscia esistenziale, emana dal dubbio, dall’insicurezza.
Nessun luogo del mondo è immune dall’antisemitismo, nessun luogo è sicuro, neppure la terra d’Israele. Smarrito, l’artista ebreo vive in uno stato di incomunicabilità, non può illudersi, non c’è nessun rifugio, neppure nell’ambito della cultura.
5. La vita ebraica è dunque quella dell’espressionismo, l’unico movimento disposto a falsificare e demolire tutti i tabù estetici e linguistici, senza pretendere di ricostruirne subito altri. È la via dello yiddish, privo di grammatica e di sintassi, farcito di parole straniere, “percorso da migrazione di popoli”. È la via di Gustav Mahler, antologia di frantumi, magma di contaminazioni, arte aristocratica e Kitsch in un montaggio aleatorio, irriducibile a strutture linguistiche codificate. Per Arnold Schönberg emancipare la dissonanza significa eliminare le ultime scorie dell’illuminismo e del neoclassicismo, sconfiggere la tonalità, tutto ciò che di gerarchico e autoritario essa presuppone rispetto a un “prima” e a un “dopo”. L’emancipazione della dissonanza coincide con l’emancipazione del popolo ebraico, l’elemento dissonante più osteggiato, odiato, deriso, insultato, perseguitato della vicenda umana. Il messaggio ebraico culmina nell’opera del massimo genio della storia architettonica, Frank Lloyd Wright, non-ebreo. Uno studioso americano, Norris Kelly Smith, ha spiegato la natura di questo genio sulla base di un confronto tra pensiero ebraico, “dinamico, vigoroso, appassionato e spesso esplosivo” e pensiero greco, “statico, pacifico, moderato e armonioso”. Figlio di un sacerdote unitario, la cultura di Wright, radicata nel vecchio testamento, è sostanzialmente biblica.
Fin qui quanto si poteva dire 25 anni fa. Cosa è successo da allora?
Basta riferirsi alla situazione della letteratura per captare quella architettonica. La letteratura ebraica ha prevalso negli Stati Uniti a seguito della crisi e del crollo dei valori illuministici su cui si fondava. Annientati i miti dell’uguaglianza e della felicità, tutti gli americani si sono sentiti spaesati e frustrati, e ha prevalso il gruppo che da sempre, senza eccezione, era stato frustrato e spaesato, quello ebraico. Lo stesso è avvenuto molto dopo in architettura, in modo così inatteso ed esplosivo che molti non se ne sono ancora accorti.
Il razionalismo si è consumato con la guerra. Un solo architetto ne ha preso coscienza: il protagonista e il leader del movimento internazionale razionalista, Le Corbusier. La Chapelle de Ronchamp del 1950 è un urlo informale contro le illusioni illuministiche, rinnega tutti i principi promulgati dallo stesso Le Corbusier sin dal 1922: la casa su pilotis, il volume in aggetto, la pianta libera, la finestra in lunghezza, il tetto-giardino, la griglia, il Modulor. Nessun “ordine”, nessuna “ripetizione” in questo impero dello spazio-luce. Un’integrale rivoluzione comunicativa, incompresa persino dai diretti discepoli del maestro svizzero-francese. L’architettura del mondo, inclusa quella di Israele, procedette come se nulla fosse successo.
Fino al 1988, il razionalismo, nella scadente versione dell’International Style, si diffonde, malgrado varie eccezioni che non riescono però ad alterare gli orientamenti culturali. Sono eccezioni: l’Opera di Utzon nella baia di Sidney, il Terminal TWA nell’aeroporto di New York plasmato da Eero Saarinen, l’Habitat ’67 a Montréal del giovanissimo canadese Moshe Safdie, i prodotti della scuola americana di Bruce Goff. L’espressionismo riacquista cittadinanza in Germania con Hans Scharoun, con Michelucci e Ricci in Italia, John Johansen negli Stati Uniti, Reima Pietilä in Finlandia.
Il movimento organico procede ma, all’improssivo, nel 1980, qui alla Biennale di Venezia, il suo sviluppo viene ostacolato dal forsennato tentativo di anchilosare la storia tornando al passato. Il cosiddetto Post-Modern rappresenta l’estremo conato di riesumare il fascismo, condendolo di salsa anarcoide e autoindulgenza tradizionalista. Questa droga si protrae più o meno per otto anni, che servono a preparare i capi della riscossa, Peter Eisenmann ebreo, Richard Meier ebreo, Frank O. Gehry ebreo, Zvi Hecker e Daniel Libeskind ebrei, Lawrence Halprin ebreo, ed altri.
Nel 1988 si apre a New York, nel Museum of Modern Art, la mostra sull’architettura decostruttivista che, nel giro di 24 ore, spazza via i detriti puteolenti del Post-Modern scomparso nella vergogna, tanto che sembra che non sia mai esistito.
In quest’ultimo decennio si verifica l’evento epocale. L’obiettivo perseguito da almeno 5.000 anni, dall’età delle caverne, è raggiunto.
L’architettura della libertà, attiva nell’età paleolitica, e coartata dagli ordinamenti neolitici, dai mondi assiro-babilonese, egizio, greco e romano, riemersa nel tardo-antico, specie nel periodo catacombale, repressa dai bizantini ma poi riaffiorante nei linguaggi frantumati dell’Alto Medioevo e del traballante Romanico, schiacciata di nuovo dal Gotico e dal Rinascimento, premente nel Barocco ma subito congelata dal Neoclassicismo, l’architettura dell’emancipazione espressionista, ibernata dal razionalismo e dal Post-Modern, finalmente prevale, vince, trionfa spontaneamente quasi senza combattere, aprendo così il capitolo dello spazio e non-spazio ebraico.
Le caratteristiche del decostruttivismo sono poche, semplici e radicali.
Primo. Inverano quanto diceva Heschel, la teologia del luogo comune, il modo con cui gestiamo il quotidiano. Non vi sono ideologie, proclami, manifesti decostruttivisti. Siamo affrancati da qualsiasi astrazione idolatrica.
Secondo. Nel passato l’architettura, più che riflettere le esigenze della vita, le ha mascherate a fini compensatori. Più il potere s’incrinava e minacciava di precipitare, più i suoi edifici erano monumentali.
Più le crisi economiche imperversavano, più venivano celate dietro palladiane evasioni. L’architetto poteva essere uno psicopatico da rinchiudere nella neuro ma, quando sedeva al tavolo da disegno, diventava olimpico, oggettivo, librato sopra le vicende terrene. Ebbene, i decostruttivisti hanno rotto l’incantesimo, rivendicando il diritto al “progettare disturbato”, a un’architettura che non sia solo consolatoria.
Hanno rinunciato al bello, a favore del significativo.
Terzo. Fra i decostruttivisti non c’è nessuno che si dichiari decostruttivista, anzi tutti snobbano e dileggiano il termine. Non vogliono un movimento per l’emancipazione dello spazio; lo emancipano nei fatti. Non proclamano principi nuovi; annientano quelli che ci sono. Rivendicano una scrittura architettonica di “grado-zero”, che agisca in una zona bianca, neutra, sotto quella del potere e sovrastante quella dei vernacoli; un’architettura scorrevole come lo yiddish, impura e contaminata. Frank Lloyd Wright l’aveva profetizzato nel 1924, parlando ad un architetto ebreo, Erich Mendelsohn: “L’architettura del futuro sarà, per la prima volta nella storia, interamente architettura, spazio in se stesso, senza prescrizioni”. Il futuro è arrivato, impegnato e splendente, 64 anni dopo.
La scuola a Berlino di Zvi Hecker, il Guggenheim di Frank O. Gehry a Bilbao, l’ala ebraica del museo di Berlino e l’ampliamento del Victoria & Albert Museum a Londra di Daniel Libeskind sono tra le opere più eloquenti dello spazio non-spazio ebraico contemporaneo. Il pensiero ebraico, cui aderiscono e contribuiscono moltissimi non-ebrei, è in testa e guida la cultura. Ovviamente, nessuno degli architetti citati sottoscriverebbe quanto dico sull’attuale leadership ebraica. Hanno paura di separarsi dagli altri, temono un nuovo antisemitismo, sottostanno alla mentalità della generazione precedente, secondo la quale agli ebrei convenivano l’understatement e il sottovoce. Ma, dopo la Shoà, tale raffinata delicatezza è assurda.
Per concludere, una nota provocatoria. Quale linguaggio adottare progettando e costruendo oggi? Rispondo paradossalmente: lo yiddish.
Conferma il compositore jazz di New York, Uri Caine, sfidato a confrontarsi con la musica di Mahler. Ne inala ed assorbe tutte le componenti triviali, musiche da ballo, musiche popolari con campanacci, sonagli e colpi di bacchetta. Nessuna espressione gli è estranea, tutto viene cercato, rintracciato, citato, presentato e trattenuto, per poi essere annichilito con scherni e grida di dolore, fino a quando rimane soltanto la sottile melodia di un violino, suonata da un musicista esausto, ormai dimenticato nelle ceneri di una casa consunta dalle fiamme.
Cosa poteva fare Uri Caine su un Mahler che profetizza l’Olocausto?
Cosa si può fare, come si può vivere dopo l’Olocausto?
Evidente: abbracciando la modernità che fa di ogni crisi, di ogni tragedia, di ogni catastrofe, un valore. .Wright e Mahler sono, per molti versi, comparabili, e la via di Uri Caine è applicabile all’architettura: giocare su spazi e volumi è come scherzare su suoni disperati.
Questo è lo spazio non-spazio ebraico, frutto di secoli e secoli di vita miserrima e soccombente, spiritualità traboccante, fame endemica, pensiero millenario, superstizioni e credenze cabalistiche, sopportazioni di soprusi e di restrizioni perverse, persecuzioni inaudite per ferocia e ottusità, e poi danza, canto, spasmodica volontà di vivere, delirio dell’attesa messianica e, infine, capacità di ridere di sé anche sull’orlo del baratro, del massacro.
-
Consulenza per il piano-guida dell’area Belfiore-Macelli e per la progettazione del nuovo complesso ferroviario dell’Alta Velocità di Firenze.
Pubblicazione di “Controstoria e storia dell’architettura”.
“Controstoria e storia dell’architettura”
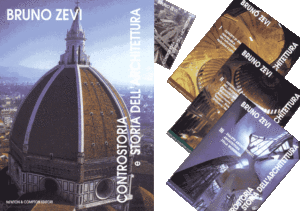 3 voll, Newton Compton, Roma 1998; riedizione di “Architettura concetti di una controstoria”, Newton Compton, Roma 1994; “Architettura della modernità”, Newton Compton, Roma 1994; “Controstoria dell’architettura in Italia”, 7 voll., Newton Compton, Roma 1995-1996; “Storia e controstoria dell’architettura in Italia”, Newton Compton, Roma 1997.
3 voll, Newton Compton, Roma 1998; riedizione di “Architettura concetti di una controstoria”, Newton Compton, Roma 1994; “Architettura della modernità”, Newton Compton, Roma 1994; “Controstoria dell’architettura in Italia”, 7 voll., Newton Compton, Roma 1995-1996; “Storia e controstoria dell’architettura in Italia”, Newton Compton, Roma 1997.
1999
Lapide ai fratelli Rosselli
Lapide ai fratelli Rosselli
 Roma, via delle Convertite
Roma, via delle Convertite
Scriveva Massimo Mila: con la Settima è l’idea di gioia che s’impadronisce di Beethoven: “quasi un adeguamento alla condizione divina”.
Carlo Rosselli prediligeva questa sinfonia sopra ogni altra. Per questo, le note della Settima scandirono il suo funerale a Parigi nel 1937, quando, tra un’immensa folla inorridita dal crimine fascista, seguiva il feretro Aldo Garosci portando un cuscino con i cimeli della guerra di Spagna.
La Settima accompagnò il percorso sinuoso di Piazza della Signoria a Firenze, quando la salma di Rosselli da Bagnoles de l’Orne tornò in Italia.
La Settima suona oggi a Roma perché, a cento anni dalla nascita e a sessantatre dall’assassinio, Carlo Rosselii giunge finalmente nella capitale che lo ha sistematicamente ignorato.
Evento significativo quello di oggi che il Presidente della Repubblica voleva siglare con la sua presenza, per onorare non solo uno dei massimi eroi della storia antifascista, ma anche il protagonista del liberalsocialismo, ispirazione essenziale del movimento “Giustizia e Libertà” e del Partito d’Azione.
Abbiamo organizzato questa cerimonia in modo semplice e breve. Apre Nicola Terracciano, dirigente del ricostituito Partito d’Azione Liberasocialista, leggendo alcune frasi dei messaggi rosselliani.
Poi, tra tutti gli ospiti venuti dall’estero, avrà la parola una sola persona, la prof.ssa Ekaterina Naumova, in rappresentanza di 46 deputati russi che si riconoscono nel pensiero di Rosselli e sono convinti che l’itinerario dal comunismo alla democrazia passi attraverso la stazione del liberalsocialismo.
Parlerà subito dopo un leader prestigioso di “Giustizia e Libertà” e del Partito d’Azione, Vittorio Foa, uno dei pochi rimasti, con Norberto Bobbio, dopo la scomparsa di Leo Valiani. E chiuderà la riunione l’Assessore alla Cultura del Comune di Roma.
Quando vuole, subito o più tardi o alla fine, a nome del Presidente Ciampi che si trova a Foggia, il Presidente del Consiglio dei Ministri o Vittorio Foa scoprirà la lapide che ricorda i fratelli Rosselli sulla casa in cui nacquero Carlo cento e Nello novantanove anni fa.
È tutto.
Nicola Terracciano legge Rosselli.
Ha la parola per un telegrafico saluto la professoressa Ekaterina Naumova, che rappresenta un gruppo di deputati russi.
La parola è adesso a Vittorio Foa.
Ha la parola in chiusura l’Assessore alla cultura del Comune di Roma.
Fatemi terminare questa riunione con un brevissimo accenno ad un aspetto nascosto, quasi inedito, della personalità di Carlo Rosselli: il suo essere ebreo.
Dell’ebraicità di Nello sappiamo tutto: la sua partecipazione critica al congresso sionista, la sua appartenenza alla comunità israelitica fiorentina, il suo coinvolgimento nei costumi della tradizione avita.
Carlo, invece, divorato dalla lotta rivoluzionaria contro il fascismo, non ebbe né tempo né occasioni per occuparsi di ebraismo. Eppure il suo animus denuncia un’impronta tipicamente ebraica.
Era accanitamente contro l’idolatria e contro il dogma. Combatteva gli idoli del liberalismo e quelli del socialismo, i dogmi marxisti della cultura di massa, della classe operaia egemone, della dittatura del proletariato, come i molteplici dogmi del capitalismo. Era contro tutti per realizzare pienamente i suoi ideali e se stesso.
Dice Martin Buber, il filosofo degli chassidim: “ognuno, in Israele, ha l’obbligo di riconoscere e di considerare che lui è l’unico al mondo nel suo genere. Ogni singolo uomo è cosa nuova nel mondo e deve portare a compimento la propria natura in questo mondo”.
Ebbene, Carlo Rosselli è stato davvero unico al mondo nel suo genere, unico ad opporsi ad una concezione umiliatrice dell’individuo sull’altare di miti collettivistici, unico a portare un immediato aiuto ai democratici spagnoli, mentre i socialisti si baloccavano con teorie pacifiste e i comunisti aspettavano ordini da Mosca.
Non esiste uomo paragonabile a Carlo Rosselll nell’intero panorama europeo.
È proprio unico, diverso, eretico, estraneo alla mentalità passiva della concentrazione antifascista di Parigi, cosciente di essere “cosa nuova nel mondo”; ed ebraicamente, poiché noi non abbiamo nessun oltretomba, nessuna vita eterna, pronto a portare a compimento i suoi ideali, i suoi programmi, “la propria natura”, in questo mondo.
È tutto, grazie.
Scontro con i radicali su Le Pen.
Zevi polemico lascia i Radicali: «Vi siete alleati con i nazisti»
“la Repubblica”, 8 dicembre 1999
 Dopo vent’anni di convinta appassionata militanza, Bruno Zevi si dimette da presidente onorario del Partito Radicale. «In quel movimento –dice- non posso più stare.» Motivo della rottura è la decisione della Lista Bonino di formalizzare l’alleanza con il “Fronte Nazionale” del leader xenofobo Le Pen al Parlamento europeo.
Dopo vent’anni di convinta appassionata militanza, Bruno Zevi si dimette da presidente onorario del Partito Radicale. «In quel movimento –dice- non posso più stare.» Motivo della rottura è la decisione della Lista Bonino di formalizzare l’alleanza con il “Fronte Nazionale” del leader xenofobo Le Pen al Parlamento europeo.
L’intesa, che per i radicali è puramente tecnica e permette di dar vita a un gruppo autonomo, per Zevi è un «atto ripugnante» perché dà diritto di cittadinanza a una forza «nazista e intollerante».
In una lettera inviata a Marco Pannella, Zevi ricorda di aver già sollevato il problema all’ultimo congresso radicale, era luglio scorso, ed oggi «voi vittoriosi ed io soccombente, mi trovo a dover scegliere tra il Partito Radicale, tecnicamente alleato ai nazisti, e il popolo ebraico. Non ho esitazioni; scelgo la parte delle vittime dei campi di sterminio. Del resto, la presidenza d’onore del Partito Radicale, tenuta da un ebreo, potrebbe disturbare i vostri alleati tecnici».
«Con grande dolore, credo che la sua decisione vada accettata», commenta Pannella. E Bonino: «Spero che Bruno ci ripensi, si è trattato solo di un grandissimo equivoco».
Bruno Zevi, 81 anni storico protagonista del dibattito sull’architettura italiana nel secondo dopoguerra, ha militato durante il fascismo nel movimento “Giustizia e Libertà” e nel Partito d’Azione.
2000
Lettura della sua prolusione al Congresso Nazionale In/arch del 20 gennaio 2000, organizzato per festeggiare i 40 anni dalla fondazione dell'Istituto.
Prolusione al congresso In/arch 20 gennaio 2000
Il secolo scorso, segnato dal genio di Einstein, ci ha lasciato in eredità un suo interrogativo così espresso nel 1952:
Fin qui il nostro concetto di spazio è stato associato alla scatola. Ci si accorge però che le caratteristiche formative dello spazio-scatola sono indipendenti dallo spessore delle pareti della scatola. Non sarebbe dunque possibile ridurre a zero questo spessore, senza che si abbia per risultato la perdita dello “spazio”? Tale passaggio, al limite, sembra ovvio… uno spazio senza scatola, autonomo. Questa idea può essere formulata drasticamente: se la materia dovesse scomparire, rimarrebbero ancora lo spazio e il tempo come un continuum quadridimensionale oggettivamente inscindibile. Si è resa quindi necessaria un’altra idea: l’evento localizzato non soltanto nel tempo, ma anche nello spazio.
La profezia di uno spazio determinato dall’evento, svincolato dalla scatola, autonomo, immateriale, capace di offrire simultaneamente sicurezza e trasparenza si proietta nel nuovo millennio in chiave politica, sociale, filosofica, architettonica e umana. Uno spazio non più contenuto in un involucro senza spessore, libero da ogni involucro. È un sogno e un obiettivo.
Cari amici dell’In/arch, autorità, signore e signori,
a distanza di 40 anni dalla fondazione del nostro Istituto, credo di essere in grado di fare una prolusione al congresso, ma non so come cominciare. Ci sono tre o quattro modi di iniziare il discorso, e io ve li sottopongo in modo che scegliate voi secondo il vostro gradimento.
Il primo inizio è in chiave politica, e suona cosi’:
Cari amici,
il governo di centro-sinistra rischia di crollare per mancanza di fantasia e di vitalità della maggioranza che lo sostiene. Per quanto attiene alle politiche del territorio, alla cultura delle città, all’ambiente e all’architettura di qualità, il governo di centro-sinistra si è differenziato dai precedenti solo in due cose: nella demolizione di pochi edifici abusivi, e in un’infinità di chiacchiere, alcune belle ma comunque prive di conseguenze, dell’on. Veltroni e dell’on. Melandri.
Francamente, il disegno di legge recante disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica e urbanistica, presentato dall’on. Melandri, va sdegnosamente rifiutato, perché la direzione dell’architettura prevista non è affidata ad una personalità libera, di prestigio, com’è in Francia quella di François Barré, ma può essere incarnata anche da un burocrate selezionato dal mazzo dei Sisinni. Tante grazie, on. Melandri, si tenga la sua legge.
Il secondo inizio è in chiave amministrativa e recita così:
Cari amici dell’In/arch,
il nostro congresso si apre quasi alla vigilia delle elezioni regionali del 26 marzo. Le forze di sinistra si dimostrano del tutto indifferenti, ciniche, irresponsabili sulla necessità di mutare rotta acquisendo una fisionomia credibile. I candidati della sinistra sono largamente privi di fascino e di carisma. Hanno malgovernato o non-governato in questi anni, non esprimono alcuna autocritica e persino in casi come il Lazio, che comprende una capitale sull’orlo della catastrofe, dichiarano di non voler cambiare. Del Giubileo sappiamo una sola cosa sicura: che alla fine dell’anno, in pieno e clamoroso disastro, il Sindaco di Roma sorridente non si dimetterà, anzi ci comunicherà che tutto è andato nel modo migliore.
Il terzo inizio della mia prolusione è in chiave culturale:
Cari amici,
apriamo il congresso in stato di prostrazione della professione e, ancor più, della scuola. La professione si strascina ed è 50 anni indietro rispetto alla cultura avanzata. La scuola è 100 anni indietro.
Del resto, lo stato depresso dell’architettura riflette a perfezione il clima depresso della società. Mentre i Presidenti della Repubblica francese si sono sempre impegnati sui valori ambientali e edilizi, mentre in Inghilterra Tony Blair interviene continuamente a favore di un’architettura di qualità, in Italia nessun leader, nessun uomo di Stato, nessun Presidente della Repubblica, nessun Ministro, nessun Senatore, nessun deputato, nessun Presidente della Regione, nessun Sindaco si occupa e preoccupa di problemi ambientali e/o architettonici, se non in qualche accenno dei comizi domenicali.
È logico che la professione langua e perda terreno. Scrivendo un libro sui capolavori del XX secolo, mi sono accorto, con viva sorpresa, che l’Italia ha prodotto, dall’esposizione di Torino del 1902 alla stazione di Firenze, a Sabaudia, alla casa del fascio a Corno di Terragni, alla villa Malaparte a Capri di Libera, al Memorial alle Fosse Ardeatine al villaggio La Martella presso Matera di Quaroni, al Forte Quezzi a Genova di Daneri e via dicendo, molti più capolavori di quanto ci si potesse aspettare. Ma perché? In un contesto politico in cui le doti creative venivano represse e punite in scala urbanistica e nell’impegno di un’edilizia significativa per il popolo, gli artisti-architetti si rifugiavano nella ricerca spasmodica del perfetto e del sublime, nel messaggio unico dei particolari della scrittura. Un capolavoro di Nervi a Orbetello, un capolavoro di Morandi nel salone sotterraneo di Torino, un capolavoro di Scarpa a Verona, un capolavoro di Albini a Genova, testi tragici sotto il profilo biografico, brama di eccezione lirica, conseguente alla strada sbarrata della prosa democratica.
Ecco i tre modi, politico, amministrativo e culturale di cominciare la prolusione affidatami. Scegliete voi. lo opto per una quarta ipotesi e comincio davvero:
Cari amici dell’In/arch, autorità, signore e signori,
sono passati poco più di quarant’anni da quella giornata del 26 ottobre 1959 quando, al Ridotto del Teatro Eliseo in via Nazionale, gremito di architetti di tutta Italia, fondammo il nostro Istituto.
Conservo molte fotografie di quella riunione e delle precedenti patrocinate dalla sezione italiana dell’Unione Internazionale Architetti.
C’erano tutti: Pier Luigi Nervi e Adriano Olivetti, Giuseppe Samonà e Luigi Piccinato, Ernesto Rogers e Luigi Moretti. Un’atmosfera di rara tensione determinata dall’ostilità istintiva degli Ordini degli Architetti, che volevano conservare i loro monopoli, dall’ostilità della maggioranza dei costruttori, che non vedevano alcuna necessità di incontrarsi con gli architetti, dall’ostilità dei critici d’arte che non capivano perché volessimo coinvolgerli, in breve dall’ostilità di tutti coloro che sguazzavano benissimo nel pantano professionale e culturale. Lanciammo allora l’idea di una collaborazione tra economia ed arte, fra costruttori e architetti, al fine di elevare il livello della professione.
Era chiaro a tutti, nell’ottobre 1959, che, proprio per la presenza di tante forze virtualmente ostili, noi incarnavamo la parte vincente.
Nel 1944, all’indomani della Liberazione, l’Associazione Per l’Architettura Organica (APAO) aveva rappresentato l’impulso e l’urto rivoluzionario. Per merito di cinquanta, cento, duecento architetti organici sparsi da Torino a Palermo, l’Italia fu reinserita nel circuito dell’architettura mondiale, superando l’isolamento fascista. Eravamo gli orfani di Edoardo Persico, di Giuseppe Pagano e di Terragni, ne impersonavamo l’eroica eredità, eravamo decisi a non permettere più che l’Italia fosse la terra della restaurazione, dell’accademia, dell’anticultura. Nei primi due concorsi del dopoguerra, quello per il Memorial alle Fosse Ardeatine e quello per il blocco frontale della stazione Termini, il movimento moderno prevalse contro tutte le scorie della dittatura totalitaria. Eravamo la nuova generazione dei leader che dal 1952 aveva conquistato il potere nell’Istituto Nazionale di Urbanistica.
Adesso, nel 1959, con l’In/arch trovavamo lo strumento idoneo per orientare una stagione di prosperità edilizia. Il fronte milanese, che si era sottratto all’esperienza organica, si sfaldava, e i migliori venivano con noi. Dal 1948 l’avamposto veneziano di Samonà drenava le intelligenze e fungeva da cuneo nel panorama dell’insegnamento universitario. Nel campo dei libri, i nostri prevalevano. Praticamente, dominavamo tutta la pianificazione dall’alto con l’INU e quella dal basso con Danilo Dolci. Grazie a Ugo La Malfa e a Fiorentino Sullo, partecipavamo alla commission nazionale di programmazione economica.
In questo quadro, l’In/arch era necessario, anzi indispensabile per la vita dell’architettura e degli architetti. Facemmo bene a fondarlo e dirigerlo. Avete fatto bene, anzi benissimo a rinnovarlo, svincolandolo da ogni patrocinio e conducendolo fino a questo appuntamento nell’ambito di una politica di centro-sinistra.
Ed ora, veniamo al nocciolo. L’architettura è sostanzialmente cambiata in questi ultimi anni, in particolare dal 1988, dalla mostra del decostruttivismo al MoMA di New York. L’In/arch ha resistito con magnifica energia all’ondata reazionaria del Post-Modern dilagante negli anni Ottanta. Spazzata via la vergogna post-modernista, è spalancato al futuro.
Una nuova pagina si è aperta all’architettura, anche se solo poche decine di architetti nel mondo ne sono pienamente coscienti. La nuova epoca è caratterizzata da un nuovo costume professionale, da nuovi strumenti progettuali e, segretamente, da nuovi ideali.
Cosa e accaduto? Possiamo riassumerlo in cinque punti:
l. si è concluso un ciclo di circa 5.000 anni, dall’età delle caverne al decostruttivismo, durante i quali il linguaggio degli architetti ha costantemente oscillato tra il mondo autoritario delle regole e quello trasgressivo della libertà creativa. All’informale paleolitico ha fatto seguito il geometrismo neolitico; i rigidi “ordini” greci sono stati contestati dagli arbitri ellenistici; il monumentalismo classico romano è stato smentito dalla civiltà adrianea e dal tardo-antico; nei percorsi senza fine delle catacombe si è raggiunto il “grado zero” della scrittura architettonica, privo di ogni stasi spaziale; dopo il bizantinismo, nuovo “grado zero” nell’informale dell’Alto Medioevo; poi, la splendida stagione anticlassica, romanica e gotica, che si prolunga fino a Brunelleschi compreso. I velleitarismi classicheggianti della scuola albertiana vengono presto riassorbiti dai morsi spietati del manierismo, da Bramante a Michelangiolo, da Vasari a Palladio; e da allora, incessanti contrasti tra un potere accademico che vorrebbe livellare, istituzionalizzare, omologare, e l’impeto rivoltoso degli autentici artisti. Dal 1851 il movimento moderno segna tappe di progressive aree di libertà, contese dai conservatori che vorrebbero fermare lo sviluppo e tornare indietro. Quando esplode con Frank Lloyd Wright l’epopea organica, la viltà compie l’ultimo tentativo di fare retrocedere la storia e, negli anni Ottanta, invade il campo con il purulento post-modernismo.
Ma, già nel 1988, inaspettatamente, quasi per miracolo, il pendolo reazione-libertà si sottrae alla sua legge genetica scegliendo la libertà.
2. cinquemila anni di storia autoritaria sono così liquidati. Non restano che gli atti creativi, le eccezioni alle regole. Gli architetti restano senza precetti, ordini, proporzioni, ritmi, equilibri, bilanciamenti, simmetrie, cadenze ripetitive, modelli prescrittivi, moduli da imitare, dogmi e tabù da rispettare. L’intero apparato delle convenzioni e delle abitudini risulta estirpato. Dalla sera alla mattina, vince solo la deroga, l’abnorme. I tavoli da disegno vanno al macero, perché quel disegno non serve più; giganteschi falò di righe a T, squadre, tecnigrafi, compassi liberano gli studi professionali. Si lavora con il computer che ignora la linea dritta, il parallelismo, l’angolo retto, l’uniformità e lo standard. Sconfitti i velleitarismi uguagliatori, trionfa la diversità e la ricerca di identità diventa costume di vita.
3. Durante i cinquemila anni, ogni spirito creativo è stato combattuto dall’accademia: Brunelleschi, Michelangiolo, Borromini fino al suicidio, Persico e Terragni fino alla disperazione. Ma, dagli anni ‘9O, il fenomeno si è rovesciato. Un Frank O. Gehry o un Daniel Libeskind possono inventare gli impianti e le strutture più improbabili e folli, le giurie dei concorsi internazionali li scelgono e li premiano, la committenza li approva e conferma, il pubblico sia degli esperti che dei profani plaude. Conclusi i cinque millenni si è davvero voltata pagina.
4. Nasce una nuova architettura sul terreno disastrato dalle scorie di cinquemila anni di compromessi. Le scuole di architettura chiudono o dovrebbero chiudere, perché non c’è più nulla da insegnare. I laureati, infarciti di nozioni sgangherate e arbitrarie, devono sforzarsi di dimenticare tutto quanto hanno imparato, e di negare metodicamente tutto ciò in cui credono. Gli studenti di architettura barcollano istupiditi, storditi dalle elucubrazioni verbali di docenti che non hanno più nulla da dire.
5. Siamo all’alba di una nuova civiltà, la cui luce non è destinata ad oscurarsi. Non si alimenta di orientamenti linguistici, ma di esperienze sociali. La nuova architettura incarna la democrazia, giustizia e libertà, il liberalsocialismo con le sue contraddizioni, la sua cacofonia, la sua affabilità al caos. Il suo avvento ha coinciso con fatti epocali inattesi e quasi miracolosi: la fine del comunismo sovietico senza guerre e crisi catastrofiche; la caduta del “muro” e l’unificazione delle due Germanie; la sinistra finalmente al potere anche in Italia, lo sviluppo inaudito delle scienze, delle tecniche e delle arti; il crollo delle concezioni collettivistiche e delle ideologie sovrastrutturali. Al confronto con eventi di tale portata, l’architettura non poteva sottrarsi al compito di essere un’architettura di eventi. Il tempo di qualsiasi “rappresentazione” è scaduto. Si recita a soggetto, in diretta.
Cade la stessa nozione di “progetto” quale si è maturata nella tradizione, e suona quasi ridicola quella “cultura del progetto” sulla quale si sono versati fiumi di parole fino alla penultima decade del XX secolo. È come una macroscopica spazzatura di pseudoconcetti e teorie astratte, attuata nel giro di pochi giorni. Non c’è più un “progetto” da realizzare; adesso l’architettura viene progettata realizzandola, nel corso del suo formarsi. Di tutte le costruzioni pensate, una volta aboliti criteri, principi e metodi, cosa rimane? Immagini sognanti, vaghe e mobili, simili alle “città invisibili” di Calvino.
– Ecco i cinque principali connotati dell’architettura del terzo millennio. Rispetto al passato, la rottura è categorica ed integrale. Ma del passato restano, non più vincolanti:
i cinque principi di Le Corbusier: la pianta libera, la struttura in aggetto, i pilotis, la finestra in lunghezza, il tetto-giardino. Ma si possono buttar via, come ha fatto lo stesso Le Corbusier nella Chapelle de Ronchamp;
il principio di Theo van Doesburg e Mies van der Rohe della decomposizione del volume in lastre da riassemblare ma senza riformare la scatola;
la poetica cézanniana di J.J.P. Oud, un purismo nativo, sottratto alle torture linguistiche di “De Stijl”;
l’impeto materico di Mendelsohn , Häring, Scharoun e Steiner nel contorcere, spremere il masso, quasi fosse investito da una tempesta di vento all’interno e all’esterno, e la sua “pelle” risultasse da questa duplice pressione;
la concezione degli spazi catapultati da Wright, da dentro al fuori, e raccolti da un contesto ambientale assonante;
la casa nel paesaggio, quello delle periferie urbane e quello incondito, selvaggio;
l’immersione nei segni e segnali della metropoli derelitta e vitale e dell’autostrada slittante nel territorio;
il brutto, il rifiuto, il “cheapscape” di Frank Gehry, il panorama degli sfasciacarrozze, l’anarchitettura di Gordon Matta-Clark, il caso e il silenzio di John Cage trasferiti in sede edilizia.
In breve, restano le poetiche e gli strumenti mediante i quali si è decostruito e distrutto il mondo regolamentato di cinque millenni, aprendo la strada all’esplosione dell’individuo e dei suoi rapporti con gli altri.
Sono disponibili:
– l’architettura “di sezione” di Alvar Aalto, con lo spaccato dell’aula magna esibito;
– la scrittura di Jean Renaudie, che censura ogni angolo retto per accentuare l’interconnessione dinamica tra i vari ambienti;
– i segni slabbrati e contorti, in perpetuo stato di ebollizione, di Reima Pietilä, che in Finlandia parla case popolari e residenze presidenziali con lo stesso linguaggio;
– gli aggetti, i gusci, le membrane di Bucky Fuller, Pierluigi Nervi, Riccardo Morandi, Felix Candela e Sergio Musmeci;
– gli intrecci tra strutture e luci di Guarino Guarini;
– l’interpenetrazione di figure geometriche in Francesco Borromini;
– i progetti “espressionisti” di Michelangiolo, specie le mura fiorentine del 1529;
– l’anticlassicismo palladiano di Palazzo Valmarana, della Loggia del Capitanio, de “La Malcontenta” e del Redentore;
– la sproporzione brunelleschiana nella cupola del duomo di Firenze, nei vuoti degli Innocenti, nelle colonne centrali e nei tronchi di trabeazione a Santo Spirito;
– il travolgente raggiro di strade della Siena medievale, le piazze e quella del Campo;
– le affaticate volte a crociera di Sant’Ambrogio di Milano, che bruciano impianti sostanzialmente bidimensionali;
– il cosiddetto Tempio di Minerva Medica che offre un dialogo tra il dentro e il fuori premendo sui suoi nicchioni;
– l’incredibile anticlassicismo dell’Eretteo nell’acropoli ateniese, con le sue sfasature altimetriche, la diversità delle sue facciate e dei suoi ordini, lo scarto dei suoi spazi;
– infine, i vocaboli primordiali, il “menhir”, “il dolmen”, la caverna, il recinto, il villaggio.
Tutto questo non è più “dato” che pesa e condiziona la fantasia architettonica. È un mondo da riscoprire in funzione della creatività moderna, quando e dove serve a stimolarla.
Spente ed esaurite le ideologie, mancano i “manifesti” programmatici, sia individuali che collettivi. Persino un intellettuale come Peter Eisenmann rinuncia. Bernard Tchumi sembra essere sempre sul punto di emettere un manifesto, ma si ferma a tempo. Così Gehry e Libeskind, Hecker, Domenic e Behnish. Appelli come quelli della Secessione Viennese o del gruppo De Stijl sarebbero oggi inconcepibili. Perché oggi non si tratta di unificare le forze, ma al contrario di sconnetterle in omaggio alla diversità. Neppure un’associazione orientata come fu l’APAO, nell’immediato dopoguerra, sarebbe oggi calzante, quando l’obiettivo consiste nel disfare il vecchio più che nel produrre il nuovo.
Per concludere, l’architettura che ci sta davanti riflette l’universo di Albert Einstein, Sigmund Freud, Carlo Rosselli, Arnold Schonberg, Frank Lloyd Wright. Dominando l’ideologia della cultura di massa, della standardizzazione, della prefabbricazione, “la sovranità dell’individuo” promulgata da Wright sembrava un concetto arretrato, ottocentesco, idillico ed evasivo. Con l’ideologia della classe operaia egemone, della dittatura del proletariato, della collettivizzazione dei costumi e delle coscienze, il messaggio liberalsocialista di Carlo Rosselli sembrava anacronistico e ritardatario. Non è stato così. Hanno vinto Wright e Rosselli, hanno perso i loro avversari. Pochi protagonisti hanno salvato il mondo e noi dobbiamo celebrarli.
Ho finito. Leonardo insisteva sulla necessità di tener conto delle nebbie, delle foschie, delle sbavature, delle albe, delle piogge, del clima ingrato, del caldo e delle nuvole, degli odori, tanfi e profumi, della polvere, delle ombre e delle trasparenze, degli spessori soffici e quasi sudati, delle evanescenze fuggevoli. Amici dell’In/arch, adesso l’architettura è attrezzata per captare tali valori.
Pubblicazione di "Capolavori del XX secolo"
2001
Pubblicazione di "Tutto Zevi".
-
Commemorazione del primo anniversario della scomparsa alla Protomoteca del Campidoglio a Roma.
-
Commemorazione della scomparsa a Reggio Calabria.
-
Commemorazione della scomparsa a Venezia.

 English
English