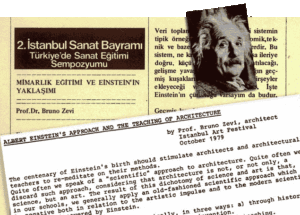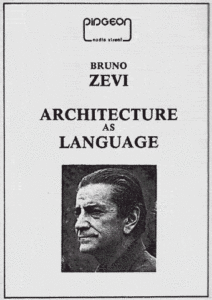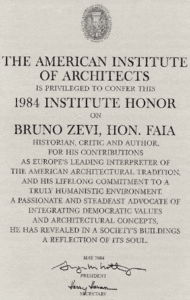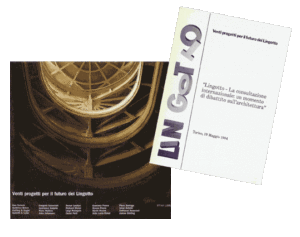Biografia: 1978-1989
1978
Relatore al XIII congresso mondiale dell’UIA a Mexico City, durante il quale contribuisce a fondare il CICA (Comitato Internazionale dei Critici d’Architettura).
Comité lnternational des Critiques d’Architecture (CICA)
 Per decenni segretario generale dell’Unione Internazionale Architetti (UIA) e ora presidente d’onore, Pierre Vago propone un’iniziativa volta a elevare il livello culturale della massa degli architetti raccolti ogni tre anni nei congressi mondiali. Ci incontriamo a Mexico City e, il 26 ottobre 1978, formuliamo la seguente dichiarazione, che è alla base del CICA:
Per decenni segretario generale dell’Unione Internazionale Architetti (UIA) e ora presidente d’onore, Pierre Vago propone un’iniziativa volta a elevare il livello culturale della massa degli architetti raccolti ogni tre anni nei congressi mondiali. Ci incontriamo a Mexico City e, il 26 ottobre 1978, formuliamo la seguente dichiarazione, che è alla base del CICA:
1. Siamo convinti che la collaborazione e il dialogo tra i professionisti e i critici debbano essere organizzati in funzione permanente nell’ambito dell’Unione Internazionale Architetti.
2. Crediamo che critica e giudizio di valore debbano essere riconosciuti come inerenti al processo architettonico, dallo stadio programmatico ai dettagli più minuti del design. La critica architettonica non è più concepita come un tribunale, dove i critici sono i giudici e gli architetti le vittime da giudicare e spesso da biasimare.
3. Vogliamo sottolineare che le considerazioni economiche, tecnologiche e socio-culturali non bastano a creare un’architettura investita di tutti i valori che sono essenziali alla società. Una migliore qualità della vita, il potere creativo, l’espressione immaginativa individuale e collettiva sono necessari. Il compito della critica architettonica non è solo quello di riconoscere e selezionare, ma anche quello di stimolare questo tipo di creatività in antitesi alle restrizioni burocratiche e ai tabù accademici.
Il documento fu firmato da me, Max Blumenthal (direttore di «Techniques & Architecture», Parigi), Louise Noelle Gras de Mereles (condirettrice di «Arquitectura», Mexico), Mildred F. Schmertz (direttore associato di «Architectural Record», New York), Blake Hughes (USA) e Jorge Glusberg (direttore del CAYC di Buenos Aires, che sarà l’anima organizzativa del CICA).
Tra le adesioni più rilevanti, Julius Posener (Berlino), Dennis Sharp (direttore della rivista dell’Architectural Association, Londra), Moniek Bucquoye (direttore di «Neuf», Bruxelles), Mario Gandelsonas (direttore di «Oppositions», New York), Elémer Nagy (condirettore di «Magyar Epitomuvészet», Budapest), Toshio Nakamura (direttore di «A+U», Tokyo), Marina Waisman (direttrice di «Summa», Buenos Aires), Lance Wright (direttore di «The Architectural Review», Londra).
L’annuario CICA del 1987, pubblicato dal CAYC di Buenos Aires, elenca 70 membri, tra i quali Giulio Carlo Argan, Rudolph Arnheim, André Chastel, James Marston Fitch, Ada Louise Huxtable, Lewis Mumford, Joseph Rykwert, che saranno raggiunti da altri, come Peter Davey (nuovo direttore della londinese «The Architectural Review») e Kenneth Frampton.
L’attività del CICA è scandita da interventi clamorosi nell’ambito dei congressi mondiali dell’UIA: Varsavia, giugno 1981; Cairo, gennaio 1985; Brighton, luglio 1987; Montréal, maggio 1990. La relazione «Il Grado Zero della scrittura architettonica» tenuta a Varsavia, è pubblicata in “Pretesti di critica architettonica”, Einaudi, Torino 1983. Delle riunioni tenute dal CICA a Barcellona, Buenos Aires, New York, Berlino, Parigi, Vienna, Sofia ha dato sistematica notizia la rivista «L’architettura – cronache e storia».
Cosa c’è dietro la mia presidenza del CICA, rinnovata ogni triennio, da Mexico City a Montréal? Può esser detto con le parole di George Steiner tratte dallo stupendo libro “Language and Silence”, in cui si precisano tre compiti della critica contemporanea:
1) cosa rivisitare e come. Siamo eredi di un patrimonio immenso e dobbiamo scegliere o sottolineare quanto entra in dialogo diretto con il presente. Ogni generazione seleziona e il critico di valore «sente prima degli altri» ;
2) connettere, superando le barriere ideologiche e politiche, combattendo lo sciovinismo. «Il critico non è uomo che può vegetare nel suo giardino»;
3) formulare giudizi sull’arte attuale, non solo in termini tecnici ed estetici, ma in chiave di ciò che «contribuisce o detrae alle deperite riserve dell’intelligenza morale… La nostra epoca non è ordinaria. Avanza sotto l’angoscia dell’inumano, sperimentato in una scala inedita di grandezza e orrore. Ci sono piaceri di distacco che uno vorrebbe concedersi, ma non può».
Credo che tutte le lotte contro l’accademismo, il postmoderno, l’irresponsabilità più o meno lucida, la ricostruzione classicistica del Teatro Carlo «Infelice» a Genova, il piano della 167 a Roma, siano state condotte sotto l’impulso dell’intelligenza morale.
Fonda e dirige la collana “Universale di Architettura” per le edizioni Dedalo, che fino al 1985 pubblica 73 titoli.
Prolegomeni a una “Universale di Architettura”
 Il progetto concordato con Raimondo Coga delle edizioni Dedalo di Bari, era vasto e ambizioso. Comprendeva monografie su monumenti, artisti, città, territori, problemi teorici, aspetti del design. Al confronto, quanto è stato realizzato dal 1978 al 1985 appare davvero modesto, una mera prefigurazione di quella che potrebbe essere un’“Universale”. Tuttavia i 73 numeri della collana includono opere fondamentali.
Il progetto concordato con Raimondo Coga delle edizioni Dedalo di Bari, era vasto e ambizioso. Comprendeva monografie su monumenti, artisti, città, territori, problemi teorici, aspetti del design. Al confronto, quanto è stato realizzato dal 1978 al 1985 appare davvero modesto, una mera prefigurazione di quella che potrebbe essere un’“Universale”. Tuttavia i 73 numeri della collana includono opere fondamentali.
Ristampe e traduzioni: “L’architettura dell’umanesimo”, di Geoffrey Scott;
“Borromini: manierismo spaziale oltre il Barocco”, di Arnaldo Bruschi; “Lo spazio architettonico da Roma a Bisanzio”, di Sergio Bettini; “L’architettura protocristiana preromanica e romanica” e “L’architettura italiana del Duecento e Trecento”, di Giulio Carlo Argan; “Frank Lloyd Wright”, di Norris Kelly Smith. Saggi di particolare originalità: “Pensiero organico e architettura wrightiana”, di Edward Frank; “Gramsci e l’architettura”, di Andrea Mariotti; “Fourier e l’architettura della felicità socializzata”, di Massimo Di Forti;
“Architettura come disidentità. Teoria delle catastrofi e architettura”, di Carmine Benincasa; “Il luogo kafkiano”, di Alberto Maria Racheli; “De-architetturizzazione. Progetti e teorie 1969-1978”, dei Site;
“Baudelaire, Rimbaud e l’architettura”, di Elisa Mariani Travi:
Guide: “Pienza, tra ideologia e realtà”, di Luciana Finelli e Sara Rossi; “Benevento”, di AA.VV.; “Trani”, di AA.VV.; “Viterbo”, di Enzo Bentivoglio e Simonetta Valtieri;
“Guastalla”, di Stefano Storchi.
L’esperienza ha confermato quanto si prevedeva: esiste un enorme patrimonio di idee, di sondaggi, di indagini che s’impolverano nei cassetti, in attesa che qualcuno lo scopra, lo aggiorni e lo riediti. I veicoli: una rivista certo, ma anche un’agile «Universale».
1979
In agosto si dimette dalla Facoltà di Architettura di Roma e dal 1° novembre va in pensione con 14 anni di anticipo.
Exodus universitario
Queste dimissioni non hanno precedenti e costituiscono un atto di accusa contro:
1) il corporativismo dei professori, ordinari e incaricati;
2) la massa degli studenti che «si laurea in stato di analfabetismo»;
3) la burocratizzazione e la sclerosi degli organismi preposti all’università;
4) un’«industria culturale universitaria» sempre più squalificata e dannosa alla libera cultura. Sulla scottante questione intervengono centinaia di docenti. Molte le critiche e le invettive a questo gesto. La risposta viene in sede di assemblea del Partito Radicale ed è riprodotta nell’editoriale di «L’architettura – cronache e storia», n. 288, ottobre 1979.
Sfascio universitario e degrado culturale
Il compromesso storico funziona splendidamente. I professori comunisti, da Asor Rosa a Lombardo Radice e Sanguinetti, scattano all’unisono con i colleghi della destra, in difesa dell’«istituzione», dell’«ordine», della disciplina corporativo-burocratico-sindacale, insomma in difesa dell’acquiescenza. Non possono smentire quanto hanno affermato ritualmente, durante vent’anni, in focose e platoniche dichiarazioni; ma, dopo aver ribadito pro forma che l’università è in stato di necrosi, proclamano a gran voce che adesso si registra una ripresa, che alcuni studenti lavorano con serietà, che un po’ di ricerca e di cultura si riesce a produrre, che bisogna aver pazienza perché comunque l’università cosiddetta di massa è sempre preferibile a quella élitaria, e guai a chi l’abbandona per lanciare un allarme, invece di restare lì, sulla barca che affonda, senza alzare un dito, anzi contribuendo col peso del silenzio e dell’omertà, ad accelerarne l’inabissamento. Reazione da destra e reazione da sinistra trovano una precisa convergenza nel pantano accademico e le eccezioni si contano sulle dita, anche se annoverano nomi quali Sabino Acquaviva, Renzo De Felice, Carlo Ludovico Ragghianti, Vittorio Strada, Adriano Buzzati Traverso, Giulio Carlo Argan, Paolo Alatri, Massimo L. Salvadori e pochi altri.
Perché sento l’impulso di intervenire in questa assemblea? Perché il radicalismo si è maturato nelle battaglie degli atenei, e molti dei suoi leader, a cominciare da Marco Pannella, si sono affinati guidando il movimento degli studenti universitari. Del resto, anche nella passata legislatura, i deputati radicali sono stati coinvolti nel tema universitario e hanno coraggiosamente bloccato una delle tante leggi con cui i governi democristiani cercano di stroncare l’opposizione negli atenei, distribuendo prebende, accrescendo lo stuolo dei salariati, svigorendone e corrompendone la cultura. Ma questo non basta più. La questione universitaria assume ormai un’urgenza prioritaria. Lo ha dimostrato in queste settimane il trascurabile episodio di un professore dimessosi anticipatamente che ha riempito le prime pagine dei quotidiani e i notiziari della radio e della televisione. Perché un evento così modesto ha scatenato un putiferio? Per il semplice motivo che, in questo paese, basta che qualcuno esprima le sue convinzioni con un atto, anche minimo, pagato di persona, basta questo perché l’obbrobrio, lo scandalo universitario riesploda.
Oggi non si tratta più di «riforma», meno ancora di una riforma basata sullo slogan, privo di senso, dei dipartimenti. Occorre una rivoluzione che ristrutturi, alle radici, la didattica e la ricerca. In mancanza di questa trasformazione radicale, non solo avremo un’università degradata, inferiore a quelle peggiori del terzo mondo, ma -quel che è assai più grave- avremo una cultura mortificata e travolta dal sottosviluppo universitario. Vorrei che almeno un dato fosse chiaro: l’università italiana sta fagocitando la libera cultura, con migliaia di concorsi a cattedra; la maggior parte degli intellettuali s’invischia a vita in una macchina faraonica, irresponsabile, inagibile, culturalmente improduttiva, didatticamente assurda e ciò si ripercuote nell’attività culturale e creativa che si esplica fuori dell’università. Il paradosso è questo:
durante il fascismo, esisteva una libera cultura, impersonata da Benedetto Croce, Piero Gobetti, Carlo e Nello Rosselli, dai fuoriusciti, dai carcerati e dai confinati, da Luigi Pirandello e Aldo Palazzeschi, da architetti e critici di architettura quali Terragni, Persico, Pagano, cui era vietata la porta dell’università; noi eravamo cresciuti e abbiamo combattuto la tirannia, alimentati da quella libera cultura. Oggi, invece, la libera cultura non esiste quasi più, poiché gli intellettuali, persino i poeti, quando non sono «organici» ai partiti, quando non sono assorbiti dall’industria culturale editoriale, vengono ingoiati da un’industria anche più infeconda, quella pseudoculturale universitaria, gigantesca fabbrica di libri, libercoli, quaderni, riviste e rivistine che nessuno legge, che non hanno mercato ma servono a vincere borse di studio e concorsi a cattedra. Quando l’università diventa una mostruosa corporazione burocratico-sindacale e un mastodontico parcheggio per giovani disoccupati, il suo carattere anticulturale si estende e lentamente contagia ogni ramo della scienza. Che tale processo sia giustificabile in nome dell’università di massa è uno degli equivoci, degli alibi, più diffusi e balordi. L’università di massa da noi non esiste, esiste solo la massificazione abbrutente dell’università d’élite. La liberalizzazione dell’accesso non ha portato all’università i figli meritevoli dei contadini, dei proletari e dei sottoproletari; al più, vi ha portato, indiscriminatamente, i figli somari della borghesia urbana media e piccola. Ma, anche questo alla condizione di rimanere somari, di laurearsi in stato di analfabetismo, perché il nostro elefantiaco meccanismo universitario può a stento sopravvivere solo se la maggioranza degli studenti non segue le lezioni e i seminari, non frequenta le biblioteche e i laboratori e rinuncia a priori alle attrezzature indispensabili alla ricerca. La cosiddetta università di massa, in Italia, è un esamificio e un laureificio di massa, non una scuola di alta cultura aperta alla massa. Ad Architettura, a Medicina, a Lettere, a Magistero, a Giurisprudenza, più o meno in ogni Facoltà, poiché solo un’élite di studenti può malamente frequentare, l’università è costretta a richiedere uno standard nozionale infimo, vergognoso, l’unico compatibile con il suo assetto grottesco. La ricerca, per quel poco che si fa, si svolge nel chiuso degli istituti baronali, senza la partecipazione degli studenti e spesso neppure dei giovani docenti. Impera il burocratismo più demenziale nell’assegnazione degli incarichi d’insegnamento, mentre nei concorsi domina la lottizzazione partitica, da parte comunista non meno che da parte democristiana.
E ancora: se l’esperienza francese delle «unità pedagogiche» ha mostrato come si possano articolare le Facoltà sul territorio, quella inglese della Open University attesta che l’uso dei mass-media è lo strumento indispensabile per un’università di massa. Ma la nostra ineffabile RAI-TV rifiuta anche l’ipotesi di apprestare un’Università dell’Aria; per ore e ore del giorno e della notte non trasmette niente; ma non consente di dedicare queste ore all’insegnamento a distanza, che potrebbe davvero portare l’università alle masse di tutto il paese.
Nel salto qualitativo «dall’antagonista radicale al protagonista socialista», qualcosa bisogna fare concretamente per la cultura e per l’università, combattendo anzitutto la dilagante «reazione da sinistra» nell’arte e nell’attività intellettuale. La colpa dello sfacelo, ovviamente, è della destra, ma questo non ci interessa: la destra fa il suo mestiere. Il dramma è che la colpa è anche nostra, perché non siamo capaci di inventare le strutture di un’università di massa, non siamo capaci di rinnovare l’università statale, e non siamo neppure capaci di escogitare qualche alternativa, un’università indipendente, laica, promossa dalla sinistra e atta a stimolare la ristrutturazione di quella statale. Nella nostra azione universitaria, siamo alla bancarotta, alla perdita di credibilità. All’inizio di ogni stagione accademica, qualche rettore minaccia di non riaprire l’ateneo: cerimonia inoffensiva, che serve a scaricare la coscienza. Neppure un rettore di eccezionali doti, come Antonio Ruberti, può superare l’impasse. I piccoli rimedi, volti all’efficientismo, non intaccano la sostanza del tema. La seconda università romana, a Tor Vergata, a parte il fatto che ci vorranno dieci anni per costruirla, sarà un lager peggiore della prima.
A questo punto, l’unica speranza sta nel governo-ombra proposto dai radicali, idea-motrice caratterizzante il passaggio «dall’antagonista al protagonista». All’interno dell’istituzione universitaria non ci sono forze sufficienti a rinnovarla: non esiste un movimento dei professori di sinistra e le organizzazioni studentesche vegetano in stato di frustrazione. All’esterno, non esiste una libera, creativa piattaforma della cultura, mentre incalza una nuova accademia sostenuta dalla sinistra. Le ragioni per essere pessimisti e quindi per restare appiccicati fino a 75 anni alla propria cattedra, sono innumerevoli. Ma questa situazione non può durare, la relativa calma che constatiamo negli atenei si fonda su una prostrazione di professori e studenti, su un infiacchimento etico-culturale che preannuncia, per il domani, o il collasso definitivo o una spaventosa tempesta. Io nutro ancora un po’ di ottimismo. Credo che intorno a una proposta immaginativa e rischiosa per l’università di massa, elaborata da un governo-ombra, si possano coagulare le forze coraggiose all’interno e all’esterno dell’istituzione universitaria, impostando una battaglia dura ma, alla fine, forse vincente.
Pubblicazione di “Frank Lloyd Wright”.
“Frank Lloyd Wright”
 “La costante riscoperta di Wright”, così s’intitola l’introduzione al saggio pubblicato dalle edizioni Zanichelli nel 1979. A parte le pagine dedicategli nel mio primo libro, “Verso un’architettura organica” , Einaudi,Torino 1945, parla del maestro americano una piccola monografia del 1947 (ampliata nel 1955); pubblicata da Il Balcone di Milano. Che la riscoperta sia costante lo dimostra anche, nel presente volume, il discorso «Non si invalida l’eredità wrightiana» pronunciato alla University of Michigan ad Ann Arbour nel 1986.
“La costante riscoperta di Wright”, così s’intitola l’introduzione al saggio pubblicato dalle edizioni Zanichelli nel 1979. A parte le pagine dedicategli nel mio primo libro, “Verso un’architettura organica” , Einaudi,Torino 1945, parla del maestro americano una piccola monografia del 1947 (ampliata nel 1955); pubblicata da Il Balcone di Milano. Che la riscoperta sia costante lo dimostra anche, nel presente volume, il discorso «Non si invalida l’eredità wrightiana» pronunciato alla University of Michigan ad Ann Arbour nel 1986.
Zanichelli, Bologna 1979. Edizione tedesca, Artemis, Zurigo 1980.
1980
-
Relatore al secondo incontro internazionale del CICA a Buenos Aires (13-20 aprile).
Entra a far parte della giuria del premio CICA per la critica architettonica. -
Relatore al convegno “Dall’architettura alla cultura – Dalla cultura all’architettura” (Termoli, 5-6 luglio).
-
Relatore al Third International Meeting of Architectural Critics presso il MOMA di New York (4-7 dicembre).
Pubblicazione di “Giusepp Terragni”.
“Giuseppe Terragni”
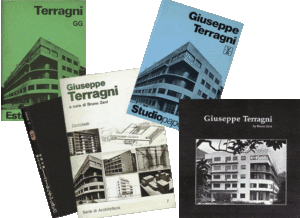 L’architetto comasco è un personaggio difficile, tormentato, struggente.
L’architetto comasco è un personaggio difficile, tormentato, struggente.
Malgrado la dittatura fascista, realizza edifici democratici ed eversivi. Di regola, riesce a evitare l’enfasi retorica degli impianti classicisti. Il suo scavo linguistico è complesso, non si limita al manieristico gioco combinatorio degli etimi dei maestri. Lo stesso Peter Eisenman, dopo gli studi pubblicati su «Perspecta» nel 1971, ha lottato per agguantare e dipanare l’enigma Terragni.
Zanichelli, Bologna 1980. Edizione inglese, Triangle, Londra 1989. Edizione spagnola, Gili, Barcellona 1981. Edizione giapponese, Kajima Institute, Tokyo 1983. Edizione tedesca, Artemis, Zurigo 1983.
1981
Discorso di conferimento della cittadinanza onoraria di Firenze a Giovanni Michelucci.
Conferimento della cittadinanza di Firenze a Giovanni Michelucci
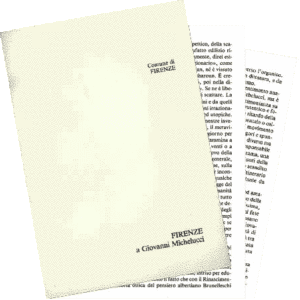 Nel 1951, esattamente trent’anni fa, in questa stessa aula, Firenze conferiva la cittadinanza onoraria al più grande architetto allora vivente, Frank Lloyd Wright, uno dei massimi geni dell’intera storia architettonica.
Nel 1951, esattamente trent’anni fa, in questa stessa aula, Firenze conferiva la cittadinanza onoraria al più grande architetto allora vivente, Frank Lloyd Wright, uno dei massimi geni dell’intera storia architettonica.
Ricordo quella cerimonia con profonda commozione. Per me costituiva un evento carico di significati: era l’Italia uscita dalla Resistenza, l’Italia e la Firenze di Carlo Rosselli, che avevano lottato per una democrazia moderna, post-fascista, in cui politica e cultura fondessero in una volontà radicale di rinnovamento, erano questa città e questo paese, ancora feriti dalle conseguenze della guerra, ad esaltare – presente Carlo Sforza, Ministro degli Esteri – un artista, un uomo, uno spirito creativo senza eguali che, rifiutando i facili slogans del collettivismo e quelli altrettanto futili dei riflussi nel privato, proclamava «la supremazia dell’individuo» quale cardine di un metodo democratico caratterizzato dalla qualità.
In termini di architettura, quell’evento sembrava implicare una presa di coscienza, da parte degli intellettuali e dei professionisti italiani, dello spazio-tempo organico, cioè della rivoluzione einsteiniana incarnata negli invasi edilizi ed urbani. Benché sconfitta sul terreno della politica e già invischiata in un sistema tradizionale di tipo pre-fascista che non abbiamo ancora superato, quell’Italia della Resistenza, rappresentata da Carlo Ludovico Ragghianti, si poneva alla testa di una riscossa culturale, ravvisando in Wright la personalità che meglio inverava un processo architettonico dinamico, costantemente in fieri, non mai fermo sulle posizioni acquisite, una personalità che aveva combattuto da decenni l’International Style, cioè la riduzione commercializzata e classicizzata del linguaggio moderno. L’omaggio a Wright, proposto da Firenze all’Europa, implicava l’esigenza di oltrepassare il razionalismo, che aveva scritto un capitolo fondamentale e inalienabile del movimento moderno, ma era ben lungi dall’averne esaurito i contenuti. La vicenda stessa del maestro di Taliesin attestava la complessità genetica dell’architettura moderna, invitava a riconquistarne la componente espressionista e comunque le valenze materiche, per poi compiere il salto verso l’organico.
Una basilare indicazione partiva dall’Italia affrancatasi dalla dittatura e da Firenze non più disposta a chiudersi nel proprio provincialismo.
Rievoco quell’evento di trent’anni fa, perché oggi provo un sentimento analogo. Sarebbe assurdo stabilire un confronto tra Wright e Michelucci, ma è certo che Michelucci offre, nel contesto europeo, un’altra testimonianza su «la sovranità dell’individuo». È senza dubbio l’architetto più autentico e fecondo nel panorama di una cultura che, preso atto con estremo ritardo della crisi del razionalismo e confondendola per ignoranza, pigrizia mentale o calcolato equivoco, con una crisi generalizzata ed irreversibile del movimento moderno, ha lanciato contro di esso tre siluri, fortunatamente logori e spuntati: il pre-moderno, l’anti-moderno e il post-moderno, tre strade diverse ma convergenti in un tentativo di restaurazione, di cui è spesso corresponsabile la sinistra politica direttamente o per agnosticismo. In questo panorama, una riflessione sull’itinerario di Michelucci sembra utile, anche al di fuori della festosa occasione che ci riunisce qui, perché si tratta di un itinerario scandito da ostacoli, angosce, riprese, errori, sgomenti, cadute e trionfi; un itinerario umanissimo malgrado l’eccellenza dei risultati e perciò assai distante da quello quasi mitico del genio di Taliesin.
Sarebbe fuor di luogo, qui a Firenze, dove Michelucci è conosciuto ed amato, e dove moltissimi sono suoi discepoli, tracciare un resoconto critico della sua produzione architettonica. Del resto, la letteratura su di lui è vastissima ed egli stesso, in numerosi libri, saggi e interviste, ha documentato ogni fase del suo lavoro. Cercherò quindi di fissare alcuni punti che mi pare possano costituire riferimenti stimolanti per tutti noi e segnatamente per i più giovani. Cinque caratteri, di ordine etico, psicologico ed artistico: la capacità di sradicarsi dai traguardi raggiunti, il rapporto attivo con il passato, l’unità tra urbanistica e architettura, la pluralità linguistica ed, infine, l’età avanzata come momento liberatorio. Credo che in questi aspetti si dispieghi la figura di Michelucci, anche quale poeta degli spazi. E passo ad esaminarli:
1) la capacità di sradicarsi dai traguardi raggiunti, l’efferata, tormentosa ricerca di nuove e più calzanti vie espressive. Com’è noto, l’accademia costituisce il substrato permanente, tenace, corrosivo della cultura italiana, un baratro in cui ognuno di noi può precipitare, anche senza volerlo, appena allenta la sua tensione. Ed è difficilissimo sfuggire alle lusinghe accademiche, perché il classicismo non riguarda soltanto archi e colonne, cioè un vocabolario anacronistico, ma si può applicare con disinvoltura anche a grattacieli di acciaio e cristallo, o ad opere spericolate di ingegneria strutturale. Quando si è toscani, tanto peggio: per scrostare dal proprio animo i tabù della simmetria, dell’assonanza, della proporzione, dell’impianto prospettico, della scatola chiusa, dello spazio statico, dell’isolamento del manufatto edilizio rispetto alla città e al territorio, occorre un impegno psichicamente, direi esitenzialmente costosissimo. Michelucci non è «nato rivoluzionario», come Wright o Mendelsohn; non ha avuto un maestro come Sullivan, né è vissuto in un’atmosfera culturale incandescente ed eversiva come Scharoun. È cresciuto nel mondo dell’artigianato, poi nel clima accademico, poi nella dimensione provinciale e strapaesana della rivista «Frontespizio». Se ne è liberato lentamente, a fatica, avanzando e retrocedendo prima di scattare. La sua è una storia di sofferta emancipazione dai feticismi contadini e da quelli monumentali, dalle polemiche intellettualistiche e dalle esaltazioni irrazionali, dal gretto professionalismo e dalle astrazioni spiritualistiche ed utopiche.
Afferma che disconosce tutto quanto ha progettato e costruito, mentre invece ci sono soltanto pochissime opere da rifiutare. Ma l’essenziale, il meraviglioso in lui è che cammina e, come ha scritto, passa «ancora, giorno per giorno, di sorpresa in sorpresa per ciò che avviene nel mondo». Cammina a novant’anni più rapidamente e audacemente di quanto facesse a venti o a quaranta. Avverte «i segni di una speranza nuova, di un senso nuovo della vita», crede nella città nuova, s’interroga «non solo sull’uomo in generale, ma sulla scuola, sulla casa, sull’ospedale, sulla chiesa, sulla prigione, sulla banca, sulle strade, sulle piazze, sui teatri, sui luoghi e sugli edifici per incontri sportivi e culturali» e, ogni volta, dà una risposta diversa, scopre qualche cosa e trova l’energia di trasformarsi. Per Frank Lloyd Wright «la legge del mutamento organico è l’unico principio proficuo e concreto che l’umanità possa conoscere». Ebbene, Michelucci che, trent’anni fa, sentiva del tutto estraneo il genio di Wright, impersona, nella propria biografia e nell’arte degli spazi «strappati al sistema», alla giungla degli «addetti ai lavori» e degli «uffici competenti», il principio del mutamento. Scrive: «Sono finiti i tempi degli schemi precostituiti. È cominciata l’era del grande esodo. È come se l’uomo avesse riscoperto la sua originaria vocazione di nomade. Forse per maturazione collettiva, ma anche per il terrore del domani, voglio credere che sia cominciata la lunga marcia verso la libertà».
2) il rapporto attivo con il passato. Basta leggere il saggio «Brunelleschi mago» per capire in quale chiave Michelucci si pone in dialogo con la storia.
Lo fa in presa diretta, spregiudicata, eretica, sottraendosi a qualsiasi filtro interpretativo di marca scolastica. Scopre l’anticlassicismo di Brunelleschi, direi quasi che lo fiuta, meglio di ogni esegeta e filologo. Lui, intriso per educazione di cultura rinascimentale, capta subito il fatto che con il Rinascimento canonizzato da una distorta ottica del pensiero albertiano, Brunelleschi non ha nulla in comune. Detesta Palazzo Strozzi per la sua scatola chiusa, perché, dice, «non è spazio, rifiuta di diventare spazio», «rappresenta la vera negazione delle conquiste liberatrici esemplarmente espresse nelle fabbriche brunelleschiane». Odia le città ideali del Rinascimento, perché, afferma, sono «oggetti privati» del ceto superiore, sono asociali, l’opposto «del concetto stesso di città». Certo, anche Michelucci si alimenta di fonti storiche come tutti i veri architetti. Ma progressivamente le brucia, con un processo esattamente antitetico a quello di coloro che esplicitano «la presenza della storia» mediante grottesche e vacue citazioni formali. Michelucci inciampa sia nell’accademia che nel vernacolo durante la sua ricerca, e adotta il vernacolo come antidoto dell’accademia. Ma si accorge presto che il dialetto edilizio popolare, specie in Toscana, è spesso quello favorito dalla classe dominante per differenziare l’habitat delle classi subalterne, e allora lo rigetta. Sfugge così ai due trabocchetti storicistici, cioè intrinsecamente antistorici che non a caso sono accettati e promossi dalle dittature: il classicismo accademico e la cosiddetta architettura «minore», anonima, «spontanea», che il realtà è spontanea solo nei rari casi in cui protesta contro i dogmi accademici, non quando li integra a sfondo pittoresco dei monumenti del potere. In breve, quello di Michelucci è un rapporto di odio-amore con la storia, l’unico valido se si vuol comprendere il passato senza subirne passivamente l’autorità. E qual’è il termometro critico con cui misura sia il passato che il presente? Lo dice in «Brunelleschi mago» telegraficamente: «Nonostante l’infinita varietà, gli spazi possibili appartengono sostanzialmente a due categorie: quella dello spazio che vincola e quella dello spazio che libera». La scelta esorbita dall’architettura, coinvolge la politica e l’etica sociale: quando lo spazio vincola, anche se è inondato di bandiere rosse, è repressivo e fascista; quando libera, è democratico, pensato per il benessere di tutti. Ciò vale anche rispetto alla mania conservatrice, che induce a restauri di un masochismo inaudito, e preferisce il falso-antico ai genuini interventi moderni. «Non permettendo che si stabilisca una continuità tra il vecchio e il nuovo – sono parole di Michelucci – i centri storici diverranno col tempo organismi sempre più privi di vita, come accade per qualunque oggetto che si isoli dall’uso quotidiano». Ecco come si deve amare la storia: aggredendola, contestandola, difendendone l’eredità nel solo modo legittimo, cioè evitandone la sclerosi.
3) unità tra urbanistica e architettura. Il continuum fra spazio interno dell’edificio e spazio esterno della comunità diviene, dagli anni di guerra, una costante delle immagini di Michelucci. Ma questo continuum non è inteso in senso inerte, ambientistico. Riguarda una fruizione alternativa dell’organismo architettonico che, banca o chiesa, ospedale o scuola che sia, acquista funzioni coinvolgenti tutti i cittadini. Riguarda un linguaggio aperto, parlante, virtualmente un «non-finito» che chiede all’intorno di contribuire a compiere la propria fisionomia. E cos’è il linguaggio? Michelucci risponde:
«Lo spazio è il solo linguaggio, la sostanza di ogni fatto architettonico e di ogni complesso urbanistico… Lo spazio è storia in continuo divenire». Gli splendidi disegni per la «Città Nuova» trasmettono questo messaggio: il messaggio della «città variabile», quella «che esprime la vera immagine della popolazione, la città che muta, che non è eterna, che segue le esigenze e l’umore stesso degli uomini». Michelucci denuncia la pavidità, la viltà di una settorializzazione della cultura, quello scisma tra un’urbanistica bidimensionale e una terza dimensione architettonica che impedisce il realizzarsi dello spazio-tempo, della quarta dimensione, della «mobilità sociale ed umana», senza la quale lo spazio «diventa una prigione». I suoi schizzi sono dei «non-finiti» che celebrano l’incontro-scontro tra individuo e collettività, tra pubblico e privato, tra edificio e città o territorio e non intendono sottomettere il piano al diktat dell’architettura, ma neppure mortificare l’architettura in nome dell’urbanistica. Lo spazio, per lui, non è spazialità in astratto, da contemplare: determina i comportamenti, i tempi e i modi dell’uso. Contro la tendenza alla restaurazione, contro il neoconservatorismo, si tratta di riconquistare, cito Michelucci, «la tradizione vera, il vero senso del murare con fantasia, in piena libertà creativa, rompendo tutti i vincoli della concezione accademica», senza preoccuparsi «di seguire un disegno formalmente e tecnicamente definito». L’edificio diventa cosi non un oggetto, ma un catalizzatore della vita comunitaria e la città diventa «una grande casa», secondo un’accezione antichissima che molti ripetono e, però, pochissimi applicano.
Se c’è un architetto, oggi in Italia, che sostanzia il termine di «urbatettura», il principio di identità tra urbanistica e architettura, questo è Michelucci.
Perciò inneggia alla partecipazione della gente, alla creatività corale, non per un’ideologia populista, non per appagarne i capricci, gli archetipi e i tabù culturali ma, al contrario, per trovare, scrive, «il coraggio di costruire e di demolire quello che da soli non oseremmo mai fare». E precisa: «Vi è una biologia dello spazio che non è diversa dalla biologia umana. Se manca la vita, la presenza creativa e la partecipazione dell’uomo, lo spazio non parla». Ebbene, riconosciamolo francamente: oggi, malgrado tanti discorsi di politici ed amministratori, malgrado tanti comitati di base e tante consultazioni popolari, «lo spazio non parla»; anzi, di regola, lo spazio temporalizzato, quello che libera i comportamenti, non c’è. Qualcosa non funziona nella progettazione e nell’uso degli spazi, urbani o architettonici che siano: «Non crediamo nel nostro tempo e non lo amiamo; abbiamo smarrito la coscienza di esser noi stessi a tesserne la trama; ci sentiamo spettatori più che protagonisti», osserva Michelucci. Siamo soffocati da regolamenti appiattenti, livellatori e questo offende e induce a protestare contro la città negativa, che genera indifferenza.
4) la pluralità linguistica. Michelucci non è mai stato razionalista in modo rigoroso, tanto che partecipò solo marginalmente alle battaglie del M.I.A.R.
nel 1928-31. Ebbe torto – lo dico con schiettezza – perché il M.I.A.R. rappresentò l’ultima occasione, durante il fascismo, di legittimare il movimento moderno, di rinnovare le Facoltà di architettura, di combattere la dittatura con l’arma architettonica. Tuttavia, se fu assente da quell’episodio-chiave, quando i razionalisti furono sconfitti, si sentì parte della minoranza perseguitata. La stazione di Firenze, insieme a Sabaudia, significò la risposta che un’avanguardia battuta dava al trionfo della retorica del potere: risposta coraggiosa, che consentì la sopravvivenza e poi il rilancio del movimento moderno per opera di Persico, Terragni e Pagano. Il razionalismo comunque è una tappa obbligata della cultura contemporanea e Michelucci dovette recuperarla dopo una fase incerta, retrograda e dispersiva. Più tardi, superate le esperienze monumentali e vernacolari, attraverso alcuni sondaggi nella poetica di Alvar Aalto, abbraccerà la via espressionista. «Se mi si chiedesse una preferenza – scrive – dichiarerei senza esitazione che solo l’espressionismo mi ha interessato e continua ad interessarmi; e proprio per quel suo carattere di esperienza lasciata a metà, non conclusa e, forse, inconcludibile. A pensarci bene, l’espressionismo non rappresenta uno stile, ma la rottura di uno stile, di tutti gli stili». Storicamente, l’espressionismo è l’urlo del primo dopoguerra tedesco. Per Michelucci, durante la parentesi illusoria del miracolo italiano, è l’urlo contro il vicolo cieco dell’artigianato, dell’accademia, del classicismo e del vernacolo. Dopo, nella chiesa di Longarone e, ancor più, nell’ospedale di Sarzana, egli imbocca una strada che non può essere denominata da un -ismo, perché è organica. Il complesso di Sarzana vede un’articolazione espressionista dei corpi edilizi sul terreno, ma poi volumi, fronti, angoli trattati con il lessico razionalista; in questa sintesi sta l’aspirazione all’organico. Il pluralismo linguistico di Michelucci è segnato da sospetti, remore, intime difficoltà, tormenti che gli sono indispensabili per sviluppare se stesso, per trovare una propria convinzione. Io non ritengo che la pluralità linguistica sia, di per sé, un valore, né giudico fatalmente necessario lo spreco di energie che essa implica. Però, guardiamoci intorno: pochissimi sono gli architetti europei capaci di riconquistare la lezione dell’espressionismo e, fondendola con quella razionalista, di giungere all’organico. Di fronte a questa constatazione, non importa il prezzo pagato. Non importa domandarsi quante opere valide avrebbe potuto produrre Michelucci tra le due guerre, se avesse aderito al razionalismo e poi all’organico. Dice con umiltà: «Io non ho risposte. Non le ho mai avute. Il dubbio, il timore di sbagliare mi ha sempre accompagnato. Certo, vedendo i naufragi delle certezze degli altri, posso dire che quella che ho sempre considerato una mia personale condanna era, forse, un metodo di lavoro». Viene alla mente la vicenda corbusieriana. Dopo la smagliante stagione razionalista, Le Corbusier rivoluziona il proprio linguaggio nel supremo gesto informale di Ronchamp; ma poi torna indietro, nel brutalismo, e solo alla fine, progettando l’ospedale sulla laguna di Venezia, trova una sintesi. Michelucci ha impiegato più tempo per riscoprire i valori della materia, della luce, dello spazio dinamico, ma non è tornato indietro, anzi ha saputo bruciare le scorie dell’espressionismo per raggiungere una visione organica, la più attuale offerta dalla cultura moderna. Un lungo, travagliato itinerario nel pluralismo, che però sfocia nell’equazione più ricca, variabile e coerente.
5) L’età avanzata come momento liberatorio. Il fenomeno non è nuovo.
Lo riscontriamo nel Brunelleschi di Santo Spirito e della Lanterna, nell’Alberti del coro della Ss. Annunziata, in Michelangiolo, da Porta Pia a Santa Maria degli Angeli; lo registriamo in Wright, in Le Corbusier, in Scharoun e in molti altri architetti. Ma il caso di Michelucci è singolare, se non unico, sotto questo aspetto: il passare degli anni non lo porta soltanto ad emanciparsi dai vincoli istituzionali, professionali e didattici, al fine di parlare in modo più veritiero e scoperto con se stesso; lo induce invece a sperimentare la felicità dell’architetto a colloquio con gli altri. Se, in genere, l’età avanzata implica una volontà di affrancarsi dai condizionamenti esterni, in Michelucci e, ch’io sappia, solo in lui, significa una stupefacente gestione della propria fragilità per ricavarne un’energia oscillante tra disperazione e gioia. Ciò deriva naturalmente dall’indipendenza che Michelucci ha sempre mantenuto.
Non sopporta le istituzioni, i vincoli, i regolamenti burocratici. Ha sempre insegnato, ma senza fossilizzarsi nella didattica, nella palude universitaria.
Quando la Facoltà di architettura di Firenze gli era ostile, l’ha abbandonata. Ha coltivato il rapporto con gli altri non per un imperativo sociale, ma come un mezzo per coltivare meglio se stesso nel mondo. È vissuto per molti anni, come Wright e Le Corbusier, isolato, senza lavoro, stupito che qualcuno, cliente o amico, bussasse alla sua porta. Ha amato le persone semplici, ma ha nutrito una ripugnanza insuperabile per i mediocri. Il suo successo è esattamente proporzionale alla sua mancata ricerca del successo. I maggiori incarichi professionali li ha avuti quando non li cercava più. Questi valori esistenziali, questa quotidiana riproposizione del proprio tempo, del fluire della propria esistenza, sono la chiave della vitalità di Michelucci.
E concludo. Non credo, neppure in questa occasione, di essere ottenebrato dal mio affetto per lui. E, del resto, lo amo perché non è un personaggio titanico, ma una persona intrisa di debolezze. La sua forza consiste nel governarle, proiettandosi nel mondo degli altri attraverso il mestiere dell’architetto. Consiste nel guardare al presente e all’avvenire, non soltanto alla conservazione del passato e, meno ancora, alla sua manipolazione abietta e suicida.
La felicità dell’architetto, la felicità che ha descritto, non come miraggio illuministico, non come bene naturale da cui saremmo espropriati, quanti di noi l’hanno veramente sperimentata? E perché sono cosi pochi? Ecco: la risposta a questo quesito ognuno di noi può cercarla confrontandosi con la vicenda di Michelucci. Egli merita la cittadinanza onoraria di Firenze, l’omaggio e il plauso, la gratitudine di tutti noi, perché ha raggiunto una felicità che non poggia sulla solitudine, sull’equilibrio, sul compromesso, sul commercio avaro tra pubblico e privato, sul potere intellettuale od artistico, e meno ancora su un atteggiamento automanierista. È una felicità segnata da crisi, pene, delusioni, rischi e contraddizioni. «Non sono un maestro», ripete, e non vuole esserlo. Ma consentitemi, a chiusura, di rivolgermi direttamente a lui, per dirgli: Non sei un maestro nell’accezione tradizionale del termine, quella accademica. Lo sei in una dimensione più ampia che va oltre l’architettura, anche se in essa trova il suo massimo fascino espressivo. Lo sei e per questo ti ringraziamo e ti festeggiamo. Perché tu, prima ancora di esaltarla, incarni la felicità disperata dell’architetto, impegnato a creare una città «dove non esistano recinzioni, detti e tabù», una città anti-idrolatica i cui spazi siano determinanti non dalla geometria, ma dall’etica rivoluzionaria del vivere quotidiano.
1982
Pubblicazione di “Erich Mendelsohn”.
“Erich Mendelsohn”
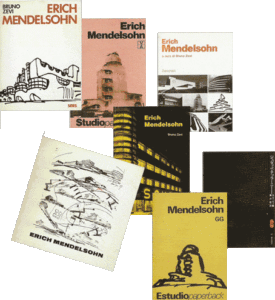 Dopo il grosso volume “Erich Mendelsohn: opera completa” Architetture e immagini architettoniche, pubblicato dalla Etas Kompass di Milano nel 1970, pochissimi si sono occupati di questo maestro. Era quindi necessario richiamare l’attenzione su di lui, specie in un periodo di neo-espressionismo e di espressionismo astratto sempre riaffiorante. A questa esigenza ha risposto il saggio Zanichelli del 1982.
Dopo il grosso volume “Erich Mendelsohn: opera completa” Architetture e immagini architettoniche, pubblicato dalla Etas Kompass di Milano nel 1970, pochissimi si sono occupati di questo maestro. Era quindi necessario richiamare l’attenzione su di lui, specie in un periodo di neo-espressionismo e di espressionismo astratto sempre riaffiorante. A questa esigenza ha risposto il saggio Zanichelli del 1982.
Zanichelli, Bologna 1982. Edizione inglese, Rizzoli International, New York, e The Architectural Press, Londra 1985. Edizione spagniola, Gili, Barcellona 1984. Edizione francese, Sers, Parigi 1984. Edizione tedesca, Artemis, Zurigo 1983.
Etas Kompass, Milano 1970; Testo&Immagine, Torino 1997. Edizione inglese “Erich Mendelsohn. The complete works”, Birkhäuser, Basel 1999.
1983
Candidato del Partito Socialista Italiano alle elezioni.
Gli intellettuali: perché nelle liste ci siamo anche noi
 “Corriere della sera”, 15 maggio 1983, a cura di Paolo Conti e Antonio Debenedetti
“Corriere della sera”, 15 maggio 1983, a cura di Paolo Conti e Antonio Debenedetti
Bruno Zevi (architetto, candidato nelle liste del PSI).
Elio Vittorini affermava che cultura e politica si identificano nei momenti di emergenza, cioè quando si manifestano eventi rivoluzionari o tentativi di restaurazione. La mia biografia conferma la tesi di Vittorini. Ho partecipato intensamente alla lotta politica in tre periodi: durante il fascismo, nella cospirazione condotta dal movimento “Giustizia e Libertà” di Carlo Rosselli. Poi, durante gli anni successivi alla liberazione nelle file del Partito d’Azione. Infine, nel 1953, al tempo della «legge truffa», nel movimento di “Unità Popolare” di Ferruccio Parri e Pietro Calamandrel. A me sembra che questo sia un momento pericoloso, in cui si tenta di far regredire il paese sia sul terreno politico che su quello culturale. Non solo la destra e il centro, ma anche un vasto settore della sinistra stimolano la restaurazione; basti pensare che, in architettura, la neo-accademia e il post-moderno si incarnano in personaggi della sinistra. Di fronte a uno sfascio del genere, gli intellettuali non possono stare alla finestra, aspettando di vedere come andrà a finire. L’atmosfera dell’università e dell’industria culturale è già irrespirabile. Gli uomini liberi devono scuotersi: è in gioco il ruolo dell’Italia nel circuito della cultura occidentale.
Annual Discourse al RIBA di Londra.
Dal manierismo al linguaggio
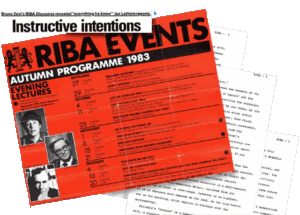 “Architecture versus Historic Criticism”, discorso annuale del Royal Institute of British Architects (RIBA), Londra, 6 dlcembre 1983
“Architecture versus Historic Criticism”, discorso annuale del Royal Institute of British Architects (RIBA), Londra, 6 dlcembre 1983
Un’introduzione provocatoria può essere fornita da due citazioni. La prima, di Georg Simmel, concerne il tabù della simmetria. Nel 1896 egli affermò che «la tendenza alla simmetria, a una sistemazione omogenea degli elementi secondo principi generali, è tipica di tutti i regimi dispotici», mentre «la forma dello stato liberale tende invece all’asimmetria», al riconoscimento dello sviluppo indipendente di ogni elemento, e «a libere relazioni a largo raggio» fra di essi. In altri termini, Simmel considerava l’asimmetria un sintomo del grado di maturità democratica raggiunto da una società e dalla sua architettura.
La seconda citazione è di Alois Riegl. Datata 1901, riguarda l’architettura tardo-romana che, egli scrive, «riconosce lo spazio come una quantità materiale e cubica – e perciò è diversa dall’architettura antica e classica – ma non come quantità infinita e senza forma – ed è dunque diversa dall’architettura moderna».
Riegl traccia una chiara distinzione tra due momenti della concezione architettonica: la «composizione di masse» e la «formazione dello spazio». Per lui, la storia testimonia l’evoluzione da una visione primitiva che è terrorizzata dal vuoto, dalle cavità, dal non-costruito, a una visione matura che esalta lo spazio: dapprima uno spazio statico e cubico, poi fluido, dinamico, senza forma, emancipato dalla costrizione geometrica.
Ottantasette anni sono trascorsi da quando Simmel fece la sua dichiarazione sull’asimmetria, e ottantadue dall’asserto di Riegl sullo spazio.
Ma la maggioranza dei nostri edifici sono tuttora simmetrici e non contengono spazi reali, creativi. I due problemi sono intrinsecamente correlati perché, accettando la simmetria, la «composizione delle masse» assumerà un valore maggiore della «formazione dello spazio»; il contenitore prevarrà sul contenuto, l’omogeneità degli elementi costruiti spingerà a dimenticare «le libere relazioni a largo raggio» dell’ambiente in cui la gente vive e si muove.
Una struttura simmetrica è auto-assertiva, isolata dal contesto sia urbano che paesistico. La simmetria è un a priori, una regola astratta imposta al territorio, alla fabbrica della città o all’edificio, che non implica alcun dialogo con l’intorno.
La Rotonda di Palladio è un oggetto omogeneo collocato su una collina, un coagulo nella campagna vicentina che non colloquia con nessun episodio circostante. Quando, nello sviluppo della sua arte, Palladio perseguì l’ideale del continuum, questo impianto omogeneo fu abbandonato: a Villa Foscari, La Malcontenta, le facciate totalmente diverse denotano una drammatica svolta del suo impulso spaziale.
In genere, i palazzi rinascimentali sono simmetrici e questo è il motivo per cui il Rinascimento non ha prodotto città umane, organiche. Le poche «città ideali» realizzate s’ispirarono agli insediamenti militari, alle prigioni e ai cimiteri. Anche le ville rinascimentali sono di norma simmetriche: odiano la natura, la crescita, squadrano gli alberi per uniformarli.
Potete immaginare Palazzo Vecchio a Firenze come un oggetto simmetrico, con la torre di Arnolfo issata nel mezzo? Se fosse così, guasterebbe sia la piazza che la corte degli Uffizi.
La simmetria dunque rimanda alla composizione delle masse, dei «pieni», e l’asimmetria alla formazione degli spazi, dei «vuoti». Una soluzione simmetrica è impossibile se si pensa in termini non di facciate e volumi, ma di luoghi e spazi, e ancora più se si pensa agli uomini e alle donne, alle famiglie e alle comunità, ai loro comportamenti. Un uomo può essere considerato simmetrico quando giace immobile in una bara, ma è sempre asimmetrico quando è vivo e cammina nello spazio. Di conseguenza, questo spazio non dovrebbe essere statico, «materiale e cubico», ma fluente, dinamico, come disse Riegl. Quando, nel 1901, egli parlava di «architettura moderna», intendeva un linguaggio che unificasse lo spazio «infinito» del gotico con lo spazio «senza forma» derivato dalle interpenetrazioni barocche. Fu quasi una profezia. Trentacinque anni dopo, Frank Lloyd Wright costruì Falling Water, la Casa sulla Cascata: nessuna simmetria, nessuna composizione di masse, anzi niente masse, neppure masse vuote, ma formazione dello spazio dentro e fuori, continuo fra interno ed esterno.
Un critico deve esplicitare il suo punto di vista; si potrà essere in accordo o in disaccordo con lui, ma in ogni caso costituirà un utile punto di riferimento, positivo o negativo. Se invece non ha salde convinzioni ed è capace di spiegare tutto e il suo contrario, mostrerà di essere uno scettico, anche se brillerà per essere un acrobata verbale, in grado di coniare due parole nuove ogni mattina e di connetterle ad altre tre nel pomeriggio.
Sospetto che l’attuale crisi dell’architettura sia causata principalmente da quei critici che: 1) confondono il movimento moderno con l’International Style, 2) hanno sostenuto e difeso l’International Style per decadi, quando era già obsoleto, 3) invece di condannare l’International Style, in nome del movimento moderno, ripudiano i linguaggi contemporanei in blocco, senza discriminazioni. Tre errori macroscopici, consapevoli o incoscienti che siano. Comunque, quando questi critici sentenziano che l’architettura moderna è morta, possiamo essere sicuri che è splendidamente operante.
L’International Style è esattamente l’opposto del movimento moderno.
Ha tentato di classicizzare la nuova architettura facendone un ennesimo stile della collezione Beaux-Arts. Se prendete ad esempio il Seagram Building progettato da Mies van der Rohe e Philip Johnson, vi troverete incarnate tutte le regole Beaux-Arts: visione prospettica rinascimentale, per giunta frontale, scatola di vetro e metallo, nessuno spazio creativo ma solo vuoti scatolari, congegno accademico con squisite modanature agli angoli. Si comprende perché Johnson, partendo dal Seagram, sia approdato al più squallido eclettismo.
Dal 1940 al 1943, negli Stati Uniti, fui allievo di Walter Gropius e dei suoi collaboratori nella Graduate School of Design della Harvard University. Ma è da Wright e da Lewis Mumford che ho imparato la complessità dell’architettura moderna, la sua non riducibilità alla matrice cubista propugnata da Siegfried Giedion in “Space, Time and Architecture”. Scoprii la componente espressionista del movimento moderno, totalmente rinnegata da Giedion e vidi un possibile terreno d’incontro tra cubismo ed espressionismo, una sintesi chiamata architettura organica.
All’inizio del 1943, tornai in Europa per contribuire all’azione dei gruppi antifascisti clandestini in Italia. Ma fui fermato per qualche settimana a Londra in quanto ero repubblicano e il governo inglese allora era a favore della monarchia corresponsabile dello stato totalitario. Mi recavo ogni giorno nella biblioteca del RIBA e, quando infine mi fu concesso di salpare per Roma, portai con me il manoscritto del mio primo libro, “Verso un’architettura organica”, pubblicato nel 1945.
Questo volumetto, poco più di un pamphlet, si trasformò, nel 1950,in una ponderosa “Storia dell’architettura moderna”. Alcuni critici la definirono «L’anti-Giedion». Infatti, sottolinea la rilevanza del movimento Arts & Crafts, che Giedion disconosce; di grandi artisti come Joseph Maria Olbrich, Antoni Gaudì ed Erich Mendelsohn, che Giedion emargina, dello sviluppo post-cubista e post-razionalista, da Etik Gunnar Asplund, su cui Giedion tace, ad Alvar Aalto, affatto trascurato nella prima edizione di “Space, Time and Architecture” del 1941. Nella mia Storia, il capitolo conclusivo non era dominato da Le Corbusier, Gropius e Mies, ma da Wright; non era più il piano di Amsterdam del 1934, ma i piani di ricostruzione di Londra del 1944 a dare un’indicazione per il futuro dell’Europa urbana. Più tardi, ho aggiornato questa Storia, integrandola ogni cinque anni circa, e poi ampliandola nel 1975 in due volumi: “Spazi” e “Storia dell’architettura moderna”. Avevo imparato da Wright e Mumford, ma anche da Nikolaus Pevsner e Walter Curt Behrendt, che l’architettura moderna non è «uno stile», ma un processo continuo, un gioco che distrugge continuamente le sue regole, e deve essere reinventato ogni giorno. Così, quando Le Corbusier, nella Chapelle de Ronchamp del 1950, smentì la pianta libera, i pilotis, il tetto-giardino, la finestra a nastro, tutti i «principi» che aveva promulgato nel 1921, e in certo modo risuscitò lo spirito e le forme dell’espressionismo, questo non costituì un trauma per la mia Storia, in quanto la poetica espressionista vi esisteva già come fattore permanente del linguaggio moderno.
Lo stesso si può applicare alle opere di Hans Scharoun, Walter Netsch, John Andrews, Denys Lasdun, John Johansen, Lucien Kroll, Norman Foster, Renzo Piano e Richard Rogers, Peter Eisenman e Richard Meier, Günther Domenig, Jean Renaudie, Fehling & Gogel, Ralph Erskine, per menzionare solo alcuni nomi. Questi architetti hanno aggiunto nuove parole al linguaggio moderno, arricchendone i contenuti, contribuendo a renderlo più colto e popolare, capace di dialogare con la cacofonia urbana e con il kitsch.
Il panorama dell’architettura moderna è cambiato, la complessità ha sostituito la semplificazione geometrica e puritana; la distanza tra un Domenig e un Eisenman, o tra un Erskine e un Renaudie, è enorme. Ma tutti appartengono alla stessa ricerca, passata dal dilemma elementare cubismo/espressionismo a una complicata equazione che si può definire «organica» o, se più vi piace, «umana» come proponeva Aalto, oppure «post-industriale» o «elettronica» o come volete.
Il post-modernismo è un narcisistico non-senso, ma è sintomatico che Charles Jencks abbia concluso il suo pamphlet “The Language of Post-Modern architecture” esaltando Antoni Gaudì e che recentemente abbia proclamato Frank Lloyd Wright il migliore degli architetti postmoderni. Bene, possiamo essere d’accordo con lui su Gaudì e Wright, dimenticando tutto il resto, da Philip Johnson a Michael Graves.
Mi dispiace di essere alquanto rude con i post-modernisti. Alcuni di loro si lamentano per il fatto di essere chiamati «Rats, Posts & Pests»; lo trovano sgarbato, «unEnglish». Ma è forse gentile e «inglese» ripetere, come loro fanno, che noi tutti, i moderni, saremmo morti dal «15 luglio 1972, alle 15,32»? Quello che i post-modernisti non comprendono è che il movimento moderno ha un intrinseco potere di rigenerazione, di morire e risorgere, che i loro aborti non possiedono.
Certo, si potrebbe essere più generosi verso i teorici del post-moderno e riconoscere che hanno contribuito, forse involontariamente, a chiarificare la situazione. Perché adesso la gente dell’International Style, i cosiddetti «classico-moderni», che è una contraddizione in termini, e tutti i mediocri che hanno ricalcato in vetro e metallo le regole e i dogmi Beaux-Arts, ora si rivelano meri plagiari dediti all’uso di falsi archi e colonne, false simmetrie, false decorazioni. Finalmente, l’equivoco tra International Style e movimento moderno è superato.
Gli architetti International Style tornano al classicismo e all’eclettismo, all’accademia cui appartengono, mentre le persone creative continuano a sviluppare il movimento moderno.
D’ora in poi, nessuno penserà che Michael Graves o Ricardo Bofill siano architetti moderni. Sono traditori e suicidi, non subiscono crisi perché, come artisti, non esistono. Solo gli architetti moderni sono in costante crisi, perché sono vivi. C’è ragione per essere ottimisti: il carnevale post-moderno ha dimostrato che l’alternativa al movimento moderno è una sciocchezza alla moda o una vergognosa idiozia. Una volta separata dalla corruzione International Style, l’architettura moderna torna a essere una minoranza, una sfida rischiosa per gente coraggiosa. La confusione è finita. I mutamenti di oggi non sono quelli dell’avanguardia e dei pionieri, riguardano l’età matura dell’architettura moderna. Coinvolgono parecchi problemi, tra i quali tre appaiono rilevanti: la presenza della storia; il manierismo moderno, sia a livello aulico che a quello regionale e vernacolare; e, infine, la codificazione del linguaggio moderno.
Il dialogo con il passato. Come storico, non ricordo una sola età, una sola cultura che, per enfatizzare l’originalità del suo messaggio, non abbia dovuto combattere contro l’arte del periodo precedente. Tutte le culture, da quella romana rispetto alla greca, dal primo cristianesimo rispetto all’eredità imperiale, al Rinascimento rispetto al Medioevo, al Barocco rispetto al Rinascimento, tutte le nuove poetiche hanno dovuto attaccare i contenuti, i metodi e le forme preesistenti. Ma non c’è cultura che, dopo la fase pionieristica, non abbia trovato, in un modo o nell’altro, una dialettica persuasiva tra il nuovo e il vecchio.
Come possiamo raggiungerla noi?
Prima di cercare di rispondere a questo quesito, va sottolineato che, anche durante la stagione pionieristica, l’indifferenza degli architetti per il passato è stata più apparente che reale. Le Corbusier studiò la storia in profondità, non nei falsi manuali e precetti Beaux-Arts, ma viaggiando per anni in Oriente, Grecia e Italia, e scoprendo cosa c’era di nuovo, di moderno nel passato. Il linguaggio dei «volumi puri sotto la luce» deriva dal cubismo quanto dall’eredità ellenica. Quando Corbu rigetta questa poetica, a Ronchamp, la conoscenza dei castelli medievali francesi lo aiuta a trovare nuove espressioni. Chiunque l’abbia conosciuto, e abbia passeggiato con lui lungo le calli di Venezia, non dimenticherà mai la sua straordinaria sensibilità per il tardo-antico, per il carattere narrativo della città lagunare. Lo stesso vale per Wright. Ho passato giorni e giorni con lui a Roma, Firenze, Perugia, Assisi e Venezia, e non ricordo un architetto altrettanto ricettivo in presenza di Palazzo Vecchio a Firenze o di Santa Maria della Salute a Venezia. Il disprezzo per il passato è stato un atteggiamento alla moda dell’avanguardia, ma i maestri si sono sempre nutriti di storia.
Di conseguenza, gli architetti moderni non hanno mai commesso crimini contro il passato. Li hanno commessi invece gli accademici che esaltavano retoricamente l’antichità. Non sono stati Arnolfo di Cambio o Brunelleschi a distruggere i monumenti greci e romani, ma i maestri dell’Alto Rinascimento che li misuravano con reverenza e interpretavano Vitruvio come una kabala. Non fu un architetto del ciclo Arts & Crafts o Art Nouveau o protorazionalista a fracassare il cuore di Roma erigendo l’orribile monumento a Vittorio Emanuele, ma Giuseppe Sacconi, studioso di modanature etrusche e classiciste. Non fu Terragni ad aprire l’atroce via della Conciliazione adducente a San Pietro, ma Marcello Piacentini, il capo degli architetti fascisti, il corruttore del movimento moderno in nome del classicismo. Anche durante la dittatura di Mussolini, quando gli architetti moderni intervenivano nei centri storici, producevano opere come la Casa del Fascio a Como o la Stazione ferroviaria di Firenze, che dialoga ancora gentilmente con l’abside di Santa Maria Novella.
Ciò comunque non è sufficiente per assicurare un fertile scambio tra architettura e storia. Di cosa abbiamo bisogno?
Sappiamo che la storia può essere usata per qualsiasi scopo, anche il più reazionario. Non furono soltanto Hitler, Stalin e Mussolini a sproloquiare in nome della storia. I rivoluzionari francesi predicarono un revival classico, Robespierre mitizzò Atene, e l’estrema sinistra lo attaccò mitizzando Sparta. Così, nell’alterco fra Atene e Sparta, il classicismo arrivò sulla scena, con Napoleone.
Il problema è che in ogni età, per ogni generazione, la storia deve essere riesaminata e riscritta alla luce dell’arte contemporanea. La storiografia creativa converge sempre con l’architettura creativa, con una reinterpretazione della storia condotta con occhi moderni. Forse il più importante e difficile obiettivo oggi non è un’altra storia dell’architettura moderna (ce ne sono già troppe), ma una moderna storia dell’architettura, dalla preistoria a oggi. Come professore di Storia dell’Architettura prima all’Università di Venezia, poi a Roma, per trent’anni ho cercato di insegnare la storia alla luce dell’arte e della cultura contemporanea. Per trent’anni, all’inizio di ogni lezione, sia sull’antico Egitto o sul romanico o sul XIX secolo, chiedevo agli studenti e a me stesso: perché ce ne occupiamo? E solo dopo aver trovato una chiave moderna alla lettura del passato, potevo individuare l’interesse operativo di analizzarne i prodotti. Dopo una lezione su Villa Adriana a Tivoli o su una moschea di Sinan a Istanbul, su Biagio Rossetti a Ferrara o sulle fattorie contadine nel sud della penisola italica potevamo scoprire suggerimenti inaspettati e stimolanti sugli impegni progettuali di oggi. A quel punto, la storia non era più un noioso passaggio obbligato nel curriculum studentesco; era il più valido e scientifico laboratorio di progettazione.
Non riesco a concepire la critica se non come critica storica. Non credo che un critico debba impersonare per forza un duplice fallimento: come architetto e come storico; Da Vasari a Baudelaire, i critici autentici sono individui che hanno un potenziale creativo e, allo stesso tempo, una profonda cultura storica. Solo attraverso la moderna critica storica si può dimostrare che Michelangiolo e Borromini hanno da offrire all’architetto moderno più di Gropius o Aalto perché, nel loro contesto linguistico, furono più coraggiosi e inventivi. Solo mediante la moderna critica storica si può dimostrare quanti templi greci, cattedrali gotiche, palazzi rinascimentali e chiese barocche siano mediocri o orrendi.
Altrimenti, la storia resta una specie di elenco telefonico dove ognuno è bello e grande. Una mitologia acritica gremita di sentenze tautologiche: qualcosa che dà ai giovani un complesso di inferiorità, perché sembra implicare che gli architetti pessimi, codardi e sciocchi siano una prerogativa dell’epoca contemporanea. La critica storica può confutare e demistificare questa mitologia mostrando quanti idioti si possano annoverare nel passato.
Come funziona questa critica? Nello stesso modo della moderna critica musicale, letteraria o figurativa. L’attenzione va concentrata, più sul processo che sul risultato. Vanno analizzati e valutati il programma dell’edificio e le sue possibili alternative, il modo in cui ha preso forma e le possibili maniere in cui avrebbe potuto acquisire altre forme, le opzioni rispetto agli spazi e al loro uso, ai volumi, al sistema strutturale, fino all’ultima modanatura. Va identificato l’itinerario costituito dalla somma dei dati, dal processo induttivo e dai momenti di vera invenzione. La critica storica aspira a ricostruire la genesi e la crescita di un’ipotesi architettonica dall’interno, è come se si dovesse progettare una cupola per la cattedrale di Firenze e, nella bottega di Brunelleschi, se ne discutesse ogni scelta con lui.
Il critico storico non è più un pomposo giudice che sentenzia in un tribunale applicando le leggi della proporzione, della simmetria, del ritmo, della prospettiva agli edifici sottoposti alla sua valutazione. Egli sa che queste leggi sono tutte accademiche e false; perciò scende dal piedistallo, si unisce agli architetti, ne condivide i problemi, le angosce, le vittorie e le sconfitte, il potere immaginativo e l’impotenza. Così il critico storico agisce all’interno della fenomenologia architettonica, e non guarda l’edificio come un oggetto statico da contemplare più che da vivere.
Questa cultura storico-critica non ha nulla in comune con il miserabile storicismo dei neo-accademici e dei post-moderni. Gli storicisti non sanno nulla di storia, conoscono solo gli stili Beaux-Arts, li copiano, li combinano in grottesche «citazioni» per sfoggiare la loro intellettualità.
Ma quando una vera coscienza storica è presente, non c’è bisogno di metterla in mostra. Si può provare che quanto più è forte la coscienza storica di un architetto, tanto meno evidente apparirà nei suoi prodotti.
Lo storicismo si stronca con una consapevolezza tagliente, aggressiva della storia.
Dunque, architettura moderna + storia architettonica moderna? È sufficiente? L’ho creduto per molti anni. Dal 1948 al 1973 ho ritenuto che la storia potesse fornire un metodo consistente e scientifico per la progettazione. In altri termini, ho creduto nel manierismo moderno.
Perché? La storiografia contemporanea ha riconosciuto lo splendore e la creatività del manierismo nei suoi molti aspetti. Anzitutto, in chiave di Michelangiolo e Palladio, cioè nella rivolta contro le regole classiciste, sovrastrutturali e oppressive. Poi in chiave di Vasari, Vignola, Giulio Romano, anticlassicisti mediante la contaminazione di poetiche diverse e spesso contrastanti.
In realtà, viviamo in un’età manieristica, seguita a quella di Wright, Le Corbusier e Mendelsohn. Il nostro obiettivo è simile a quello della generazione successiva a Leonardo, Raffaello e Michelangiolo: consiste nel combinare creativamente i linguaggi dei maestri, nel sottrarre loro gli attributi sovrumani e mitici, nel popolarizzarne i messaggi. Manieristi sono stati Alvar Aalto, Hans Scharoun, Rudolf Schindler, Giuseppe Terragni. Manieristi sono tutti gli architetti validi e creativi del dopoguerra, dai brutalisti britannici ai metabolisti giapponesi, da Eero Saarinen ad Aldo van Eyck. Il manierismo è l’alternativa laica alla dogmatica ideologica del classicismo e alle scenografiche ipnosi del Barocco. Borromini fu un tardo-manierista in lotta disperata contro le direttive della controriforma cattolica. Il manierismo può essere drammatico e dolce, è umano. Si possono annoverare vari generi di manierismo. In primo luogo, quello intellettuale e concettuale, «un discorso sui discorsi dei maestri», come in Peter Eisenman e Richard Meier. L’Atheneum di New Harmony, Indiana, denota un acrobatico innesto di linguaggi. Vi si rintracciano elementi semantici di Le Corbusier, Mies, Aalto, Louis Kahn e altri; il risultato è senz’altro un’opera d’arte.
C’è poi un manierismo più inclusivo, meno sofisticato e più popolare: quello di Paul Rudolph, Oscar Niemeyer o del municipio di Boston.
C’è un manierismo eretico, aperto al kitsch, il manierismo del «nonfinito», come nel Mummers’ Theatre a Oklahoma City di John Johansen, e nelle stazioni della metropolitana di Stoccolma.
C’è un manierismo utopistico e un manierismo High-Tech. La stessa architettura organica è manierista perché ha lanciato un ponte tra la scuola Arts & Crafts e il mondo della macchina e, più tardi, tra il cubismo o, meglio, il gruppo olandese «De Stijl» e l’espressionismo tedesco.
Come quello di Michelangiolo, il genio di Wright è manierista. A un tale grado che sia «De Stijl» che il suo opposto, la Scuola di Amsterdam, proclamarono il loro debito con il leader di Taliesin. Anche Erich Mendelsohn si riconobbe e auto realizzò a suo contatto. Scrisse da Chicago: «Ho trascorso due giorni con Frank Lloyd Wright; due giorni nella meravigliosa corrente, densa di aspettative e generosa, tesa e rilassata… Siamo diventati amici subito, stregati dallo spazio, tendendoci le mani uno verso l’altro nello spazio… Wright dice che l’architettura del futuro sarà per la prima volta interamente architettura, spazio in se stesso, movimento in tre o quattro dimensioni, senza alcun modello prescritto, senza abbellimenti… una joie de vivre effusa nello spazio, dionisiaca e divina… Non esiste nessuno che gli si avvicini». Nel 1924, Mendelsohn scopriva ciò che Alois Riegl aveva profetizzato: la formazione dello spazio, in Wright, aveva trionfato sulla composizione delle masse.
Qualche altro attestato a gloria del manierismo. Può essere usato in modo ugualmente intelligente a due livelli linguistici: l’aulico e il vernacolare, l’elegante e lo slang. Storicamente, nel XVI secolo ha intrecciato solo linguaggi aulici, quelli dei protagonisti della generazione precedente. Ma, più tardi, le contaminazioni hanno coinvolto gli architetti minori. Nel campo degli edifici anonimi, dell’«architettura senza architetti», ci sono vari casi di manierismo dialettale.
Il manierismo può essere bilingue e anche trilingue, combinando il livello aulico con quello popolare e tecnologico. Se paragonate cosa è successo nella contaminazione dei livelli linguistici in letteratura, o in musica da Mahler a Ives, con ciò che è accaduto in architettura, avrete l’impressione che il moderno manierismo architettonico sia ancora in uno stato d’infanzia e possa esplorare molti nuovi sentieri creativi nelle prossime decadi.
Ma quali sono i difetti, le lacune del manierismo? Perché dopo venticinque anni passati a insegnare storia come metodologia della progettazione, ho constatato che il manierismo non era sufficiente, e un ulteriore passo in avanti era indispensabile?
Il limite fondamentale del manierismo è stato analizzato da molti studiosi. Per combattere le regole del classicismo e per infrangerle, il manierismo, in qualche modo, ne legittima l’autorità, è costretto a mettere il classicismo su un piedistallo prima di buttarlo giù e fracassarlo. Il manierismo è fatto di dissonanze, ma queste sono concepite come eccezioni alle assonanze, mentre nell’arte moderna, come ha spiegato così chiaramente Arnold Schönberg, le dissonanze non sono più dipendenti dalle assonanze, hanno una vita autonoma, comunicano e si muovono autonomamente. Il manierismo è legato all’invettiva contro il potere totalitario e repressivo, mentre la nostra epoca ormai ne è largamente libera… La nostra condizione è diversa da quella del XVI secolo, non abbiamo l’inquisizione cattolica, i nostri Galilei non devono giurare. Possiamo ancora chiamarlo manierismo ma il nostro è sostanzialmente diverso da quello storico.
Il secondo inconveniente del manierismo è più rilevante. Senza riferimento alle assonanze e liberi da costrizioni, gli architetti medi sono perduti. Domandiamoci: quanti buoni manieristi moderni esistono nel mondo? Cento? Due, cinquecento? Anche a essere molto generosi, si tratta di una trascurabile minoranza rispetto all’obiettivo di creare un ambiente decente e civile, una comunicazione democratica urbana e architettonica. Il manierismo moderno è terribilmente arduo, richiede una costante educazione culturale che la maggioranza degli architetti non è preparata ad assimilare. Piaccia o no, il manierismo moderno è una proposizione aristocratica ed élitaria, riservata solo ai migliori architetti.
L’International Style, i tentativi di fare dell’architettura moderna un altro stile Beaux-Arts, il neo-accademismo, il Post-Modern e il neo-vernacolare sono sintomi delle difficoltà incontrate dal manierismo moderno. Un linguaggio di dissonanze indipendenti è troppo complicato, provoca una nevrosi al giorno. Bisogna ricominciare ogni volta dal Grado Zero della scrittura architettonica, rifiutando il linguaggio aulico e il dialetto, nonché tutte le regole codificate. Un compito troppo impegnativo. Gli architetti vogliono una certa dose di sicurezza, e lo stesso i committenti, che chiedono case apparentemente rassicuranti per nascondere il loro stato insicuro. Sicché l’accademia, con i suoi dogmi obsoleti e l’eclettismo post-moderno con la sua superficiale licenziosità, offrono due strumenti complementari per una simile sicurezza suicida. Situazione inevitabile, o c’è qualcosa da fare? Nel 1973 pensai che qualcosa doveva esser fatto. Per la professione il manierismo non bastava. Occorreva un linguaggio, un linguaggio codificato trasmissibile a tutti, e tale da poter essere scritto da architetti e costruttori, letto da critici e cultori d’arte, parlato dal pubblico. Non si può imparare l’italiano solo ordinando spaghetti e leggendo “La Divina Commedia”. Un linguaggio diventa linguaggio quando passa attraverso un processo di codificazione. Noi abbiamo un solo linguaggio codificato, quello del classicismo Beaux-Arts. Tutto il resto appare deroga, eccezione o negazione di esso. C’è una ragione per cui il linguaggio moderno anticlassico non dovrebbe esser codificato? Arnold Schönberg fu poeta e critico. Creò un nuovo linguaggio musicale, poi lo codificò per renderlo trasmissibile. Al contrario, Voysey e Mackintosh, Horta e Olbrich, Sullivan e Gaudì, Wright, Le Corbusier, Häring e Mendelsohn crearono un nuovo linguaggio architettonico, ma fallirono nel codificarlo. Temettero di stabilire nuove regole, nuovi dogmi, o di promuovere un nuovo stile. Non riuscirono a vedere ciò che Schönberg vide, cioè che c’era un’ alternativa alla codificazione accademica, che si potevano codificare non i paradigmi, non i comuni denominatori, ma le eccezioni, le droghe, le anti-regole. Non un codice costrittivo come quello Beaux-Arts ma, al contrario, un elenco aperto per prevenire le regressioni accademiche.
Nel 1964 John Summerson pubblicò un breve saggio sul “Il linguaggio classico dell’architettura”. Ho aspettato nove anni il suo complemento, un saggio su “Il linguaggio anticlassico” o, semplicemente “Il linguaggio moderno”». Nel 1973, poiché nessuno sembrava averne intenzione, decisi di scriverlo io. Questo saggio, “Il linguaggio moderno dell’architettura”, condensa tutto ciò in cui credo:
– l’architettura è spazio, spazio dinamico in cui muoversi, da usare e da vivere;
– l’architettura moderna coincide con la nuova storiografia, il passato va reinterpretato con occhi contemporanei;
– il linguaggio moderno dell’architettura può essere codificato e reso trasmissibile come quello della musica moderna. Può essere codificato altrettanto chiaramente del suo opposto, il classicismo Beaux-Arts, ma naturalmente usando il sistema opposto di codificazione. Il linguaggio moderno dell’architettura non è semplicemente il linguaggio dell’architettura moderna. I suoi «principi» o «invarianti» sono strumenti per stimolare la nuova architettura, ma anche per capire gli architetti e le architetture del passato.
Ho cominciato con due citazioni, sull’asimmetria e sulla formazione dello spazio. Poi ho cercato di evidenziare come l’architettura moderna sia viva, forte e multivalente, mentre l’International Style, il «classico-moderno» fosse un cadavere almeno cinquant’anni prima che i postmodernisti se ne accorgessero. Ho esaminato il problema del rapporto tra architettura moderna e storia, indicando come i crimini contro la storia vadano ascritti non ai moderni, ma ai pre-anti-post-pest-moderni, a quelli che esaltano retoricamente il passato per distruggerlo con grottesche parodie. Ho analizzato il manierismo moderno nelle sue conquiste e potenzialità, ma anche nei suoi limiti generici che sottolineano l’urgenza di codificare il linguaggio moderno dell’architettura. In ogni senso dobbiamo difendere il passato. Ma sempre ricordando che «le cattedrali erano bianche», ed erano bianche perché erano nuove.
Pubblicazione di “Architectur as language”.
Pubblicazione di "Bruno Zevi o modern architecture"
“Bruno Zevi on modern architecture”
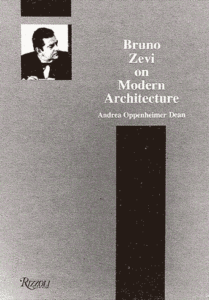 Andrea Oppenheimer Dean, redattrice del «A.I.A. Journal», mensile del prestigioso American Institute of Architects, incontra Ada Louise Huxtable, critico di architettura del «New York Times»: «Ho un’idea, chiedere una borsa di studio per sei mesi e, a Roma, approfondire il modo di pensare di Bruno Zevi». «Ottimo», risponde la Huxtable, «era tempo di svolgere questa ricerca. Conta sul mio pieno sostegno». Bill Lacy, che più tardi dirigerà a New York la scuola di architettura della Cooper Union, è presidente dell’American Academy in Rome.
Andrea Oppenheimer Dean, redattrice del «A.I.A. Journal», mensile del prestigioso American Institute of Architects, incontra Ada Louise Huxtable, critico di architettura del «New York Times»: «Ho un’idea, chiedere una borsa di studio per sei mesi e, a Roma, approfondire il modo di pensare di Bruno Zevi». «Ottimo», risponde la Huxtable, «era tempo di svolgere questa ricerca. Conta sul mio pieno sostegno». Bill Lacy, che più tardi dirigerà a New York la scuola di architettura della Cooper Union, è presidente dell’American Academy in Rome.
Approva la richiesta e la Dean da Washington, D.C., viene catapultata sul Gianicolo.
“Bruno Zevi on Modern Architecture” esce nel 1983 presso Rizzoli International di New York. È composto da pagine biografiche e interviste su esperienze, idee e ideali. Segue un’ampia antologia di scritti, che partono dall’opuscolo anti-Gropius “An Opinion on Architeciure” del 1941 e si concludono con un intervento svolto alla Graduate School della Harvard University nel 1982. Un capitolo fondamentale, destinato ad avere vasta risonanza, è “Ebraismo e concezione spazio-temporale dell’arte”, pubblicato in italiano in “Pretesti di critica architettonica”, Einaudi, Torino 1983. Il libro di Andrea Oppenheimer Dean completa l’opera di penetrazione nella cultura anglosassone esplicata per decenni mediante conferenze, articoli, collaborazioni a riviste, e i seguenti volumi: “Towards an Organic Architecture”, Faber & Faber, London 1949; “Architecture as Space – How to Look at Architecture”, Horizon Press, New York 1957 e Da Capo Press, New York 1993; “The Modern Language of Architecture”, University of Washington Press, Seattle 1978 e Van Nostrand Reinhold Company, New York 1981.
Andrea Oppenheimer Dean “Bruno Zevi on modern architecture”, Rizzoli International, New York 1983.
Pubblicazione di "Pretesti di critica architettonica".
1984
In marzo, si dimette dal comitato di redazione dei piani di edilizia economica e popolare del Comune di Roma.
La lettera di Zevi: «Politica elettoralistica, disastro irreversibile».
“Il Messaggero”, 12 marzo 1984
 Questa è la lettera con la quale Bruno Zevi rinuncia all’incarico di progettista dei nuovi piani di edilizia economica e popolare. La lettera è indirizzata all’Assessore al Piano Regolatore, Vincenzo Pietrini, socialista.
Questa è la lettera con la quale Bruno Zevi rinuncia all’incarico di progettista dei nuovi piani di edilizia economica e popolare. La lettera è indirizzata all’Assessore al Piano Regolatore, Vincenzo Pietrini, socialista.
Ecco i motivi che mi inducono a rinunciare e a pregarti di sostituirmi:
1) Formazione dei gruppi professionali. Risultano palesemente frutto della consueta lottizzazione partitica. Mi pare che questo non sia più sopportabile. I socialisti non possono continuare a condannare a parole il metodo della lottizzazione, e poi ad adottarlo.
Qualcuno deve dire: NO. I lottizzati e i lottizzanti non possono. Spetta dunque a persone come me dare un esempio, anche perché, più che un professionista, sono uno studioso.
2) Piano P.E.E.P. I suoi criteri di impostazione, benché sottoscritti da quattro esperti di sicuro prestigio, non mi convincono. Per le seguenti considerazioni: a) i comunisti preposti all’urbanistica capitolina hanno sfasciato l’organismo della città, obliterando il magistrale Piano Regolatore concepito dal socialista Luigi Piccinato nel 1962; esattamente come lo avevano disatteso i democristiani, e peggio. I comunisti hanno profuso le risorse comunali per attrezzare e dotare di servizi le borgate abusive, premiando l’edilizia illegale e incrementandola in grado vertiginoso. Hanno optato per una politica meramente elettoralistica, ai danni della città, dei suoi abitanti vecchi e nuovi, ricchi e poveri e a vantaggio soltanto della speculazione mafiosa;
b) i socialisti coinvolti nell’amministrazione capitolina non hanno avuto la forza di opporsi allo scempio, non hanno potuto affermare la priorità dell’Asse Attrezzato e dei Nuovi Centri Direzionali, che avrebbero evitato l’invasione del terziario nelle zone residenziali e quindi la necessità di costruire altri alloggi in una città che ne possiede sin troppi;
c) compiuto un disastro irreversibile, i comunisti hanno passato la gestione urbanistica ai socialisti. Tutto era già pregiudicato. Cosa restava da fare? La cosiddetta “ricucitura”: una miriade di insediamenti che, in teoria dovrebbero incentivare il risanamento dell’ambiente circostante, ma che, in pratica, con ogni probabilità ne saranno fagocitati.
Basta una buona architettura per garantirci che ciò non si verifichi? Ne dubito. E poi: quando finirà questa prassi suicida di moltiplicare squallidi quartieri-dormitorio nell’estrema periferia romana mentre le abitazioni del centro storico e della fascia adiacente vengono trasformate in uffici?
Chi si opporrà al perpetuarsi di questo circolo vizioso? E quando? E come?
3) I socialisti hanno ereditato la bancarotta urbanistica causata dal malgoverno comunista. Fanno quanto possono, con la migliore buona volontà, ma purtroppo nella logica della bancarotta. Non hanno ancora formulato un “progetto alternativo socialista per Roma”, capace di determinare un’inversione di tendenza. Sicché la “galoppante schizofrenia” del Pci, come l’ha definita il compagno prosindaco Pierluigi Severi, continua a dominare l’urbanistica della capitale.
E giungo alla conclusione.
Credo fermamente nell’utilità di uno scambio assiduo e di una collaborazione tra politici e intellettuali, a condizione però che non comporti un appiattimento della cultura sul potere.
Gli amministratori socialisti del Comune di Roma avranno valide ragioni per accettare il disagio di questa fallimentare situazione urbanistica. Agli intellettuali spetta un compito diverso: quello di mostrare che non tutti i socialisti sono disposti a subire gli scandali della lottizzazione e a prolungare, con rimedi non idonei, i guasti democristiani e comunisti.
Un senso di responsabilità per l’immagine del Psi a Roma mi spinge dunque a pregarti di esonerarmi dall’incarico affidatomi, per il quale torno ad esprimerti la mia sincera gratitudine.
-
Relatore ai colloqui dei critici nell’ambito dell’IBA di Berlin (25-26 settembre).
-
Relatore al convegno dell’UIA sul tema “Man and Space” tenuto a Vienna il 30 maggio.
Direttore della collan "Comunicare l’Architettura" per la SEAT fino al 1984.
“Comunicare l’architettura”
 20 monumenti, 20 complessi edilizi, 20 spazi aperti italiani
20 monumenti, 20 complessi edilizi, 20 spazi aperti italiani
Come si vive un edificio. «L’architettura è atto generatore e poi fruizione cinetica, polisensoriale e non solo ottica, di vuoti parlanti, di cavità compresse o dilatate, di spazi sostanziati dalla luce e animati da frequentatori e abitanti. Capire l’architettura significa scoprirne i molteplici percorsi, le accelerazioni e le pause, le cerniere strutturali, i riverberi degli involucri murari sugli invasi e anche gli apparati plastico-decorativi in quanto funzionali a un risultato spazio-temporale».
Come si sperimenta un complesso edilizio.
«Numerose voci stridenti, codici contraddittori, timbri espressivi inconciliabili sboccano spesso in un discorso frammentato e dissonante; in cui i gesti poetici s’intrecciano con lunghe pause prosaiche. Se un monumento può essere paragonato a una lirica, un complesso edilizio è un romanzo scritto a più mani, nel quale spiccano solo alcuni squarci autenticamente creativi. Ma è nel dialogo sempre intermittente, imbrigliato e tronco, tra poesia e prosa che sta la sua forza segreta… Un complesso edilizio è una sommatoria di non-finiti e da questa condizione trae la sua carica comunicativa.
Attenua o rinnega la mania amalgamatrice, ama e celebra il sospeso, l’incerto, la soluzione esitante, il marginale e il mutevole. Alla spasmodica, psicopatica pretesa di “ordine”, che nasconde intima insicurezza e tendenza alla coercizione, replica esaltando la “deregulation”, il turbamento, la sorpresa, l’anomalo. All’astratto, monocorde ideale accademico sostituisce la rozza, sanguigna registrazione storica».
La fruizione degli spazi aperti.
«Contrariamente a quanto accade negli invasi racchiusi, gli spazi urbani si qualificano per la molteplicità delle loro slabbrature: le figure geometriche si alterano per colloquiare con l’intorno stabilendo incessanti rimandi e fluenze. L’atmosfera, la luce del cielo, la nebbia, i temporali, la neve, il traffico, gli elementi naturali, gli eventi del quotidiano rendono questi vuoti continuamente mutevoli… Il codice del non-costruito esige una percezione, una sapienza di lettura quanto mai ardua e complicata, poiché i riferimenti agli involucri edificati e agli altri spazi aperti sono innumerevoli… La paura del vuoto, inteso come negatività, è ancestrale; per millenni l’uomo ha avuto il terrore dell’inafferrabile, del non-tattile, del non costruito e l’agorafobia è tuttora un diffuso sintomo nevrotico. Questo libro punta a tradurre in gioia l’arcaico timore per i valori immateriali e invisibili: induce a vivere gli spazi aperti recependone i vari spessori, i messaggi e i significati, lasciandosi avviluppare e partecipando alle loro inaspettate avventure».
Da questi brani tolti dalle prefazioni ai volumi si coglie lo scopo di un’impresa durata dal 1984 al 1986, patrocinata con generosità dalla Seat, e specificamente dal suo presidente e amministratore delegato Francesco Silvano, per impulso di Carmine Benincasa. Si tratta indubbiamente di uno dei più incisivi contributi alla storiografia architettonica di questi decenni, ma purtroppo il vincolo di non metterlo in vendita ne ha diminuito la diffusione e l’efficacia. La collana avrebbe potuto essere estesa con altri due volumi: 20 città e 20 territori.
Polemica sulla ricostruzione del teatro Carlo Felice di Genova.
Che pasticcio quel teatro. Genova proprio non lo merita
“la Repubblica”, 29/30 aprile 1984, di Daniela Pasti
 Zevi risponde a Gardella sul progetto del Carlo Felice
Zevi risponde a Gardella sul progetto del Carlo Felice
Il giorno decisivo sarà il 24 maggio: nessun riferimento al passaggio del Piave ovviamente, la battaglia questa volta è di carattere culturale. Quel giorno, sul palcoscenico del teatro Duse a Genova, si discuterà del futuro del Carlo Felice; fautori e nemici del progetto Rossi-Gardella (subito battezzato «l’infelice») si affronteranno in un dibattito che già si prevede affollatissimo. Perché sulla vicenda del concorso per il nuovo teatro ormai la polemica è divampata e se all’inizio è stata soprattutto una “querelle” fra urbanisti e architetti, adesso coinvolge e appassiona tutta la città.
Bruno Zevi nel suo studio romano promette: «saranno fuochi di artificio», e si frega le mani camminando a passi da lupo su e giù per la stanza. È stato lui il primo artificiere, quello che ha dato fuoco alle polveri con un attacco diretto e senza mezzi termini contro la decisione della commissione giudicatrice di premiare il progetto firmato dagli architetti Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt e Angelo Sibilia, fra i sette arrivati in finale. A quella decisione la commissione formata da 28 persone è arrivata dopo un estenuante numero di riunioni, anche se la vittoria di Rossi veniva data per certa già dal primo giorno. E questo è il punto, almeno uno dei punti sul quale Zevi ha portato il suo attacco. A Bruno Zevi ha replicato Gardella giovedì scorso sulle pagine di “Repubblica”, ora la parola è di nuovo a Zevi che controbatte specificando meglio le sue accuse.
Professore, allora il suo è stato uno sfogo «emotivo e insultatorio» come ha detto Gardella?
«Naturalmente ho letto con attenzione l’intervista a Ignazio Gardella che conferma quanto avevo intuito: lui è solo marginalmente responsabile di questo obbrobrio. Lo ha firmato: è indubbiamente una colpa, un atto di debolezza, afferma però che lo sviluppo del progetto è stato seguto più da vicino da Rossi e Reinhardt. Ma Gardella sbaglia quando considera che ciò è giusto perché Rossi è di una generazione più giovane di lui. È vero il contrario: un accademico neo-classico anche se ha 43 anni e passa per comunista, può essere precocemente decrepito. La storia è piena di giovani conformisti e reazionari… Gardella, a 79 anni, come architetto ha circa due secoli meno di Aldo Rossi»
Gardella difende il comportamento della giuria, perché lei è così critico nel confronti di Aymonimo, Valle e Portoghesi che ne fanno parte?
«I fatti sono quelli che sono. Carlo Aymonimo è stato per anni direttore dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia e Gino Valle ne è tuttora professore. Com’è ovvio, hanno legami di amicizia con Gardella e Rossi, professori nella stessa scuola. Valle è discepolo di Gardella, Aymonimo ammira Rossi. Nulla di grave; ma è certo che due “veneziani” in commissione bastano.
Invece il Comune ci mette dentro anche Paolo Portoghesi, presidente della Biennale di Venezia, esaltatore fanatico e cieco delle posizioni retrologiche di Rossi, a cui ha affidato il progetto del teatro-baracca galleggiante, nonché l’ingresso della mostra di architettura del 1980, e che poi ha chiamato come proprio sostituto al posto di direttore del settore architettura della Biennale. No, è troppo: ognuno andrebbe bene, per conto suo; tutti e tre insieme, no. Controprova: si è subito detto: vincerà Rossi, e cosi è stato».
Ma perché il Comune ha scelto come terzo membro tecnico proprio Portoghesi?
«Ho qui una lettera del Sindaco Cerofolini, socialista, che mi dice che hanno dovuto chiamare Portoghesi perché già gli avevano affidato una ricerca sugli spazi culturali della città…ma questa è una giustificazione ridicola».
Cerofolini è socialista e anche Portoghesi lo è: questo può essere un motivo?
«Può esserlo, può esserlo, anche se sia detto per inciso, pure io sono socialista. Ma io mi attengo ai fatti e i fatti sono che tre veneziani in commissione non andavano messi. E che il progetto che hanno approvato è la più grande pazzia architettonica dopo il monumento a Vittorio Emanuele II.
Ma guardi, guardi qui (aprendo un libro sull’architettura nazista) guardi se non è degno di stare in mezzo a queste cose, con il suo neoclassicismo, e la sua torre bruttissima. E vuole sapere, la contraddizione più smaccata è che proprio Gardella, sotto il fascismo, rifiutò di partecipare al concorso per l’Eur, perché non voleva saperne di quelle colonne…».
Gardella però afferma che questa opera è coerente con il suo lavoro precedente e che «coerenza non vuol dire immobilismo».
«Ma per carità…io annovero il Dispensario antitubercolare di Alessandria e la Casa delle Zattere di Venezia, entrambe opere di Gardella, tra le realizzazioni più significative dell’architettura italiana. E non ho niente da eccepire sulla sua affermazione che la consonanza col luogo è uno degli aspetti dell’attuale momento di ricerca architettonica, è un principio wrightiano. Ma nel progetto Rossi non c’è alcuna ricerca di consonanza: si copia malamente il Barabino, si propone un’orrenda, disgustosa torre che, se costruita, farebbe rivoltare nella tomba il povero Barabino.
Questa è «consonanza»? L’indecente pasticcio stilistico, tipico del peggior eclettismo accademico nostrano?».
Parliamo di costi: il progetto Rossi costerà 80 miliardi, mentre quello di Ladun, l’architetto che ha progettato il National Theatre a Londra, che inizialmente piaceva di più alla maggioranza della commissione, era anche molto più costoso.
«lo sono contrarissimo all’appalto-concorso che chiama a partecipare le ditte costruttrici, le quali a loro volta si rivolgono agli architetti per il progetto. Per una cosa di questa importanza era meglio fare prima un concorso direttamente per i progettisti e poi un appalto fra le ditte costruttrici. Però se si entra in questa logica, perché allora non ha vinto il progetto di Viganò che costava ben 30 miliardi in meno della soluzione Rossi-Gardella?».
A chi tocca ora decidere se dare il via alla costruzione?
«Tocca al Consiglio comunale di Genova e io mi auguro che il Consiglio non accetti il responso della giuria, ed eviti lo scempio del centro urbano proposto da Rossi. Genova ha un record glorioso nella storia dell’architettura moderna italiana, non è ammissibile che si tradisca il passato e il presente in omaggio a un falso pseudo-neoclassico. Sarebbe il segno di una involuzione culturale tanto più tragica perché subita da un’amministrazione a guida socialista. Per me il socialismo moderno, il liberal-socialismo è insieme politica e cultura, e quindi non può arrendersi e abdicare di fronte all’incultura».
Zevi, Portoghesi: sul Carlo Felice è subito polemica
“Corriere mercantile”, 20 gennaio 1984
“Per concludere e completare la panoramica sul problema della ricostruzione del “Carlo Felice”, abbiamo chiesto il parere di esperti quali i professori Bruno Zevi e Paolo Portoghesi e di persone particolarmente interessate a tutta la vicenda: il professor Gianfranco Bruno, direttore dell’Accademia di Belle Arti e la prof.ssa Giacomina Calcagno direttrice della biblioteca Berio.
Infine abbiamo ascoltato l’opinione di Franco Ragazzi, Sovrintendente al Teatro dell’Opera che è anche membro della commissione esaminatrice.
Bruno Zevi
Il professor Bruno Zevi è uno dei maggiori esperti di storia dell’architettura moderna. Già docente universitario presso le Facoltà di Architettura di Venezia e di Roma, ha, alcuni anni fa, abbandonato clamorosamente l’attività didattica. È la più autorevole voce della critica “razionalista” in architettura.
Professor Zevi, Genova…
«Genova, Carlo Felice. Bene, bene. Mi dica chi ha vinto.»
Non ha ancora vinto nessuno. lei pensa che il teatro vada comunque ricostruito, indipendentemente dai costi?
«È paradossale. Adesso che Genova è in crisi c’è chi dice che il teatro costa troppo, durante la Genova prospera si era tentato di ricostruirlo e poi non s’è fatto. Seguo questa faccenda del Carlo Felice con estrema attenzione sin dal 1948/49. Il progetto Scarpa era ottimo ma non è mai stato definito. Ogni volta che ho scritto qualcosa su Genova, il ponte dell’Italsider o qualsiasi altra cosa, ho tirato fuori il tema del Carlo Felice. Insomma, l’Opera di Parigi costa 36 milardi, e noi non ne possiamo spendere qualcuno in più?
Quello che ritengo indecente è di aver realizzato un appalto-concorso che mischia l’offerta economica con la qualità progettuale. Molto meglio sarebbe stato un concorso di idee. Ci sono in lizza comunque dei grandi nomi dell’architettura. Per esempio Denis Lasdun, medaglia d’oro della Royal Academy. Il teatro va fatto e subito. Avremo finalmente a Genova un documento di respiro europeo».
Che ne pensa delle polemiche circa un’eventuale incompatibilità fra alcuni commissari e alcuni concorrenti?
«Non si capisce perché dei professionisti di valore come Portoghesi agiscano così scorrettamente. È noto a tutti che il posto di Portoghesi alla Biennale di Venezia, alla sua elezione a presidente, l’ha preso Aldo Rossi, uno dei concorrenti del Carlo Felice.
Come pure il fatto che il commissario Aymonino ha firmato vari progetti insieme al concorrente Rossi. Basti pensare al famoso «steccone del Gallaratese» che è riuscito anche a vincere il trofeo Muggia nel 1977, un premio che si assegna all’architettura più brutta dell’anno.
La deontologia professionale avrebbe dovuto imporre delle dimissioni. Comunque quando nomineranno il vincitore sarò contento per la città e lieto di darle un mio giudizio».
Il fascismo in architettura
“Dichotomy”,vol. 3, autunno 1979, con il titolo originale “On Architectural Criticism and Its Diseases”.
Il problema principale della critica architettonica oggi consiste in un eccesso di tautologia. Si ha l’impressione che i critici siano agnostici o cinici, che non credano in nulla e spesso non siano neppure interessati all’architettura.
Giustificano infatti ogni genere di tendenze estetiche:
International Style, Revivalism, Spontaneismo, Neoliberty, Vernacolare, Pop, Contestualismo, Beaux-Arts e Post-Modern. Spiegano con virtuosismo l’ideologia che si suppone nascosta dietro ogni progetto o edificio. Qualsiasi sciocchezza, qualsiasi idiosincrasia, ammantata di acrobatiche teorizzazioni, assume strepitosa importanza. La critica è davvero largamente responsabile della confusione che domina la scena architettonica. Accettando ogni fenomeno e il suo contrario, è tautologica con raffinata e ironica compiacenza.
Qualche esempio. L’attività progettuale dei «New York Five» (specie di Richard Meier, John Hejduk e Peter Eisenman) fu un aspetto significativo del manierismo contemporaneo, ma Colin Rowe e Kenneth Frampton gli conferirono una tale aureola che, per vari anni, gli studenti di architettura si sentirono in dovere di imitarlo. L’eclettismo può essere un’arma utile contro la rigidità dell’International Style, ma Charles Jencks con il suo «Post-Modernism», ha incoraggiato la più caotica e insensata anarchia. Probabilmente Arthur Drexler ha creduto che, dopo quattro decadi di ostracismo, fosse giusto riconsiderare i frutti della parigina École des Beaux Arts, ma la rassegna da lui allestita al Museuum of Modern Arts di New York divenne un alibi per folli retrocessioni neoclassiche. Un altro caso: se Philip Johnson disegna un AT&T Building in fogge palladiane senza capire niente di Palladio, potete essere certi che alcuni critici lo applaudiranno con entusiasmo, o almeno «spiegheranno» per quali motivi universali e stratosferici abbia prodotto una simile grottesca atrocità.
Si può obiettare: se gli architetti sono confusi, anche i critici lo diventano; la storia dell’arte va insieme all’arte. Questo è vero quando la critica architettonica è mera tautologia. Ma un critico pronto ad accettare e ideologizzare ogni moda, anche la più stupida, non è un critico. Gli atteggiamenti passivi sono altrettanto negativi nella storia e nella critica dell’architettura. Allo slogan che la storia «non si fa con i se» dobbiamo rispondere che o si fa con una serie di «se», o è meglio rinunciare perché diventa tautologica. Analogamente con la critica:
bisogna avere il coraggio di dire NO, di ripudiare ciò che non ha senso.
L’obiettivo principale del critico dovrebbe essere di preservare i valori che le mode, per ragioni commerciali, tendono a dissipare. Il movimento moderno ha generato molti valori basici e permanenti, insieme ad alcuni fattori transeunti e datati. Il compito di un critico dovrebbe essere di impedire che il bambino venga gettato via con l’acqua sporca del bagnetto. Constatiamo invece che la maggior parte dei critici, per sentirsi à la page, proclama che il movimento moderno è un «fiasco», che è un equivoco, che non è mai nato, anzi che l’architettura stessa è morta. Inclinazione necrofila ridicola, che tuttavia influenza numerosi studenti di architettura, riducendo la loro gioia e frustrandone gli impulsi.
Ogni critico dovrebbe sentire il dovere di dichiarare ciò in cui crede, e specialmente ciò a cui si oppone. Sono pronto a farlo, e non temo che qualcuno reputi le mie convinzioni «troppo semplicistiche», «unilaterali», «piuttosto ingenue», «rigorose oltre il dovuto» o «esagerate».
Sono abituato a questo tipo di giudizi.
In politica, nell’etica, nei comportamenti, nell’arte e, naturalmente, in architettura, sono contro il fascismo. Per esso non intendo soltanto Mussolini, Hitler e Stalin, ma tutti gli assolutismi e totalitarismi. Da questo punto di vista, le «assolute verità» dell’Illuminismo e i dogmi marxisti sono fascisti. Regole, ordini, precetti, proporzioni, monumentalismi sono espressioni di potere. Tendono a opprimere l’individuo, a negare il diverso, a escludere le eccezioni. I «lumi» intellettuali possono essere fascisti se non ammettono ombre. Dunque, il fascismo è un morbo piuttosto complesso e insinuante, che s’infiltra dovunque e che dobbiamo estirpare ogni giorno dentro noi stessi.
Ci sono tendenze fasciste nell’architettura preistorica; in Egitto, dove le piramidi furono costruite da schiavi ebrei; in Grecia, dove i templi sembrano incarnare una concezione statica, impersonale della vita. C’è molto fascismo, ovviamente, nell’architettura romana. Non meraviglia trovare tendenze fasciste nel Rinascimento, nel Barocco e in particolare nel periodo neoclassico. Il movimento moderno è nato per combattere il fascismo: le sue origini, con William Morris e il ciclo Arts & Crafts, furono esplicitamente antifastiste. Più tardi, elementi fascisti corruppero il Movimento Moderno, sebbene in misura limitata. L’International Style tentò di imporre una dittatura, e per questo, dall’inizio della mia attività di storico e critico, l’ho sentito ostile. Ho creduto, e ancora credo, in un’architettura democratica, organica, rappresentata non solo dal genio di Frank Lloyd Wright, ma anche da alcuni esponenti espressionisti e neo-espressionisti come Erich Mendelsohn, Hugo Häring, Hans Scharoun, Rudolf Schindler, Alvar Aalto. Sfortunatamente non c’è una divisione recisa tra architetti fascisti e antifascisti: lo stesso architetto può essere democratico in un edificio e fascista in un altro; Mies van der Rohe è stato democratico nel padiglione tedesco a Barcellona del 1929, ma alquanto fascista nel Seagram Building di New York. Aalto fu democratico in tutte le sue opere, a eccezione del Palazzo Enso-Gutzeit a Helsinki. Le Corbusier fu quasi fascista nel tracciato ellenizzante di Chandigarh. Brasilia è una città fascista, benché Lucio Costa e Oscar Niemeyer si siano sempre opposti alla dittatura. Comunque, non ricordo un solo edificio fascista di Frank Lloyd Wright.
Nel saggio “Il linguaggio moderno dell’architettura” ho cercato di mostrare cos’è il fascismo in chiave architettonica. Sette caratteristiche: a) indifferenza ai contenuti sociali e alle funzioni; b) simmetria, consonanza, proporzione; c)tridimensionalità prospettica; d) scatole, volumi compatti, sia in pietra che in vetro; e) costruzioni tradizionali con pilastri e travi; f) spazi statici e monumentali; g) Isolamento dell’edificio dal contesto.
In antitesi, le caratteristiche di un’architettura democratica sono: 1) interpretazione creativa dei contenuti e delle funzioni come base del metodo progettuale; 2) simmetria, dissonanza, proporzioni umane anziché astratte proporzioni formali; 3) tridimensionalità antiprospettica; 4)scomposizione della scatola e simbiosi interno-esterno; 5) membrane, conchiglie, aggetti e sconvolgimento degli elementi architettonici nel gioco strutturale; 6) spazi dinamici, pensati non per la contemplazione ma per l’uso; 7) continuità tra edificio e città, tra città e paesaggio. Non ho inventato questi sette principi. Come storico li ho ricavati scientificamente dalle esperienze del movimento moderno. Il principio 1) deriva da William Morris, dal suo antiformalismo. Il principio 2) nasce dall’Art Nouveau e dal Bauhaus. Il principio 3) dal cubismo. Il principio 4)dalla sintassi «De Stijl». Il principio 5)dall’ingegneria moderna. Il principio 6) da Einstein e Wright. Il principio 7) dall’urbanistica più avanzata. Con stupore e tripudio, ho scoperto che gli stessi principi si applicano a tutta l’architettura creativa del passato. Tutti gli artisti veri e originali sono «moderni»; i loro messaggi sono sempre aggressioni alle regole.
I sette principi dell’architettura fascista sono regole. Quelli dell’architettura democratica invece sono anti-regole, mirano a liberare dalle imposizioni del potere, sono incentivi all’emancipazione.
Ho collaudato questi principi sui tavoli da disegno, per vari anni nella professione e nelle scuole. Credo che siano utili; in ogni caso, non conosco metodi migliori. Non capisco come si possa insegnare progettazione, o criticarla, senza qualche criterio. Si può optare per i principi democratici o fascisti (= illuministi, classicisti). Ma, senza principi, si abdica accettando quelli del potere.
Il mio punto di vista è premeditatamente «esagerato»; e ciò, considerando l’attuale epidemia di tautologia, può sembrare inelegante. Ma è necessario, almeno per avere qualcosa su cui essere in disaccordo.
Oggi, di norma, non siamo né d’accordo né in disaccordo perché abbiamo poco su cui discutere.
Maimonide diceva che la verità si può trovare solo in eventi rari ed eccezionali. Lo stesso vale per l’architettura. Contro l’amalgama, la piattezza, il livellamento fascista, possiamo scegliere l’inventività, l’eresia di un’architettura emancipata.
1985
-
Membro del comitato Amici di Palazzo Grassi a Venezia.
-
Membro del consiglio di amministrazione della Quadriennale d’Arte, i rappresentanza del Comune di Roma.
1986
Relatore al convegno “The Wright Hand” indetto dalla University of Michigan at Ann Arbour in aprile.
Non si invalida l’eredità wrightiana
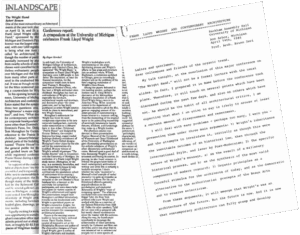 Intervento conclusivo al convegno “The Wright Hand”
Intervento conclusivo al convegno “The Wright Hand”
University of Michigan, Ann Arbour Michigan, aprile 1986
Tratterò l’argomento sotto tre tagli critici:
1) i tentativi di invalidare l’eredità wrightiana, prima come se ciò fosse l’inevitabile conseguenza di una legge storica, poi attraverso l’International Style e il Post-Modernism;
2) lo specifico significato del messaggio di Wright quale a) risultato di un processo millenario e b) sintesi delle plurime componenti della ricerca moderna;
3) principi organici quale potente stimolo per gli architetti oggi, quale unica alternativa democratica ai precetti autoritari delle Beaux-Arts e alle evasioni eclettiche.
È chiaro come quella di Wright sia un’architettura del futuro. Ma il futuro è adesso. Questo è il momento in cui l’architettura contemporanea può assorbire l’immenso patrimonio wrightiano di progetti e idee. Quanto al primo tema, abbiamo rifiutato di accettare la presunta «legge» secondo la quale, dopo un’étà creativa improntata dalla presenza di un genio, ne deve per forza seguire un’altra che annulli le conquiste della generazione precedente. Alcuni riferimenti al passato delucideranno questo punto.
In epoca antico-romana, il tempo dell’imperatore Adriano fu rilevante perché seppe iniettare flessibilità in un linguaggio edilizio rigido e repressivo sperimentando le articolazioni dello spazio interno. Dopo questa stagione quasi tutti i raggiungimenti linguistici della fase adrianea furono obliterati.
Lo stesso in età bizantina. Hagia Sophia è un capolavoro straordinario per la sua dialettica fra cavità compresse ed espanse. Questa concezione non fu trasmessa, tanto che le moschee, comprese quelle di Sinan, ignorano i contrasti spaziali e gli esplosivi effetti di luce di Hagia Sophia.
In Europa, specie tra i maestri italiani, il fenomeno è ancor più stupefacente. Filippo Brunelleschi fu il genio che, nel XV secolo, misurò con la prospettiva il dinamismo gotico senza disperderne o appiattirne le tensioni. Quando morì, i suoi edifici furono criminalmente alterati. Prevalse un Rinascimento basato sulle misinterpretate teorie di Leon Battista Alberti, e poi un classicismo che era esattamente agli antipodi degli ideali di Brunelleschi.
Michelangiolo ripudiò con violenza il classicismo rinascimentale. Sue furono le incredibili invenzioni di spazi rarefatti e centrifugati, e quindi la poetica del «non-finito». Ma chi portò avanti questa eretica indagine?
Nessuno. Se considerate l’architettura europea dopo la sua scomparsa, trovate una situazione di indifferenza, delusione e cinismo. È come se Michelangiolo non fosse mai esistito.
Analogamente per il terzo genio dell’architettura italiana, Francesco Borromini, il travolgente maestro del Barocco romano. Egli si suicidò. I suoi nemici stavano vincendo la battaglia, opponendo alle sue intensamente personalizzate interpenetrazioni di spazi i loro allestimenti scenografici retorici e spettacolari. Borromini non ebbe discepoli. Fu dimenticato per molto tempo, dopo di che emerse un «borrominismo», ma a livello decorativo.
Sembra una sorta di destino pendolare. A ogni stagione di progresso segue una svolta reazionaria e si ricade nella corruzione accademica.
Naturalmente, Brunelleschi, Michelangiolo e Borromini furono sempre esaltati a parole, ma proprio dalla gente che faceva il contrario di quanto essi avevano propugnato.
Dopo la morte di Wright sentimmo che, ancora una volta, avrebbero cercato di metterlo su un piedistallo posticcio, proclamando che era un genio ma, come tale, doveva essere liquidato al più presto.
Molti alibi ideologici sono stati usati per giustificare quest’opera di annientamento. In primo luogo, è stato detto che la democrazia di massa implicava la vittoria della mediocrità. Wright era per la sovranità dell’individuo, e perciò osteggiava un simile concetto negativo della democrazia di massa, ch’egli bollava con il termine «mobocracy».
Il secondo alibi concerneva la standardizzazione come simbolo della società industriale. Wright era contro questo dogma, e fu considerato un romantico, un utopista forse da ammirare ma da condannare. L’International Style, si affermava, rappresenta il mondo industriale e deve vincere. Così, per decenni, noi combattemmo contro l’International Style e la maggioranza dei critici architettonici che lo sostenevano.
Come è noto, a un certo momento la moda dell’International Style crollò. Improvvisamente quasi tutti i critici dell’«establishment» cambiarono idea. Mies van der Rohe cessò di essere un eroe: le sue belle «scatole», belle ma scatole, furono guardate con sospetto.
Splendido! pensammo. Wright ha resistito da solo, o con pochissimi altri come Lewis Mumford, contro l’International Style. Adesso tornerà sulla scena.
Ma la crisi dell’International Style, che altro non era se non la versione classicizzata, statica e meccanica dell’avanguardia degli anni Trenta, non condusse alla visione wrightiana proiettata verso il futuro, ma al grottesco ritorno al passato del Post-Modernism. Dapprima si presentò il gruppo di Robert Venturi, il quale non capì che il prodotto della sua intelligente tesi su «Complessità e contraddizione in architettura» doveva essere l’indirizzo organico, e non una sofisticata mistura di Palladio e Las Vegas. Poi Philip Johnson fece il salto indietro da Mies al Rinascimento. Il paradosso fu che, nel giro di ventiquattro ore, innumeri architetti divennero storicisti. Non conoscendo quasi nulla del passato, spinti dai direttori di riviste, dai critici e dal terrore di perdere il treno, cosa fecero? Si aggrapparono all’anti-storia, cioè alle regole stilistiche dell’École des Beaux-Arts, a un nostalgico bricolage di citazioni dei più anti-storici principi del design.
La povertà del Post-Modernism è tale che hanno tentato di coinvolgervi persino Wright. Ovviamente, il maestro di Taliesin non è affatto Post-Modern. Ma è certo che la sua visione anticipò la società post-industriale, un mondo non più basato sulla congestione, sulla standardizzazione, sulla massa e sull’idolatria della macchina. La sua è un’architettura di vera libertà, esattamente l’opposto di un’architettura di evasione, licenza, capriccio, dove ogni scelta è ammissibile perché non interessa a nessuno.
Il convegno «The Wright Hand» di Ann Arbour passerà negli annali della cultura architettonica almeno quanto il symposium del 1962 alla Columbia University di New York. Là venne riscoperta la lezione dell’espressionismo; qui, quella organica e il suo domani. La pretesa legge storica che vorrebbe archiviare ogni genio e dimenticarlo è stata smentita. È nata «l’altra tradizione», come è stata denominata, quella di architetti giovani e vecchi, grandi e mediocri, ma appassionati: hanno deciso che l’eredità wrightiana non sia cancellata.
Vengo al secondo argomento: la natura specifica del messaggio wrightiano. Ventisette anni dopo la sua morte, constatiamo che l’architettura contemporanea è, per molti versi, ancora indietro rispetto ai traguardi raggiunti da Wright. Certo, lo stesso può dirsi per il 1473, il 1591, il 1694, ventisette anni dopo la scomparsa di Brunelleschi, Michelangiolo e Borromini. Il grande storico Charles de Tolnay scrisse che non fu Michelangiolo a costituire un ponte tra il Rinascimento e il Barocco, ma che il Barocco fu un compromesso tra il Rinascimento e Michelangiolo: un’assurdità sotto il profilo cronologico, ma un’asserzione vera e geniale in chiave linguistica. Perché la traiettoria di Michelangiolo, compresa solo da Borromini, superò di molto l’esperienza barocca. Qualcosa di simile è avvenuto con Wright: molta architettura contemporanea si trascina dietro di lui, poiché ne ha largamente dissipato l’eredità.
Architettura come spazio. La nostra è l’età della risposta organica negli edifici, nelle città e nei paesaggi. Siamo in un periodo adulto, che abbandona gli schemi semplificati e puritani dei pionieri per entrare in una fase di matura complessità. L’autentica architettura, insegna Wright, quella del futuro, ma anche del presente e del passato, concerne, plasma, inventa lo spazio vivibile, umano, lo «spazio in sé» a servizio dell’individuo e della comunità.
Lo spazio non è un mero ingrediente del processo formativo dell’architettura. È il filtro attraverso il quale tutti gli elementi e le componenti attingono la loro legittimazione architettonica. Un sito, un luogo raggiunge la sua identità in termini d’architettura solo quando approda allo status di spazio; altrimenti è solo un personaggio in cerca d’autore. Una forma plastica è scultura, diviene architettura se è coinvolta dallo spazio; anche lo «spazio scultoreo» non è sempre architettura, perché lo spazio non dovrebbe dipendere da un contenitore scultoreo, ma forgiarlo. Lo spazio è il vuoto, la cavità artisticamente animata, la negatività dell’edificio tramutata nell’azione più struggente e creativa.
Wright voleva, come scrisse Erich Mendelsohn, un’architettura «totalmente architettura – spazio in se stesso». Quest’obiettivo non riguardava un mitico sogno personale, ma segnava l’esito dei tentativi esperiti lungo millenni, dal terrore del vuoto nella preistoria al cilindro cupolato del Pantheon, dal dinamismo tardo-antico alla bidirezionalità gotica e all’intricata esplorazione barocca. Questo fermento di secoli e secoli sfocia nelle affascinanti, ipnotiche immagini wrightiane.
Inoltre, Wright sintetizza le conquiste delle numerose correnti moderne, dall’ingegneria del XIX secolo al movimento Arts & Crafts, dall’Art Nouveau al razionalismo e all’espressionismo. Egli incorpora tutti i valori spaziali che incontra, stimolandone lo sviluppo. Dal 1910 Wright è il punto di riferimento progettuale dei più contrastanti indirizzi europei.
Nell’ambito del razionalismo, Theo van Doesburg, capo del gruppo olandese «De Stijl», conobbe Wright attraverso Robert van’t Hoff e J.J.P. Oud, e dal 1925 al 1930 cercò di tradurne i principi in una sorta di sintassi della nuova architettura. Ecco alcuni punti del Manifesto:
«L’architetto moderno non parte da una forma a priori; per ogni tema elabora un approccio diverso. La nuova architettura è informale: non accetta schemi a priori né modelli in cui riversare spazi funzionali. Non riconosce tipi fondamentali e immutabili: la divisione e suddivisione dello spazio interno ed esterno è stabilita da lastre e schermi che possono estendersi in ogni direzione. La nuova architettura non riconosce componenti passive, ha vinto il buco: la finestra non è più un buco nel muro. Abolendo il dualismo fra interno ed esterno, nasce una pianta nuova, completamente diversa da quella classicista. I differenti spazi non possono essere compressi in scatole cubiche: si sviluppano in modo eccentrico, dal centro alla periferia. La nuova architettura rifiuta la monotonia reiterativa e l’uguaglianza delle due metà, cioè la simmetria; non separa il fronte dal retro, la destra dalla sinistra e, se possibile, l’alto dal basso». Quali edifici potevano ispirare e corroborare una così limpida intuizione linguistica se non quelli di Wright?
Anche la corrente opposta al razionalismo «De Stijl», cioè l’espressionismo, fu patrocinata da Wright. In generale, i razionalisti ignorano il significato e il valore energetico dei materiali, il dinamismo e il messaggio inerenti ai mattoni, al cemento, al ferro, al vetro e così via. Gli espressionisti invece ebbero una traumatica coscienza dei materiali e del loro impatto sullo spazio, e questo spiega perché da Erich Mendelsohn ad alcuni esponenti della Scuola di Amsterdam, furono devoti a Wright.
Il maestro di Taliesin dunque sta alla radice delle antitetiche correnti dell’avanguardia europea, le nutre e indica una loro possibile convergenza nella visione organica, in un’architettura «totalmente architettura – spazio in se stesso».
Terzo e ultimo tema: la metodologia organica come alternativa democratica ai precetti autoritari delle Beaux-Arts e all’evasione eclettica.
È stato osservato che l’architettura organica è libera da tutti i principi codificati del design. Ciò è sostanzialmente vero. Ma l’emancipazione dai vincoli geometrici e da tutti i codici tradizionali non implica che si muova nel vuoto e non possa essere trasmessa. L’architettura organica ha prodotto una serie positiva di non-regole, o anti-regole, di rifiuti e rigetti di tutte le norme classiciste, di tutti gli «ordini» consacrati dalle Beaux-Arts, in qualsiasi modo mescolati o contaminati.
Un «codice di deroghe»: così sono state definite le sette invarianti del linguaggio moderno dell’architettura. Dei bacilli Beaux-Arts il più pericoloso è probabilmente la simmetria. Molti studiosi, e recentemente Julius Siegmund Bielicki, hanno analizzato la psicopatologia del bisogno di simmetria. L’esigenza di una visione stabile, bilanciata e armoniosa risponde a uno stato di instabilità interiore. «Poiché la simmetria implica il reciproco rispecchiamento, è particolarmente caratteristica degli individui narcisisti». Per loro significa «egoregression» talvolta con «un tocco di paranoia». «Il principio di simmetria è diadico… Non c’è posto per un terzo:
le due metà sono legate insieme nel bene e nel male; la distruzione di una è anche la morte dell’altra. La simmetria non si riferisce in alcun modo a
un terzo oggetto». La personalità narcisistica è incapace di rivolgersi ad altra gente soddisfacendone le richieste. Bielicki afferma che i malati e gli schiavi dell’incestuosa simmetria dovrebbero far di tutto per liberarsi da tali contagiose paure e ansietà.
Alcuni edifici wrightiani sono simmetrici. Ma si possono immaginare simmetrici Falling Water, il Johnson Building a Racine, Taliesin West, la maggior parte delle Usonian Houses? Perderebbero il loro scatto vitale. Nel campo della pianificazione va ricordato che Wright ci ha mostrato i poli estremi degli insediamenti umani: Broadacre City, da un lato; The Illinois, il grattacielo alto un miglio per Chicago, dall’altro. Stiamo ancora oscillando tra questi poli, moltiplichiamo i compromessi tra sviluppo orizzontale e verticale, e tra edifici che sono, nello stesso tempo, troppo alti e troppo bassi. Troviamo difficoltà a gestire le implicazioni della Third Wave nella pianificazione territoriale e urbana. Certo, Wright non poteva prevedere le conseguenze dell’età post-industriale; ma, da “The Disappearing City” in poi, molto di quanto ha pensato e scritto può aiutarci a risolvere i nostri problemi.
Dobbiamo chiederci: l’apporto wrightiano è ancora valido, o almeno incisivo e provocatorio, per gli architetti contemporanei? Può essere messo in sintonia con la nostra società? Può contribuire a raggiungere ciò che essenzialmente cerchiamo per il nostro tempo e per il futuro?
Il nostro mondo, senza dubbio, è radicalmente diverso da quello in cui Wright visse. Ciò malgrado, le risposte a questi interrogativi possono essere positive. Nel processo di svincolamento dalla dottrina dell’International Style molti frammenti della lezione di Wright sono stati assorbiti. Da una percezione più ricca dei segni estetici alla scoperta di subculture popolari, dall’ipotesi di un’«action architecture» qualificata dal principio di indeterminazione alle domande di personalizzazione e di pluralismo, dai numerosi e sintomatici manierismi al gusto dell’aleatorio e ai fenomeni di de-pianificazione, de-tecnologismo, de-architettura, alcuni suggerimenti diretti o indiretti di Wright sono stati assimilati.
Purtroppo in modo episodico, disgregato, con un tremendo spreco di energie. Tuttavia, se l’architettura contemporanea aspira davvero a una re-integrazione, a un nuovo umanesimo, può trovare eccezionali stimoli nelle infinite fonti wrightiane.
Il convegno «The Wright Hand», così autorevole e affollato, è una rivincita per i molti giorni e notti che in questi decenni abbiamo passato da soli, combattendo l’anonimità dell’International Style e la stupidità del Post-Modernism. È una rivincita per i discepoli di Wright, per i suoi seguaci e ammiratori, per quelli pronti a dichiararsi wrightiani anche quando ciò era considerato completamente fuori moda. È una rivincita per l’American School of Architecture, per il gruppo «The Bruce Goff Legacy», per i «Friends of Kebyar», per le fondazioni e per tutti coloro che scrivono libri, saggi, bollettini per mantenere vivo l’insegnamento wrightiano. Ma è anche una rivincita per numerosi seguaci di Le Corbusier, Gropius, Mies, Mendelsohn, Aalto, che hanno incontrato Wright solo durante una fase adulta della loro attività.
Ciò che vogliamo non è un revival wrightiano, ma un’esplorazione più vasta e fertile del suo messaggio, come potete trovare in varie opere di Ralph Erskine, Lucien Kroll, Aldo van Eyck, Günther Domenig, Luigi Pellegrin, Reima Pietilä, Jean Renaudie, Fehling & Gogel. La lista degli americani, da Lawrence Halprin e Frank O. Gehry a Paolo Soleri e Richard Meier, sarebbe lunga e problematica. Quindi basterà indicarne soltanto uno, Gunnar Birkerts.
La perseverante «ricerca di libertà», di «appropriata espressione architettonica» è completamente indipendente dall’influenza di Wright.
Tuttavia, nell’atteggiamento di Birkerts si possono trovare affinità wrightiane. Costantemente contro i dogmi, afferma che «la convenzionale apertura nel muro, la finestra, è il modo peggiore di illuminare uno spazio». Molto presto, nella sua carriera, scopre che «…la risposta alle esigenze interne ed esterne è di uguale importanza». Se un architetto è contro il classicismo accademico e l’idolatria vernacolare, se è cosciente che lo «spazio in se stesso» è protagonista della formazione architettonica, prima o poi giunge a riconoscere Wright senza essere più sovrastato dalla sua statura. Del resto, non c’è bisogno di sembrare wrightiani per essere organici.
Questo convegno proclama che non si può sottrarre al glorioso patrimonio storico dell’architettura il suo massimo genio. L’eredità di Wright è qui per restare, non come valore del passato da ricordare, ma come valore del presente e del futuro da sviluppare in modi sempre mutevoli.
Brunelleschi, Michelangiolo e Borromini, dopo la loro morte, furono archiviati nel Walhalla degli eroi, disperdendo e annullando la loro eredità. Per Wright questo non accadrà. Lo spirito creativo in America e nel mondo non sarà ibernato dal neoaccademismo maniacale e dallo spettrale Post-Modernism: continuerà a inventare nuovi rischi.
-
Laurea honoris causa in “Human Letters” nella stessa università.
Processo al Vittoriano.
Processo al monumento a Vittorio Emanuele II a Roma
 Dopo aver ripubblicato “I Mattoidi” di Carlo Dossi, una satira dei primi progetti per il monumento uscita nel 1884, il Mediocredito del Lazio promosse un dibattito sul Vittoriano che si svolse a Roma, con la partecipazione di un vastissimo pubblico, a Palazzo Venezia il 27 gennaio 1986.
Dopo aver ripubblicato “I Mattoidi” di Carlo Dossi, una satira dei primi progetti per il monumento uscita nel 1884, il Mediocredito del Lazio promosse un dibattito sul Vittoriano che si svolse a Roma, con la partecipazione di un vastissimo pubblico, a Palazzo Venezia il 27 gennaio 1986.
La storia dei processi al monumento a Vittorio Emanuele ha connotati kafkiani. Da quello del 1913, di cui fu protagonista Giovanni Papini, a quello, di appena tre anni fa promosso su “Il Messaggero”, questi processi hanno grande risonanza, suscitano infuocate polemiche, poi si stemperano e vengono completamente insabbiati. Passa del tempo, cambiano gli attori e i giudici, e tutto ricomincia daccapo. È un meccanismo ripetitivo disarmante, e tuttavia attesta, proprio per le sue cicliche riprese, che il problema è profondamente sentito, che non ci siamo ancora assuefatti a questo incubo.
I testimoni dei processi sono di due tipi ben distinti: tecnici, esperti, intellettuali, da un lato; e gente comune, dall’altro. Salvo alcune eccezioni, fra cui ricordo l’onorevole Pio Baldelli, il consigliere comunale Bernardo Rossi Doria ed Enrico Testa della Lega Ambiente, i primi, gli intellettuali, sono pieni di titubanze e atteggiamenti contraddittori: detestano l’opera, la stigmatizzano e la condannano recisamente, ma poi sostengono che deve rimanere, non foss’altro che a perpetua memoria dell’infamia compiuta. La gente comune, invece, si comporta in maniera meno astrusa e più coraggiosa.
Va aggiunto che quasi ogni dibattito, ogni accenno al monumento è tinto di ironie e di facezie. Dall’età di Carlo Dossi a oggi, l’argomento si affronta con sarcasmo o con un sorriso sulle labbra: sarcasmo di sufficienza e tollerante compassione da parte degli stranieri, e sorriso rassegnato, non privo di amarezza, da parte degli italiani. Sogghignamo e sorridiamo per esorcizzare la mostruosità, perché il disastro provocato da questa faraonica mole acquisti le sembianze di una farsa irreale, quasi di una messinscena aberrante ma temporanea, da rimuovere il giorno dopo. Così, considerando il Vittoriano solo un’eclatante «stonatura», una grossolana assurdità, in fondo uno scherzo anche se di pessimo gusto, ci sottraiamo alla responsabilità di assumere una posizione rigorosa e ferma. Non parlandone seriamente, si rispetta la solita regola del gioco, che consiste nel dirne tutto il male possibile per poi concludere di preservarlo. È stato utilissimo ripubblicare “I Mattoidi” di Carlo Dossi uscito nel 1884, perché vi si constata che nessuna delle soluzioni presentate al primo concorso, neppure quelle su cui più si accaniscono i dileggi dell’autore, sarebbe stata rovinosa come il progetto realizzato. Gli schemi a obelisco, a fontana, a stele, ad arco di trionfo, a recinto colonnato, a pagoda, benché spesso risibili, ingenui e grotteschi, anche per la circostanza di essere in genere ubicati non a piazza Venezia ma in altro luogo, sarebbero risultati assai meno ingombranti del monumento eseguito, e non avrebbero implicato un vandalismo e un flagello urbanistico di analoga entità.
I «mattoidi» passati in rassegna da Dossi sono appunto mattoidi, ossessi megalomani da beffare per le insensate voluttà retoriche patriottarde; per la loro dabbenaggine, non sono dementi pericolosi.
Invece, non può rientrare nel novero dei «mattoidi» Giuseppe Sacconi.
Il suo curriculum professionale è, nell’insieme, corretto, nobilmente opaco. Sappiamo delle sue sofferenze, dei suoi tormenti, dei dubbi, delle ansie, degli affanni, della sua drammatica insoddisfazione. Sappiamo anche che, per solidarietà con Sacconi, Benedetto Croce ed Ernesto Basile si dimisero dalla commissione composta, a detta di Croce, da «elementi estranei e indifferenti all’arte». Quindi nessun processo alla persona, che è solo in parte colpevole di quanto è accaduto. Ma il monumento, ecco il dato tragico inalienabile, supera, credo a scala internazionale, qualsiasi livello di delirio.
Se volete, possiamo benissimo tenerlo in piedi, magari sprecando miliardi per restaurarlo, ma dobbiamo almeno esser consci dei colossali guai che ha originato, che determina e continuerà a generare. Sotto tre profili: 1) lo scasso provocato nel cuore di Roma, 2) il nefasto, infelicissimo testo architettonico, 3) l’ipoteca ch’esso costituisce nei riguardi delle ristrutturazioni previste o prevedibili per il riassetto della capitale.
Circa il primo punto, ne hanno trattato Marcello Venturoli, Antonio Cederna e altri studiosi. A parte l’inaudito massacro di tesori archeologici e storici, tutti sanno, e del resto i documenti lo confermano, che piazza Venezia era un invaso relativamente stretto, profondo, asimmetrico, tale da recepire le tensioni direzionali della via del Corso, coagularle e poi ridistribuirle in ogni verso della città. Era insomma un tipico spazio romano, uno spazio irregolare che calamita forze e le rilancia, offre una sosta per smistare i percorsi, segna un fermo in funzione di un arricchimento della cinetica urbana.
Il monumento ha annientato completamente questi valori. Spostando il palazzetto, ha mortificato la dimensione, la dinamica e il significato di Palazzo Venezia. Per schizofrenia simmetrica è stato demolito il decoroso edificio che gli stava di fronte, sostituendolo con una parodia del monco Palazzo Venezia. Il tutto al fine di elevare una gigantesca barriera marmorea che occlude teatralmente l’asse del corso, quasi che a sinistra e a destra non ci fosse nulla da rispettare. Il blocco è spietato, la città finisce lì: il resto diventa trascurabile, compresi il Campidoglio e i fori.
La chiusura è ermetica e implacabile proprio per un motivo specificamente architettonico: per il modo egocentrico, scisso da qualsiasi dialogo o raccordo con l’intorno, che caratterizza la concezione del monumento. Un impianto simmetrico è di per sé narcisistico. Ma a sottolinearne ancor più l’estraneità dal contesto contribuiscono le scalee, lo stilobate, i ripiani, le rampe, la curvatura del portico, i propilei laterali, il muro pieno dietro il colonnato, la ponderosa fascia che lo sovrasta, per non dire del materiale e delle incongrue sculture. Il mastodontico oggetto si rinserra masochisticamente in se stesso per escludere qualsiasi altra emergenza della città.
La questione non attiene soltanto allo stupro perpetrato dalla costruzione del Vittoriano; e neppure ai danni che questa gelida, perfida architettura determina ogni giorno e ogni notte, in ogni ora, con la sua offensiva arroganza. La questione coinvolge anche il futuro. Si è molto discusso in questi anni, a favore o contro, del parco archeologico e dello smantellamento dello stradone mussoliniano. Si è parlato di osmosi, di continuum tra zona archeologica e tessuto urbano circostante. Ma è evidente che questo obiettivo è frustrato a priori dalla presenza invadente del monumento, persistendo il quale nessuno scambio, nessuna integrazione saranno mai possibili.
I problemi di Roma, dal traffico al sistema direzionale, sono così numerosi e urgenti da far ritenere che quello del Vittoriano non costituisca un quesito rilevante. Ma poiché siamo qui a recitare questo processo, la giuria deve esprimere un chiaro parere. Se sarà contraria alla permanenza di questo misfatto, in pratica, almeno nell’immediato, non succederà nulla. Ma avrete dimostrato che non siamo un popolo esteticamente ottuso. Come il monumento, nella sua esorbitanza dimensionale, nelle sue forme stridenti e nel colore insopportabile, non è mai riuscito a inserirsi, ad appartenere al panorama romano, così né i romani, né coloro che risiedono a Roma o la visitano, lo hanno mai digerito. È un esempio di kitsch, forse il più sottile, insolente, macroscopico: un kitsch accademico, devitalizzato, glacialmente arcaico, etruscheggiante ed ellenizzante, privo di gioia e flagranza. Il centro di Roma non acquisterà mai autentica dignità senza tagliare questo nodo demente.
Comunque, non occorre postulare la demolizione, sic et simpliciter, senza appello, del monumento. Basta chiedere che questo processo non s’interrompa come i precedenti, e invece si prolunghi per liberare la gente dal torpore mentale e visuale. Cosa proporre? Un grande concorso di idee sulla sistemazione della zona archeologica e di quanto le sta intorno, compreso il Vittoriano. Un concorso che solleciti alternative valide all’attuale situazione fraudolenta.
Può darsi che qualche concorrente «mattoide» progetti una sopraelevazione del monumento; ci divertiremo, come Carlo Dossi. Ma altri, con un minimo di immaginazione, elaboreranno ipotesi per abolire la barriera marmorea, lasciandone magari alcuni settori, mutandone l’uso, attenuandone gli eccessi. Penseranno ai fori senza il Vittoriano, all’Ara Coeli senza il Vittoriano, al colle capitolino senza il Vittoriano, alla stessa piazza Venezia con un diverso altare al Milite ignoto, non più legato alla celebrazione iperbolica dell’infausta monarchia sabauda.
Ci sono motivi etici, politici, urbanistici e architettonici per indire, a distanza di oltre un secolo, un nuovo concorso. Dobbiamo mostrare che un paese civile, avendo commesso un madornale, scandaloso errore, non è disposto a subirne le conseguenze per l’eternità.
Iscrizione al Partito Radicale.
Partito Radicale
L’incontro con i radicali avviene sull’università (si veda il discorso tenuto al congresso radicale del 1979) e sulla Teleroma 56. Ho offerto la Teleroma 56 a Formica e a Martelli; l’hanno snobbata. I radicali invece ne colgono l’importanza, la potenziano, ne fanno uno strumento tuttora di grande rilievo. Con Marco Pannella c’è da anni un rapporto di profonda amicizia. Non ci vediamo mai, scambiamo idee con difficoltà, quasi con pudore, ma per un lungo periodo marciamo all’unisono.
Un partito già nuovo e diverso
Mi sono iscritto al Partito Radicale per almeno quattro motivi:
1. coerenza ideologica. Il mio itinerario parte dal movimento “Giustizia e Libertà” di Carlo Rosselli, prosegue con il Partito d’Azione, con il gruppo “Azione socialista” e con “Unità Popolare”, ed approda nell’alba liberal-socialista del Psi. Che differenza c’è fra liberal-socialismo e radical-socialismo?
2. Affinità caratteriale. Ho partecipato a quasi tutte le lotte radicali, dai referendum alla Teleroma 56. L’immediatezza, lo slancio, l’ottimismo disperato delle battaglie radicali trovano una profonda risonanza nel mio temperamento.
3. Spinta emotiva. Sono amico di Pannella, Sergio Stanzani, Massimo Teodori e molti altri leaders radicali da anni ed anni. Voglio essere più vicino a loro.
4. Emergenza attuale. Convinto ancor oggi che lo scioglimento del Partito d’Azione fu un errore grave per la democrazia italiana, auspico che il Partito Radicale non lo ripeta nel suo prossimo congresso. La posizione di Pannella è ideologicamente, politicamente e psicologicamente giustificata, ma dobbiamo convincerlo che l’Europa non può fare a meno di lui e dell’apporto radicale.
1987
Deputato al Parlamento per il Partito Radicale nella circoscrizione Venezia-Treviso.
Un architetto in Parlamento
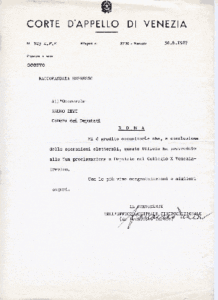 Primo a Venezia-Treviso. Il risultato mi sorprende e commuove molto più dell’affermazione ottenuta a Roma. Sono stato la goccia che mancava al Partito Radicale in quella circoscrizione. Ho pensato subito di occuparmi delle questioni veneziane, in cui intervengo da decenni. Ma una lettera dei miei studenti mi dissuade: «Non l’abbiamo eletta perché lei si occupasse di quisquilie locali. Il compito dei radicali fuoriesce dagli ambiti regionali». Ho seguito questo consiglio.
Primo a Venezia-Treviso. Il risultato mi sorprende e commuove molto più dell’affermazione ottenuta a Roma. Sono stato la goccia che mancava al Partito Radicale in quella circoscrizione. Ho pensato subito di occuparmi delle questioni veneziane, in cui intervengo da decenni. Ma una lettera dei miei studenti mi dissuade: «Non l’abbiamo eletta perché lei si occupasse di quisquilie locali. Il compito dei radicali fuoriesce dagli ambiti regionali». Ho seguito questo consiglio.
Due nuovi dicasteri: Aree Metropolitane e Università
Primo intervento nell’aula di Montecitorio, 5 agosto 1987
Poiché il mio intervento verte su due argomenti culturali – il Ministero per le Aree Metropolitane e quello della Ricerca Scientifica e dell’Università – inizio rievocando una prodigiosa figura di uomo di cultura, di studioso e di cittadino: la figura di Carlo Ludovico Ragghianti, scomparso a Firenze due giorni fa. A dire il vero, ci si poteva aspettare che, alla notizia della sua morte, la Camera dei Deputati avesse interrotto i lavori per commemorare degnamente questo padre della nostra Repubblica. Ragghianti infatti non è stato soltanto un colossale produttore e animatore di cultura nel campo della storia e della critica d’arte; è stato anche uno dei leader, insieme ad Aldo Capitini e Guido Calogero, della cospirazione liberal-socialista, e poi uno dei fondatori e dei principali dirigenti del glorioso Partito d’Azione. Tra questi due poli – storia dell’arte e lotta per la libertà – Ragghianti, pur religiosamente crociano, non ha mai fatto distinzioni. Sicché troviamo, da un lato, la sua strabiliante tesi di laurea sui Carracci, che Croce pubblicò ne «La Critica», i numerosissimi saggi su ogni periodo e piega della vicenda artistica, dalla preistoria alla pittura pompeiana e all’astrattismo del XX secolo, le riviste, da «La Critica d’arte» fondata con Ranuccio Bianchi Bandinelli e Roberto Longhi, a «Selearte», il lungo e appassionato insegnamento nell’Università di Pisa e poi, una volta nauseato dall’università di stato, nell’Università Universale Internazionale dell’Arte di Firenze; e, dall’altro, troviamo il presidente del Comitato Toscano di Liberazione, il partigiano spericolato che, passando su Ponte Vecchio con un cavo telefonico, congiunge il fronte rivoluzionario con gli avamposti degli eserciti alleati, e quindi gestisce magistralmente la rivolta contro il nazi- fascismo. Di Ragghianti è stato scritto che era un «genio emarginato». Lo era, ma era anche un genio splendente per i suoi discepoli, per coloro che ne hanno ereditato il rigore e l’intransigenza morale.
Ciò premesso, il mio intervento riguarda, come dicevo, due aspetti della struttura governativa che non sono stati commentati – neppure un accenno – nel discorso del Presidente del Consiglio, ma che invece, se ben gestiti, potrebbero rivelarsi qualificanti. Parlo della costituzione di due dicasteri: quello per le Aree Metropolitane e quello dell’Università saldata alla Ricerca Scientifica.
Il primo dicastero, concernente le Aree Metropolitane, è un residuo dell’annunciato Ministero della Casa e delle Aree Metropolitane dopo che la casa è stata riportata a forza nell’ambito dei Lavori Pubblici. Sia chiaro: nessuna nostalgia per il pastrocchio improvvisato del Ministero della Casa e delle Aree Metropolitane. Ma è certo che questo Ministero avrebbe avuto una notevole forza, quella derivantegli dagli interessi, dagli organismi, dagli istituti e dagli enti che si occupano di residenza pubblica e privata. Adesso, confinato lo scopo alle aree metropolitane, non si capisce bene che cosa potrà fare il nuovo dicastero, la cui operosità sarà sistematicamente intralciata dalla viscida inerzia del pachiderma dei Lavori Pubblici. Comunque la nascita di questo Ministero riveste, o può rivestire, un significato provocatorio. Denuncia che l’urbanistica, la pianificazione territoriale in Italia non funziona e che, come ripetono ormai da decenni enti competenti quali l’Istituto Nazionale di Urbanistica e l’Istituto Nazionale di Architettura, è necessaria e urgentissima una legge sul regime dei suoli, degli immobili e delle destinazioni d’uso. La nostra legge urbanistica risale al 1942. Sono passati 45 anni e ancora non siamo stati capaci di revisionarla, aggiornarla e cambiarla. Dopo Fiorentino Sullo, ai tempi della programmazione economica, nessuno ha neppure provato. Nel quadro della catastrofe ambientale spiccano i disastri dei piani territoriali e di quelli paesistici, i disastri dei piani intercomunali e di quelli comunali, e quindi anche i disastri delle aree metropolitane.
Le quali aree metropolitane presentano alcuni problemi specifici ma non possono essere scisse da un impegno urbanistico generale che deve e può trovare il suo rilancio. E lo può proprio perché la gente chiede ormai in modo massiccio un miglioramento della qualità della vita e sa che questo implica anzitutto insediamenti urbani più efficienti e razionali, e moderni assetti architettonici di valore estetico.
Aggiungo che la Camera dei Deputati è direttamente coinvolta nel problema delle aree metropolitane. Ubicata nel centro storico di Roma, da oltre dieci anni -presidenti Pertini, Ingrao e Nilde Jotti- ha sentito il bisogno di costituire una Commissione Consultiva Urbanistica che studia i requisiti della cosiddetta «città politica» nella cornice dell’area metropolitana della capitale, e di quell’Asse Attrezzato che dovrebbe vertebrarne la moderna versione.
Per questi motivi, c’è da augurarsi che il Ministero per le Aree Metropolitane, nato così fortunosamente, offra il pretesto per affrontare davvero, con una visione globale, la legislazione urbanistica oggi frantumata, sfilacciala, lacerata, usurata da 45 anni di inadempienze, compromessi, sabotaggi perpetrati all’ombra del Ministro dei Lavori Pubblici.
Più complessa la questione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, anch’esso elemento caratterizzante del nuovo governo. Avremo occasione di discuterne, ma l’obiettivo di questo dicastero deve essere chiarito al più presto perché esso è destinato a incidere in modo decisivo sugli orientamenti e sulla qualità della cultura italiana.
Superfluo ricordare che quella che si chiama ricerca scientifica nell’università è poco ricerca e pochissimo scientifica. Salvo che in alcuni settori, è zavorra, è produzione pseudo-culturale ai fini delle carriere universitarie, di quel meccanismo elefantiaco di docentificio che sperpera decine e decine di miliardi stampando libri che nessuno legge e che servono soltanto a vincere concorsi a cattedra. L’industria culturale universitaria ha in comune con l’industria culturale il basso livello, ma poi, contrariamente all’industria culturale, si caratterizza per il fatto di non rispondere a una domanda e di non avere acquirenti. Del resto, questa industria è strumentale ai concorsi universitari che sono stati, in vari casi, scandalosi. Basti pensare a quelli svoltisi per le Facoltà di Architettura, dove sono stati messi in cattedra, per insegnare la progettazione, individui che non hanno mai costruito non dico una casa, ma neppure un canile. La lottizzazione politica, spesso operata anche dalla sinistra, è un’altra conseguenza del degrado universitario.
Ci troviamo in un momento culturale delicatissimo: da un lato, non c’è più una libera cultura, perché tutti sono professori universitari e, dall’altro, la cultura universitaria è, in larghi settori, una cultura burocratizzata e perciò di basso livello.
In sintesi, va detto anche in quest’aula che all’università italiana mancano undici professori ordinari che l’abbandonino, e un dodicesimo che non ci abbia mai messo piede. Alludo, come capite, alla situazione durante il ventennio della dittatura, quando il rifiuto di aderire al regime fascista da parte di undici professori, da Levi Civita a Lionello Venturi, servì da punto di riferimento anche per coloro che restarono negli atenei, e quando la figura di Benedetto Croce, non-professore, dominava, stimolava e contribuiva a far lievitare l’intellettualità e l’arte del paese.
Il compito del Ministero dell’Università deve esser quello di ridare un posto e una funzione alla libera cultura, di liberalizzare e sburocratizzare gli atenei, di inventare organi concorrenziali alle università statali in modo da eliminare o almeno attenuare il torpore che deriva dal monopolio, al fine di riassorbire la pseudocultura e l’incultura universitaria trasformandola in autentica cultura.
Il Ministro preposto a questa nuovo dicastero è in grado, io credo, di svolgere questo compito. Ha una lunga esperienza universitaria, e dell’università ha conosciuto tutte le tare dall’interno. Oggi ne è fuori, può rovesciare il binocolo e vederne i problemi in modo spregiudicato, cioè in modo creativo.
Aree Metropolitane e Università, cioè urbanistica e cultura. Due ministeri di cui saremo presto chiamati a discutere le motivazioni e le strutture. È un vero peccato che il Presidente del Consiglio dei Ministri non ne abbia neppure accennato nel suo discorso di presentazione. Anche per questo, per questo deplorevole silenzio, noi radicali voteremo contro.
Ma voteremo contro con lo spirito che ha investito anche questo intervento, cioè con uno spirito propulsivo, scatenante di progettualità.
Lo scandalo dell’ora di religione
9 ottobre 1987
La mia è una testimonianza. Appartengo al popolo di Maria ebrea, di Giuseppe falegname ebreo, e del loro figlio Gesù, ebreo circonciso.
Appartengo al popolo dileggiato, perseguitato, schernito, oltraggiato per duemila anni dalla Chiesa cattolica, costante oggetto di nefandezze discriminatorie esasperate durante il potere temporale dei papi.
Poiché ci occupiamo dei problemi della scuola, va ricordato l’atteggiamento assunto dalla Chiesa verso gli ebrei fino a 117 anni fa. Fino al 1870 i vescovi non si sono preoccupati, come fanno oggi, di impedire che gli ebrei uscissero dalla scuola durante l’ora di religione: si sono preoccupati di non farli entrare, di non permettere loro di seguire né le classi elementari, né i ginnasi, né i licei, né le università. Gli ebrei, popolo o razza perfida e maledetta, peggio popolo deicida, non avevano alcun diritto all’istruzione e alla cultura.
All’ora di religione, sì, avevano diritto, anzi non potevano esserne esentati. Ogni settimana, in una chiesa vicino al ghetto, erano costretti ad ascoltare una predica diretta a farli convertire al cattolicesimo.
Del resto, meno di 50 anni fa, nel 1938-39, quando i bambini, i ragazzi, i giovani ebrei furono violentemente espulsi dalle scuole elementari, dai ginnasi, dai licei, dalle università, cosa fece la Chiesa? Nulla, proprio nulla; in qualche caso, spiegò che se lo meritavano in quanto membri del popolo deicida e maledetto. È sullo sfondo di questi precedenti, di un millenario antisemitismo cattolico, a cui tutti gli altri antisemitismi si sono ispirati, che dobbiamo giudicare gli eventi incredibili di questi giorni, le farneticanti «gravi preoccupazioni» dei vescovi, la «partecipazione e solidarietà» del pontefice a tali preoccupazioni, esposte, tanto per rendere lo scenario più teatrale e retorico, davanti a una folla di 70 mila persone.
Cosa significa la dichiarazione dei vescovi? È vilipendio della libertà, vilipendio della democrazia, vilipendio della convivenza civile, vilipendio dei diritti delle minoranze, vilipendio dell’individuo. È frutto di un fanatico istinto da Inquisizione, che sembrava represso negli ultimi decenni, e invece riemerge con inaspettata virulenza, una virulenza così rozza e brutale da richiedere la pronta, recisa risposta dei liberali, dei socialisti, dei liberal-socialisti, insomma degli eredi di Benedetto Croce, Carlo Rosselli, Pietro Nenni e Ugo La Malfa.
«Non possiamo accettare», «Non possiamo accettare», ripetono i vescovi di fronte a ogni sia pur minima esigenza liberale, magari solo formale come quella contenuta dai termini «facoltativo» o «non curricolare» del documento dei cinque partiti. Ebbene, a tale superbia dobbiamo rispondere, oggi qui e domani, se necessario, sulle piazze, di fronte a 70 mila persone: «Non possiamo accettare le vostre tesi dispotiche, il vostro autoritarismo insolente che rischia di riaprire una contesa tra Stato e Chiesa, dannosa per l’Italia e gli italiani, ma anche e soprattutto per la Chiesa».
Dopo l’aberrante dichiarazione dei vescovi, Eugenio Scalfari, che non è sospettabile di simpatie per l’intransigenza radicale, ha scritto: «La questione dell’ora di religione va molto al di là dei suoi contenuti specifici, che del resto sono di grande rilevanza. Ci riconduce infine al nocciolo del problema, che è quello dell’incongruenza di un Concordato tra Stato e Chiesa in un paese fondato sulla democrazia, e quindi sulla libertà di tutti e sull’abolizione d’ogni privilegio, a cominciare dal privilegio d’un insegnamento obbligatorio sancito da un patto con un’istituzione extrastatuale».
Asserzione incontrovertibile, che è stata ribadita anche in occasione del
Concordato rinnovato tre anni fa dai laici che reincarnarono le posizioni di Croce, Rosselli, Nenni e La Malfa di fronte al Concordato del 1929 e al voto sull’Articolo 7 della Costituzione.
Il Concordato firmato da Benito Mussolini, il Concordato firmato da Bettino Craxi, o qualsiasi altro immaginabile Concordato firmato da qualsiasi altro leader politico risulta inconciliabile con una società democratica, è una spada velenosa che penetra, inquina e corrode il terreno democratico.
Tuttavia, sia pur contro la logica, un Concordato può esistere se viene interpretato in modo equilibrato e flessibile, con senso diplomatico, con la volontà di non calpestare l’interlocutore. Le autorità cattoliche invece hanno tradito la buona fede di quanti prevedevano un’interpretazione razionale, equilibrata, non-dogmatica e intollerante delle trame concordatarie. I vescovi hanno scatenato una crociata, di cui il pontefice si è fatto vessillo.
Sono oggetto di condanne e anatemi i socialisti, i repubblicani, i liberali, i socialdemocratici che hanno sottoscritto un documento sottoposto all’esame della VII Commissione della Camera. È un documento pasticciato, logorato dai tira-e-molla, dal desiderio di far contenti Dio e il diavolo, di dire e di non dire, pur di uscire da questa impasse grottesca, da questa pagliacciata dell’ora di religione.
Pur così ostile a quel documento, quasi mi commuovo pensando ai titanici sforzi acrobatici che deve essere costato. E tanto più mi indigno per l’atteggiamento oscurantista, sprezzante per la democrazia italiana, dei vescovi.
Attenti, signori vescovi. L’Italia è cambiata, ha “votato contro” di voi per il divorzio, non è disponibile a farsi mortificare accogliendo nelle sue istituzioni, meno che mai nella scuola, metodi totalitari, intolleranti e ricattatori. Battezzate pure le bambole dei bambini che seguono l’ora di religione. Ma attenti, perché un giorno potrebbero sbattervi queste bambole in faccia.
C’è un’altra ragione per cui i vescovi dovrebbero essere più prudenti, ed è questa: oggi in Italia le minoranze religiose non sono più impotenti e paralizzate come nei secoli del dominio temporale della Chiesa e nei decenni della prima metà del secolo. Hanno acquistato dignità, prestigio e vigore politico. I valdesi possono coinvolgere l’universo protestante, come gli israeliti il mondo ebraico. Avete visto che, prima di recarsi negli Stati Uniti, il papa ha ricevuto a Roma una delegazione delle comunità israelitiche americane e, non appena attraversato l’Atlantico, ha incontrato altri rappresentanti dell’ebraismo degli Stati Uniti che hanno duramente criticato vari comportamenti della Chiesa e dello stesso pontefice: dall’invito al criminale nazista Waldheim al non-riconoscimento dello Stato d’Israele (la questione dell’ora di religione non era ancora sorta).
In breve, né il popolo italiano nel suo insieme, né le sue minoranze religiose sono inermi e disposte a subire le prepotenze di quelli che Scalfari definisce i «nuovi clericali in salsa polacca». La cultura liberale e socialista italiana, vituperata dall’insolenza dei vescovi, troverà l’energia di rispondere in difesa della democrazia. Nessuno vuole uno scontro.
Ma se continua questa provocazione dell’ora di religione, allora non l’Intesa ma il Concordato dovrà essere abrogato.
Per avere un’idea della «perfidia» dei vescovi (“perfidos judeos” fummo denominati per secoli noi ebrei nelle chiese cattoliche, e questa è una buona occasione per restituire il termine), basta ricordare che essi dichiarano di non poter accettare «che ci sia possibilità per coloro che non si avvalgano dell’insegnamento della religione cattolica di assentarsi dalla scuola». Avete capito? Non ci deve essere la possibilità di assentarsi. Sicché i casi sono due: o i presidi divengono gendarmi al servizio dei preti, oppure i vescovi dovranno appellarsi alle guardie svizzere affinché circondino tutte le scuole della Repubblica controllando che nessuno si assenti. «A qualcuno è scappato il piede dalla frizione», si dice al paese del Presidente del Consiglio. Qui non è un piede, ma un pezzo di cervello a scappare!
Romano da duemila anni, voglio chiudere con due ricordi personali sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane.
1924, prima elementare, scuola «Ugo Bartolomei» alla Batteria Nomentana.
Tutte le mattine, non appena la maestra entra in classe, ci alziamo in piedi. Tutti gli altri bambini si fanno il segno della croce e poi recitano il Pater Noster. Io, in piedi, immobile, attonito e smarrito in quel coro che mi attornia e da cui sono escluso. Quanto del mio carattere dipende ancora da quella lontana esperienza? Non so e poco importa; ma, sotto il profilo pedagogico, quell’insegnamento della religione cattolica era, a dir poco, aberrante.
Secondo ricordo. 1936, liceo Tasso in via Sicilia. Nella sezione B insegna religione un sacerdote intelligente e simpatico. Dice agli studenti: so benissimo che a voi, alla vigilia della maturità classica, della religione non v’importa un’acca; perciò vi darò ripetizioni di matematica e fisica.
Destino beffardo e baro! Espulso dall’aula in quanto non cattolico, fragile anzi fragilissimo in matematica e fisica, mi trovo a girare i corridoi del «Tasso» in attesa che finisca l’ora di religione.
Ma in terza liceo si è ormai maturi. Antifascista, membro del gruppo
Zangrandi, connetto l’atteggiamento arrogante della Chiesa a quello del regime mussoliniano. Totalitarismo cattolico, totalitarismo nazifascista, totalitarismo stalinista. Per me, ormai membro del movimento “Giustizia e Libertà” fondato da Carlo Rosselli, tutto è chiaro, “tout se tient”.
Invece non è chiaro adesso, onorevoli colleghi, non capisco come l’ora di religione imposta dai vescovi sia compatibile con la democrazia italiana. La nostra è davvero una democrazia così flaccida e imbelle da sopportare simili oltraggi?
Conclusione: tre NO, oppure l’alternativa di un quarto NO.
NO all’ora di religione nelle scuole materne.
NO all’ora di religione nelle altre scuole, a meno che non sia esplicitamente facoltativa, non curriculare, situata fuori dell’orario, all’inizio o alla fine.
NO a qualsiasi potere degli insegnanti di religione, che non riguardi strettamente questa disciplina.
Fuori di questi tre NO, ce n’è un quarto alternativo: «NO AL CONCORDATO».
-
Relatore al simposio “Theory and Criticism” della IV Biennale di Architettura a Sofia.
-
Membro dell’International Academy of Architecture di Sofia.
1988
Presidente del Partito Radicale.
Presidente del Partito Radicale
Sorgono però difficoltà: al consiglio federale di Strasburgo, poi a quello dell’Hotel Ergife a Roma. Il dissenso verte su due punti: a) la prospettiva di chiudere il partito, in considerazione della sua condizione finanziaria; b) la necessità di una guida di emergenza, che abolisca tutti gli organi statutari del partito, e affidi i pieni poteri a quattro persone: il presidente, il segretario, il tesoriere, il presidente del consiglio federale.
Non sono d’accordo sul primo punto, e meno ancora sul secondo. Non voglio far parte del «quadriumvirato», perciò mi dimetto dalla carica di presidente. Con intelligenza e generosità, Marco Pannella mi propone come presidente d’onore. A questa carica tengo molto, e vorrei che non fosse meramente decorativa. Ma, finché dura il quadriumvirato con pieni poteri io sarò fuori centro, fuori fase. Nel 1992 le liste Marco Pannella hanno segnato un’ulteriore distinzione.
1989
Al xxxv congresso del Partito Radicale, tenutosi a Budapest, propone un “Manifesto-appello”.
Manifesto-appello del Partito Radicale
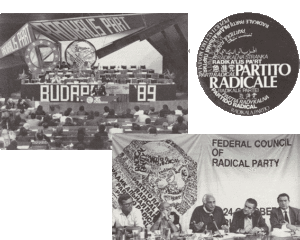 Budapest, aprile 1989
Budapest, aprile 1989
L’ansia di Carlo Rosselli, ereditata poi dal Partito d’Azione, era volta a evitare una restaurazione prefascista, il risorgere di velleitarismi nazionalistici, il prevalere della palude di una burocrazia sterile e immobilista.
Con la fine del Partito d’Azione si verifica un’atmosfera di appiattimento, di stasi, e poi di arretramento che favorisce uno stato di abulìa rispetto agli ideali europei, e l’insorgere di una frenetica, esasperata partitocrazia.
In questa atmosfera amara, repressa, insopportabile, spicca il volo il Partito Radicale: partito «filtro», discorde, anomalo, cacofonico, diverso; partito rivoluzionario nell’accezione aderente alle situazioni e ai conflitti delle ultime decadi del XX secolo. Dall’obiezione di coscienza al divorzio, le sue battaglie coinvolgono enormi masse di cittadini. La presenza radicale, nel paese e in Parlamento, esprime e organizza politicamente liberi comportamenti e costumi, incute tensione con le tematiche dei diritti civili, di una giustizia più giusta, della lotta contro la fame nel mondo e di quella antiproibizionista alla droga. A confronto di altri partiti assai più forti, il bilancio del Partito Radicale è impressionante, quasi sbalorditivo. Fondato a metà degli anni Cinquanta e rinnovato nel 1967, si qualifica immediatamente per l’internazionalismo federalista, l’antiautoritarismo, la non-violenza e la disobbedienza civile, il progetto di netta separazione tra Chiesa e Stato attraverso l’abolizione del Concordato mussoliniano.
Il sistema politico italiano è dominato, bloccato e paralizzato da estenuanti negoziati tra partiti. L’istituto del referendum infrange questa situazione, mediante l’iniziativa popolare e immette sulla scena questioni che altrimenti resterebbero emarginate. Si affrontano così i reati di opinione politici e sindacali (codice penale), l’ordinamento giudiziario militare, problemi relativi alla libertà di stampa, al finanziamento pubblico dei partiti, alle leggi di emergenza che prevedono restrizioni alle libertà personali, e ancora ai manicomi, alla caccia, alle centrali nucleari a uso civile, all’ergastolo, alla responsabilità dei giudici.
Spiccano due imprese straordinarie: Radio Radicale e Teleroma 56, che offrono un’alternativa all’informazione stereotipata e degradante: servizi politico-culturali che suscitano la stupefatta ammirazione anche degli avversari.
Il Partito Radicale si qualifica per un duplice aspetto: da un lato, è il partito della pulizia, contro la corruzione dilagante; dall’altro, è il partito del diritto, contro la concezione dell’emergenza e delle conseguenti leggi eccezionali.
La battaglia ecologica, nelle sue minime pieghe e diramazioni, permea l’azione radicale. Per anni i radicali sono stati soli a battersi contro la politica nucleare e il degrado ambientale.
L’identità radicale culmina nella lotta costante, quotidiana, disperata per la libertà dell’informazione. La sua carenza avvilisce la vita democratica, offende i cittadini, corrompe e distorce. La sfida sta in un diverso sistema informativo europeo.
Dal 1975 al 1989 il Partito Radicale ha promosso 25 referendum popolari, oltre 30 milioni di firme raccolte, 3.500 chilometri di marce, 1.300 giorni di digiuno, 1.280 di carcere.
Due connotati sono stati ripresi con inedito slancio: transnazionale e transpartitico.
Verdetto rivoluzionario, secondo il quale si affrontano compiti a scala europea e mondiale.
Pier Paolo Pasolini raccomandava ai radicali:
«Voi non dovete fare altro che continuare semplicemente a essere voi stessi; il che significa essere, continuamente irriconoscibili.
Dimenticate subito i grandi successi e continuate imperterriti, ostinati, eternamente contrari, a pretendere, a volere, a identificarvi col diverso; a scandalizzare, a bestemmiare».
Disordinare, rompere, destrutturare: ecco l’istinto e il metodo radicale. Se la società e lo stato tendono all’immobilità, all’anchilosi, i radicali intendono spezzarla lacerando gli schemi prestabiliti del potere. La «radicalità» esclude la rassegnazione e perciò evita l’invecchiamento delle istituzioni come degli esseri umani.
La «philosophy» radicale incarna un modo diverso di vedere il mondo e la vita. Aspetta una sua piena formulazione, ma intanto può essere estratta, alla maniera di Croce, dalla storia, dagli atteggiamenti e dai coinvolgimenti radicali. Al pari della «philosophy» di “Giustizia e Libertà” e del Partito d’Azione, quella radicale s’inquadra nel panorama contemporaneo del pensiero e dell’arte: è discontinua, dissonante, aritmica, disarmonica, detesta la simmetria e la monumentalità, condanna i simboli, tanto più le grottesche scenografie di templi greci e piramidi egizie, aborrisce la ripetitività, celebra il diverso e quindi il conflittuale. La sua religione è quella della libertà professata da Benedetto Croce, ma in una versione gremita di scontri, strappi, ossessivi interrogativi sull’opportunità di ricominciare tutto daccapo. Avverse alla cultura radicale sono le inerzie accademiche di ogni ordine e grado, la gigantesca produzione libraria sponsorizzata a fini di lucro, la pachidermica industria pseudo-culturale universitaria. Per un paio di secoli dopo la rivoluzione borghese, spaventose contraddizioni hanno ferito la civiltà della tolleranza e della democrazia. In nome della dea ragione, sull’altare di ideologie, miti e «ismi» si sono compiute le peggiori scelleratezze, si è ucciso e massacrato; in nome di nazioni e rivoluzioni si sono fatte guerre e carneficine.
Il Partito Radicale è l’unica forza politica che ha basato sulla non-violenza, in termini non ideologici ma di teoria della prassi, la propria azione: disubbidienza civile, digiuni, dialogo. Non solo per vincere, ma per convincere l’avversario. Scioperi della fame prima, poi scioperi della sete. Per testimoniare che democrazia = diritto all’informazione, Marco Pannella nel 1974 ha digiunato per 70 giorni.
Si è combattuto, spesso con successo, contro gli sperperi vertiginosi istigati dal potere, contro le cosche partitocratiche e i loro eserciti lottizzati e lottizzatori, contro il conformismo alleato al denaro.
Oggi dobbiamo affrontare nuovi, immani compiti. Dobbiamo accelerare la caduta dei regimi totalitari, ma anche preparare il «dopo-liberazione». Va impedito che da un’oppressione si passi a un’autoppressione non meno tragica. Rispetto ai problemi del passato, il cambiamento è così vasto e rapido da sconcertare anche noi, quasi da renderci irriconoscibili a noi stessi. Ma questa è la condizione precaria, disarmante, traumatica, gioiosa, splendida, scandalosa e inebriante di essere radicali.
-
Relatore al congresso dell’International Academy of Architecture, a Delfi sul tema “The Critical Problems of Contemporary Architecture”.
-
“Minds 2” ad Arcosanti, Arizona.
Incontro con John Cage.
Con John Cage in Arizona: non-intenzione e silenzio
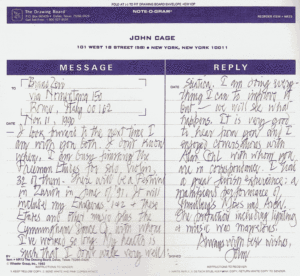 Rileggo con profitto il verdetto di Croce:
Rileggo con profitto il verdetto di Croce:
«Le opere di poesia pura, come quelle di puro pensiero, sono cose che la storia produce con rarità, a grandi intervalli; e il coro sterminato che le attornia è composto o di voci d’altra natura o di echi più o meno fievoli e confusi».
Gli autentici geni creativi sono pochissimi e distanziati nel tempo. Ho avuto l’avventura di conoscerne due: Frank Lloyd Wright e John Cage, con cui ho passato ore indimenticabili ad Arcosanti, la città di Paolo Soleri. L’ho già riferito in “Sterzate architettoniche”: come nella sua musica, l’assenza era protagonista. Dominava autocancellandosi, in modo totalmente diverso da quello del maestro di Taliesin.
Parlava di Schönberg come Wright di Sullivan, ma con disinvoltura e ironia. Fra suoni e rumori, aveva introdotto il silenzio, perché era «il terreno in cui il vuoto poteva crescere. Il mio lavoro consiste nell’esplorare la non-intenzione…».
In architettura siamo davvero indietro. Non abbiamo assorbito a fondo neppure la dodecafonia, l’oceano delle dissonanze, e dovremmo raggiungere Cage: «Io non sento la musica che scrivo. Scrivo per sentire la musica che non ho ancora sentito».
Volto segnato oltre misura già nel 1989, ma con me scherzava continuamente, come se fossimo amici da sempre; Inge dice che non mi ha mai visto ridere così. In sostanza, cosa cercava? «Una musica che trasporti l’ascoltatore al momento in cui è».

 English
English