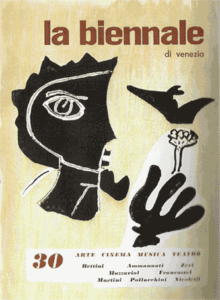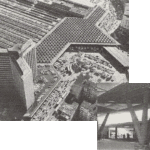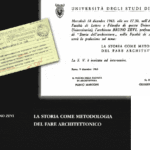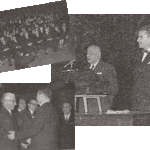Biografia: 1955-1964
1955
Direttore della rivista mensile "L'architettura - cronache e storia"
“L’architettura – cronache e storia”
 Il passaggio da “Metron” a “L’architettura – cronache e storia” fu determinato da Riccardo Musatti, che propose a Carlo Caracciolo di pubblicare la rivista. Sia Musatti che Caracciolo erano stati redattori del quotidiano “L’Italia Libera”, organo del Partito d’Azione.
Il passaggio da “Metron” a “L’architettura – cronache e storia” fu determinato da Riccardo Musatti, che propose a Carlo Caracciolo di pubblicare la rivista. Sia Musatti che Caracciolo erano stati redattori del quotidiano “L’Italia Libera”, organo del Partito d’Azione.
1956
Celebrazioni e mostra di Biagio Rossetti a Ferrara.
Piacentini corrompe il centro di Ferrara
“L’Espresso”, 15 luglio 1956
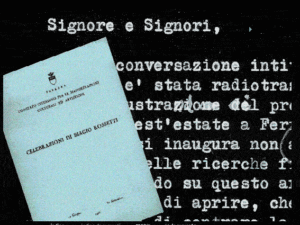 Virtù e scempio. Gloria e nefandezza. La città estense celebra, in una grande mostra dedicata a Biagio Rossetti, il genio del suo cinquecentesco organismo urbano; è la saga dell’architettura ferrarese che il Sindaco Luisa Balboni e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, senatore Roffi, hanno organizzato con rara competenza e affetto per la cultura. Contemporaneamente, si ha la spudoratezza di scoprire la facciata di un orrendo, insulso palazzo, l’ultimo aborto del più nefasto architetto della storia italiana.
Virtù e scempio. Gloria e nefandezza. La città estense celebra, in una grande mostra dedicata a Biagio Rossetti, il genio del suo cinquecentesco organismo urbano; è la saga dell’architettura ferrarese che il Sindaco Luisa Balboni e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, senatore Roffi, hanno organizzato con rara competenza e affetto per la cultura. Contemporaneamente, si ha la spudoratezza di scoprire la facciata di un orrendo, insulso palazzo, l’ultimo aborto del più nefasto architetto della storia italiana.
“Turpe nella trama e oscena nelle espressioni” è stata definita la “Moscheta” del Ruzzante che si rappresenta nel cortile del Palazzo dei Diamanti, in un gioiello di teatro provvisorio disegnato da Luigi Piccinato; la notifica arcivescovile ha proibito “ipso iure” ai fedeli di assistere alla commedia. Se i veti e le scomuniche fossero applicate all’architettura, i ferraresi dovrebbero essere obbligati a pararsi gli occhi di fronte alla mostruosità d’idiozia del nuovo Palazzo della Ragione e all’empio, svergognato architetto “littorio” Marcello Piacentini sarebbe imposto l’ostracismo più che a un lebbroso. Cinico ormai fino al masochismo, Piacentini ha voluto dimostrare a Ferrara fino a qual punto di degenerazione possa scendere un architetto. Lo sventramento dei Borghi, compresi quei due meschini palazzi di testata e la serie degli stolidi obelischetti-lampioni della via della Conciliazione, diviene al confronto un semplice incidente di una persona inabile; il Palazzo di Giustizia a Milano è solo un esempio di volgarità o di demenza senile: qui è stato superato ogni limite di decenza, si è operato a freddo il crimine nel cuore della città urbanisticamente più preziosa d’Italia. Di fronte alla Cattedrale, al commovente portico che la fiancheggia, al campanile albertiano e alla sublime abside di Biagio Rossetti, si è perpetrato un osceno e permanente atto architettonico a paragone del quale le battute licenziose “Moscheta” sono frivoli scherzetti.
«Nessuna attenuante può trovare la Torre dei Ribelli, quest’orrendo scatolone che sembra concepito da una fantasia non normale»ha scritto la “Gazzetta Padana” in un articolo intitolato «I record di bruttezza nel centro di Ferrara». In questa inattesa sollevazione della stampa indipendente e di destra ci sarà forse l’ingrediente di una speculazione contro l’amministrazione comunista di Ferrara. Siamo d’accordo col Sindaco: se avesse proibito il cosiddetto risanamento della zona, la stampa d’opposizione si sarebbe scaraventata contro un’amministrazione che, per «incomprensibili preconcetti a sfavore di un architetto di chiara fama», paralizzava le possibilità di sviluppo del centro urbano. D’accordo: ma resta lo scempio e la stampa, quali che siano i suoi motivi, ha sacrosanta ragione.
Di chi è la colpa? Di nessuno e di tutti come di regola nel nostro paese bramoso di irresponsabilità. Colpa di Piacentini? Nemmeno per sogno! Piacentini fa il suo mestiere, e se le commissioni di controllo urbanistico e architettonico comunali, e la Direzione Generale e il Consiglio Superiore delle Belle Arti lo lasciano a piede libero, egli continua a infierire sadicamente nei centri monumentali, perché un sadico è attivamente malefico.
Colpa del Comune? Nemmeno. Quando approvarono il progetto, gli amministratori di Ferrara sapevano a cosa andavano incontro, anche se oggi il risultato travalica le più sinistre previsioni: lo sapevano perché furono avvertiti, ammoniti, scongiurati di non dare il permesso di costruzione da tutti gli urbanisti e gli architetti qualificati. Ma il Comune si trovava alle strette: Piacentini era strettamente legato alle forze economiche che, sole, avrebbero potuto eseguire il lavoro. Non c’era scelta: o accettare Piacentini oppure rinunciare al risanamento e alla ricostruzione di una zona di tuguri. Bisogna pure capire le difficoltà degli amministratori di Ferrara: quando l’amministrazione delle Belle Arti dice «va bene», quando le commissioni tecniche approvano, come fa un Comune a vietare che si attui un lavoro che rivitalizza una zona del centro cittadino e implica l’occupazione di tanti operai? Allora la colpa è delle Belle Arti?
Guglielmo De Angelis d’Ossat, che si trovava a Ferrara per l’inaugurazione della mostra rossettiana, è stato esplicitamente attaccato dalla “Gazzetta Padana”. Ma anche questo è ingiusto. Un direttore generale non è un giudice inappellabile: vi è il Consiglio Superiore delle Belle Arti di cui segue i pareri. E chi è stato per tanti anni nel Consiglio Superiore? Piacentini. Il conto dunque torna a perfezione.
È l’eredità sporca, fetida del fascismo che ancora impera, sgorbia i suoi progetti, si garantisce l’appoggio delle forze economiche, siede negli organi di controllo dello Stato, fa il cattivo e il pessimo tempo nel campo dell’edilizia.
Attorno, nessuno è responsabile, tutti guardano attoniti, non sanno che fare: un folle, bieco e degenere, ha stuprato Ferrara nobilissima.
Pubblicazione di "Biagio Rossetti".
“Biagio Rossetti”
Architetto ferrarese, il primo urbanista moderno europeo
- Il sindaco consegna la medaglia d’oro della città per il volume “Biagio Rossetti” Architetto ferrarese, il primo urbanista moderno europeo
1957
Danilo Dolci digiuna contro il governo della mafia.
I digiuni di Danilo
- Danilo Dolci durante il digiuno per la legge speciale su Palermo
Specie nei primi anni della sua lotta in Sicilia, il digiuno fu lo strumento emotivo più efficace a ogni livello, dai contadini ai governanti. A Roma, quando si annunciava «Danilo Dolci digiuna», alcuni uomini politici perdevano letteralmente la testa; non lo sopportavano, chiedevano con rabbia che smettesse.
A Partinico o Trappeto, sedevamo intorno al letto su cui era disteso: un poeta del luogo, un pittore milanese, un architetto romano, cinque o sei intellettuali e giornalisti, tre o quattro esponenti del Partito Comunista. Si discuteva della situazione generale dell’isola, delle risorse idriche perennemente sprecate, dei progetti per le dighe, del centro studi e iniziative di Partinico. L’impulso di Danilo si radicò progressivamente fra la gente, culminando nella clamorosa «marcia contro la mafia»: partimmo in trenta-quaranta persone, ma lungo il percorso centinaia e centinaia di donne e uomini ingrossarono il corteo che sfociò in un impressionante comizio.
Non sono un pianificatore «dal basso», né ho mai finto di esserlo. Credo nella programmazione democratica, controllata ma non delegittimata nei suoi poteri decisionali. Tuttavia, camminando per chilometri in quei viottoli siculi, gioivo di appartenere all’altra parte, a quella degli utenti della politica.
1958
Premio Tor Margana per la direzione della rivista “L’architettura – cronache e storia”.
Premio Tor Margana a “L’Architettura – cronache e storia”
- Alvar Aalto e Palma Bucarelli
1959
Fondazione dell’Istituto Nazionale di Architettura (In/arch), di cui è nominato vicepresidente.
Per la costituzione dell’In/arch, Istituto Nazionale di Architettura
 Ridotto del Teatro Eliseo, Roma, 26 ottobre 1959
Ridotto del Teatro Eliseo, Roma, 26 ottobre 1959
Cari colleghi,
l’idea di costituire un Istituto Nazionale di Architettura è emersa nel seno della sezione italiana dell’Unione Internazionale degli Architetti (UIA). Non è un caso. Per i suoi compiti, la nostra sezione UIA è venuta a contatto con le organizzazioni di architettura di molti paesi, ha visto come funzionano, ne ha analizzato la struttura. L’idea di un Istituto Nazionale di Architettura è sorta quasi spontaneamente. Dagli Stati Uniti all’ Australia, dall’Inghilterra al Brasile, dalla Svizzera all’Argentina, ovunque nel mondo esistono Istituti di Architettura, alcuni fortissimi, altri meno, tutti operanti. Soltanto l’Italia non ha un organismo del genere, una casa dove coloro che producono l’architettura si ritrovano, concordano il loro lavoro, dibattono problemi, predispongono strategie per incidere negli orientamenti della classe dirigente, nella vita del paese, nell’opinione pubblica. Questo vuoto è stato parzialmente colmato ora dall’Associazione fra i Cultori di Architettura, ora da un’Associazione Architetti, in qualche regione da un Collegio, spesso da enti di carattere professionale che hanno aggiunto alle loro già onerose funzioni alcune attività culturali. La stessa UIA, organizzando due convegni, si è assunta un carico che, all’estero, grava sugli Istituti Nazionali di Architettura. Tale è la situazione: un contesto di ottime intenzioni, un’interessante serie di iniziative che hanno vita breve e momentaneo successo. Nulla di istituzionalizzato, quindi nulla di solido, nessuna garanzia di continuità. Ma c’è subito da domandarsi: sentiamo veramente il bisogno di un simile Istituto? A questo interrogativo risponderete voi. Qui basti constatare che quanto gli Istituti di Architettura attuano negli altri paesi, da noi o viene realizzato in forme episodiche, oppure non viene realizzato affatto. I migliori Istituti di Architettura stranieri, dopo la guerra, tennero corsi di aggiornamento per ingegneri e architetti che tornavano alla professione; sistematicamente organizzano seminari, o cicli di conferenze, su aspetti dell’economia edilizia, sulle moderne tecniche e i nuovi materiali; svolgono un’intensa attività culturale con vivaci dibattiti e confronti sulle varie tendenze progettuali; promuovono mostre di architetti, o di architetture scolastiche, ospedaliere, residenziali, industriali; assegnano premi che hanno vastissima risonanza; collaborano all’insegnamento attraverso concorsi riservati agli studenti. Inoltre, dopo e insieme a tutto questo, si rivolgono agli altri, ai consumatori dell’architettura, stimolano la clientela con scritti, esposizioni, riunioni dirette a far conoscere agli utenti cosa i produttori hanno da offrire. Tramite gli Istituti, architetti e ingegneri edili corroborano la loro azione, l’ampliano, l’ingranano nella società. Nelle ultime elezioni inglesi, sia il partito conservatore che quello laburista hanno sottoposto all’elettorato circostanziate e analitiche piattaforme riguardanti l’architettura. Chi le aveva elaborate? È evidente, uomini del Royal Institute of British Architects di orientamento politico opposto: avevano una sede comune, affrontavano problemi analoghi, parlavano un linguaggio concordato, potevano dunque dire cose diverse.
In Italia invece tutti i partiti dicono le stesse cose in materia di architettura, perché non dicono nulla di impegnativo. Non abbiamo un ente che possa sollecitarli a scelte precise. L’architettura non ha un suo organo propulsore, non ha una propria rappresentanza. Possiamo citare innumeri esempi. La Triennale di Milano annovera, tra i suoi fini istituzionali, l’allestimento di mostre architettoniche, che da anni non organizza od organizza male; fortunatamente, in Lombardia esistono un Collegio e un Movimento Studi di Architettura; altrimenti, alla Triennale non succederebbe nulla, poiché tutti rappresentano e perciò nessuno rappresenta l’architettura. Ci sono i premi Marzotto: perché non sono stati istituiti anche per l’architettura? È chiaro, nessuno lo ha proposto, perché nessuno difende l’architettura. Non parliamo di eventi culturali: muore Frank Lloyd Wright, uno dei massimi geni della vicenda architettonica, o scompare Bernard Berenson, uno storico il cui pensiero e costume critico incidono largamente anche in architettura; ebbene, in Italia non vi è una sola commemorazione solenne di queste due personalità. Chi dovrebbe promuoverla? I consigli o la federazione degli Ordini, l’ANIAI, l’UIA? Non lo fanno, non l’hanno mai fatto, perché non è nei loro obiettivi. Dunque gli architetti italiani sono dei selvaggi, e non degli intellettuali o degli artisti? Neppure questo è vero. La diagnosi è semplice: non abbiamo istituzionalizzato la nostra attività culturale, che quindi fa acqua da tutte le parti. Vantiamo un record di brillantissime iniziative, dai premi Olivetti ad alcune riviste qualificate e diffuse, ma esse non creano un costume, non garantiscono una crescita e uno sviluppo, perché manca un centro di coordinamento e propulsione, un Istituto Nazionale di Architettura.
Un raffronto con ciò che avviene in urbanistica si impone. Debole per tanti versi, osteggiato, portavoce degli interessi di una pianificazione statale, regionale, provinciale e comunale che lo Stato recepisce scarsamente – le regioni non sentono affatto, le province forse sentirebbero ma non possono concretare, i comuni avvertono ma non hanno i mezzi per rendere operativi, esponente di tematiche della vita associata incomprese dai più – malgrado tutto, l’Istituto Nazionale di Urbanistica è un organismo a carattere stabile, che ha superato anche i passaggi più spinosi della storia del paese; mobilita l’opinione pubblica nei suoi congressi, intesse con la classe dirigente un colloquio sistematico, una costruttiva dialettica di consensi e opposizioni. Se avessimo in architettura un Istituto paragonabile a ciò che è l’INU per l’urbanistica, disporremmo di una forza immensa, travolgente; ve ne potete rendere conto paragonando il peso di un piccolo nucleo di urbanisti che svolge un’azione contro corrente alla potenzialità delle migliaia di professionisti attivi in architettura. Dietro l’urbanistica non c’è nessuno, a eccezione di poche decine di persone illuminate, e vastissimi interessi sono contro; dietro l’architettura vi sono complessi, enormi interessi, tutti miranti a incrementare il lavoro; un Istituto Nazionale di Architettura può dunque avere un prestigio e una fortuna nemmeno pensabili, per ora, nel campo urbanistico.
Forse, dovrei fermarmi qui: le ragioni esposte sono sufficienti a determinare la costituzione di un Istituto Nazionale di Architettura. E invece il discorso serio comincia solo adesso. Tutto ciò che ho detto è ovvio, scontato. Se gli scopi del nostro Istituto fossero limitati alle prospettive elencate, esso non si realizzerebbe o nascerebbe male, dacché non si possono ricalcare le orme di enti impostati cinquant’anni o un secolo fa, anche se le attività che essi svolgono sono tuttora necessarie. Perché un’impresa impegni e appassioni, specie in un periodo di prosperità e perciò di fiacchezza morale, occorre che sia originale, presenti un rischio, imponga un esperimento coraggioso. Senza dubbio, anche nell’ambito della cultura architettonica destinata agli ingegneri e agli architetti c’è moltissimo da fare per stabilire un ponte tra produttori e consumatori di architettura; ma la struttura organizzativa per raggiungere questi obiettivi non può essere quella tradizionale degli Istituti di Architettura esteri, non può consistere nel creare un ennesimo ente a carattere professionale anche se con mansioni specificamente culturali.
Arriviamo ultimi, bisogna almeno arrivare bene; anzi dobbiamo arrivare primi nel configurare un orientamento così attuale, aperto e inedito da costituire; un indice anche per le forze architettoniche di altri paesi.
Il tema dunque si allarga, spalanca i suoi orizzonti. Di che si tratta?
Semplicemente della sorte degli intellettuali in una società condizionata dai mass-media e quindi dalla cultura di massa; segnatamente, fra gli intellettuali, della sorte di coloro che professano l’architettura nel quadro della produzione edilizia a scala, seconda metà del XX secolo. Si tratta insomma di riesaminare la struttura della nostra professione nella società contemporanea, nell’epoca della seconda rivoluzione industriale e dell’energia atomica.
In un’intervista pubblicata sul settimanale “L’Express” di Parigi, il celebre romanziere Arthur Koestler constatava che lo slittamento verso una cultura uniforme e stereotipata è divenuto un fenomeno irresistibile. I mezzi di comunicazione moderna creano una cultura controllata a reazione. Tra l’intellettuale e il suo pubblico si è interposto il microfono, che non soltanto impone all’intellettuale di parlare a una platea sterminata, sconosciuta e indifferenziata, ma permette anche a chi gestisce il meccanismo delle informazioni di rilevare, entro poche ore, le reazioni dei consumatori e quindi di condizionare la produzione a livelli sempre più bassi. Di fronte al dilagare dei mass-media, la minoranza degli intellettuali è in stato di impotenza: un’inquietudine profonda la pervade, un senso di distacco dalla società la condanna a un isolamento drammatico e spesso disperato, tanto più grave quanto meno l’intellettuale ne è cosciente. L’intellettuale soffre, fatica, dedica se stesso al lavoro; ma nel momento in cui ne traccia un bilancio si accorge di aver appena scalfito la realtà, di averla soltanto aggettivata senza inciderne la sostanza. Il nostro bilancio è in deficit assai più di quello degli intellettuali del passato poiché essi, anche non ottenendo il successo, potevano contare sulla fedeltà di una ristretta clientela e puntare sul riconoscimento dei posteri, mentre gli intellettuali d’oggi sono immersi in una produzione che non lascia loro né il tempo, né la serenità, né l’agio di pensare, preclude la via del ritiro, e fa sì che l’infarto o il cancro li sorprenda quando ancora non hanno avuto modo di riflettere su se stessi, sulla loro funzione nel mondo, sul rapporto con gli altri. Perciò gli scompensi psicologici aumentano con ritmo pauroso, file di intellettuali si allineano nei gabinetti degli psicanalisti; per difendersi dalla corrente amalgamatrice, per salvarsi, ognuno cerca di costruire un proprio castello, un proprio regno, una serie di difese contro il mondo ma, in tale processo l’equilibrio diviene sempre più instabile, crolla, per un motivo qualsiasi, di regola anzi senza nessun motivo. Nell’età dell’automazione e dei voli interplanetari, la classe degli intellettuali e degli artisti, che dovrebbe dominare il tempo libero finalmente elargito dal processo industriale alla maggioranza degli uomini, proprio quella classe che ha stimolato nel mondo la curiosità degli spazi e che gli spazi ha descritto e figurativamente rappresentato nell’ora del suo trionfo, è in stato di disfacimento e liquidazione. La prosperità esteriore può ingannare gli altri, non gli intellettuali stessi che, ogni giorno di più, si sentono fuori del gioco. Che c’entrano gli architetti in questo tenebroso quadro? Apparentemente poco, in quanto, per alcune doti di estrinsecazione espressiva, la professione li favorisce rispetto agli altri intellettuali, offre loro maggiori gratificazioni, li rende meno ricettivi e sensibili, immunizzandoli in parte da verticali crolli psicologici. Tuttavia, a ben vedere, il loro destino è comune a quello di tutti gli intellettuali, poiché i contrasti, le antitesi, le lacerazioni tra individuo e società raggiungono anche in architettura un’intensità spaventosa, un grado di schizofrenia. La scissione tra cultura ed economia nel campo architettonico è oggi tale da indurre a definire l’età in cui viviamo come l’età del paradosso.
Registriamo infatti questa incredibile situazione: gli architetti e l’industria edilizia sono non solo separati, ma agli antipodi. Ogni volta che vediamo demolire una casa, anche se non ha alcun valore artistico, proviamo un senso di amputazione, non sospettiamo neppure che al suo posto possa sorgere un edificio migliore; pensiamo subito a una legge economica che farà costruire più vani e più piani, che aumenterà il numero degli abitanti e delle automobili parcheggiate per strada. I produttori dell’architettura sono così in continua polemica con le forze che permettono di produrre l’architettura. E poiché l’iniziativa economica è assai più pressante e veloce di quella culturale, gli architetti sono ridotti alla periferia del fenomeno edilizio, in stato di passività, servono l’iniziativa economica, ma senza convinzione profonda e perciò senza vera possibilità di ispirazione poetica; il giudizio sui contenuti dell’ architettura sembra sfuggire al campo decisionale degli architetti in un’epoca in cui l’invenzione del programma edilizio costituisce il primo atto della creatività architettonica. Cosa rimane? La forma in senso epidermico, magari tridimensionale anziché di mera facciata, ma comunque estrinseca non essendo dettata dalla passione per il tema. Sul terreno psicologico, poi, il fenomeno più paradossale è questo: tutti gli architetti, a parole, inorridiscono al solo nome della Società Generale Immobiliare, ma tutti, o quasi, ne sono al servizio o sono complici di aziende immobiliari anche peggiori.
Il verdetto è automatico, la diagnosi chiarissima: infranto il rapporto tra economia e cultura, l’architettura è in stato di paralisi. Circolo vizioso.
Nessuno di noi, da solo, ne esce più: non il professionista che, malgrado tutto, deve campare; né lo storico d’architettura, costretto ad apparire non un alleato degli architetti moderni, ma un loro fustigatore; né il costruttore, che sente ogni sua iniziativa giudicata negativamente, quasi l’intento imprenditoriale fosse a priori deplorevole. Non ne esce l’amatore di architettura, obbligato a ripiegare sui romanticismi nostalgici della vecchia Roma, della vecchia Milano, della vecchia Napoli, tagliato fuori da una vera collaborazione con l’attività moderna. Non ne escono i geometri considerati schiuma della terra, rifiuto, da ingegneri e architetti che spesso compiono obbrobri assai più vistosi dei loro. Non ne escono i banchieri, i controllori del credito, a cui nessuno dice dove, quando, come i finanziamenti dovrebbero essere concessi per risultare più utili. Non ne esce l’amministratore locale, cui l’urbanista consegna un Piano Regolatore che nessuno vuole, che gli operatori economici e i costruttori per primi, ma non ultimi anche gli ingegneri e gli architetti, coadiuvano a sabotare. Non ne escono i parlamentari e gli uomini di governo, sollecitati in direzioni diverse e spesso contrastanti da architetti, ingegneri, costruttori, operatori economici, giornalisti, critici, amministratori locali. Insomma, è la sclerosi dell’architettura come atto di cultura integrata. Il divario tra cultura ed economia è divenuto un baratro, e allora la cultura si ritira in astrazioni, cessa di essere engagée, cade nel solipsismo e nel pessimismo, mentre l’economia si trasforma in bruta speculazione e, là dove incrocia la politica, contribuisce alla corruzione e al sottogoverno.
Si può migliorare la situazione, per dare all’attività architettonica il prestigio che le compete? Chi non lo crede, ritenendo che la società italiana sia irrimediabilmente corrotta, è pregato di accettare le scuse del comitato promotore di questa riunione per il disturbo arrecatogli.
Gli altri… nutrono dubbi, molti e gravi. Nessuno pensa che sia facile superare la paralisi in cui si trova l’architettura. A cosa porteranno le nostre perplessità? Lo vedremo tra breve. Se le titubanze prevalgono, possiamo rimandare sine die il varo dell’Istituto Nazionale di Architettura. In caso contrario, se decidiamo di saltare il fosso, lo faremo con una tenacia derivante dalla convinzione che non c’è altra via; non con superficiale ottimismo ma sicuri che, senza questa rischiosa avventura, l’architettura continuerà fatalmente a perdere terreno. In uno scritto autobiografico, Pierre Mendès-France raccontava di quando, dopo il crollo francese, era riparato in Inghilterra e partecipava, nell’armata di De Gàulle, alla battaglia aerea di Londra. Aveva una paura folle che gli provocava irrefrenabili conati di vomito: saliva in aeroplano, combatteva e, scendendo a terra, vomitava; poi, rimontava in aeroplano. In circostanze assai meno drammatiche ma altrettanto serie per l’architettura, ci troviamo in una posizione analoga. Si può rinunciare a volare, e non si fa l’Istituto; chi vuol farlo, deve aver paura ma non temere di averla conoscendo i rischi e accettando l’avventura.
Oggi è assurdo pensare a un Istituto di Architettura di vecchio stampo, affine a quelli fondati decenni or sono in società affatto diverse: un Istituto che organizzi un circoletto di conferenze, un congressetto ogni anno, qualche pubblicazioncina, e si perda in questioni meschine se, per esempio, vi debbano essere ammessi i critici d’arte o i costruttori o i geometri o i banchieri. Abbiamo già salde istituzioni professionali dagli Ordini all’ANIAI; non vogliamo doppioni. Se l’Istituto Nazionale di Architettura va creato, i suoi orizzonti devono essere ampi, l’obiettivo dell’incontro tra produttori e consumatori, che coincide con quello dell’integrazione tra cultura ed economia, deve essere costantemente presente. Sono state avanzate le riserve più strampalate all’idea di fondare l’Istituto: c’e chi paventa che gli Ordini si offendano, che l’ANIAI vi individui un ente rivale, che gli architetti, (oh mammole puritane!) si corrompano a contatto con i costruttori o sfigurino vicino ai critici d’ arte; e ancora, chi pretende che l’Istituto sia una federazione delle organizzazioni professionali esistenti, o si chiami Istituto Nazionale di Edilizia e non di Architettura, o Centro-studi, o Movimento.
Tutte queste recriminazioni e controproposte nascono da un equivoco, dal sospetto cioè che si voglia un Istituto di Architettura di vecchia formula, nello stesso spazio occupato almeno parzialmente dagli Ordini, dalla Federazione degli Ordini, dall’ANIAI, dall’UIA, dai Collegi o dalle Associazioni di Ingegneri e Architetti. Nulla di questo: qui si intende configurare qualcosa di assolutamente diverso, che risulterà in un solenne fiasco oppure in un’iniziativa nuova, straordinariamente efficace. Eleviamo dunque il discorso al di sopra di queste beghe, delle gelosie settoriali di architetti e ingegneri, pensiamo al destino dell’architettura nell’insieme e ai suoi ingredienti economici, politici, sociali, artistici. Nessuno vi chiede atti di altruismo o sacrifici. Al contrario.
L’Istituto, per risultare efficace, deve rispondere all’interesse diretto, egoistico, di chi professa l’architettura, ed essere gestito da uomini convinti che, attraverso il loro lavoro nel nuovo organismo, saranno più soddisfatti e felici, quindi più utili al paese.
Cosa farà l’Istituto Nazionale di Architettura? Qual’è il suo programma? Nessuno lo sa. Potrei tracciarvi un calendario dettagliatissimo per cinque anni; ma i programmi, anche i più seducenti, non servono se non corrispondono a una struttura di interessi; e viceversa, quando la struttura esiste, i programmi discendono da soli. Prima di discutere gli articoli dello statuto, prima di sapere quel che fa, importa sapete quello che è l’Istituto. È il luogo, il tavolo intorno al quale si incontrano le forze che producono l’architettura: industriali, banchieri, costruttori, ingegneri e architetti, fino ai critici d’arte e agli amatori di architettura.
Ci confronteremo; esamineremo in condizioni di parità, e non in quelle di subordinazione tra cliente e architetto, fino a qual punto i vari interessi possano conciliarsi. Cosa vogliono gli operatori economici? Guadagnare costruendo: è forse illegittimo? Cosa vogliono i critici d’arte? Difendere il paesaggio urbano e rurale: è sacrosanto. Ma è mai possibile che, per costruire, occorra rovinare le città o, per difenderne i monumenti, sia necessario vietare le costruzioni? Una strada comune, pur con grandi difficoltà, si deve trovare, altrimenti ci fermeremo all’attuale paralisi, per cui le città e il paesaggio vengono deturpati, la ricchezza nazionale è almeno in parte sperperata, i costruttori considerano gli architetti degli ingenui o dei pazzi, i critici elevano le loro proteste ma senza riuscire a evitare i disastri, perché arrivano quasi sempre troppo tardi. L’Istituto di Architettura deve essere un centro dove i vari personaggi della scena architettonica, dagli industriali ai giornalisti, finora isolati, trovino un canale di comunicazione, la sede di sinceri e chiari dissidi, lo strumento per rompere la segregazione. La cultura ha tutto da guadagnare e niente da perdere; oggi, nel 99,99 per cento dei casi, la cultura e la professione architettonica sono a servizio passivo della speculazione. Gli architetti invero non possono essere corrotti. Il proverbio «il peggio non è mai morto» qui non funziona. Il peggio c’è già. Cosa può nascere da una collaborazione di questo tipo, tra forze così eterogenee? Il minimo: l’educazione dei clienti. Il massimo: un’edilizia liberamente pianificata e tale da sostanziare l’attività urbanistica.
Sull’educazione dei clienti non occorre indugiare. L’Italia è l’unico paese del mondo civile i cui fruitori di architettura non siano oggetto di attenzione, di pressione didattica. Il risultato è che la nostra storia architettonica, appare, sempre più, ingemmata di occasioni perdute. Organizzeremo mostre nelle grandi città e in provincia, inviteremo i maggiori architetti stranieri, esporremo esempi di ciò che si ha all’estero nei vari campi, valorizzeremo i progettisti italiani e le loro opere più qualificate; istituiremo premi in ogni regione, diffonderemo opuscoli diretti ora ai parlamentari, ora agli amministratori locali, ora ai costruttori, ora alle masse dei consumatori. Il pubblico c’è, la congiuntura è fortunata, ma non sappiamo sfruttarla. Nessuno di noi, da solo, può farlo: non i professionisti, tutti presi dal loro lavoro; non gli storici e i critici impegnati in attività scientifiche di livello universitario; non i giornalisti che non sanno a chi e dove rivolgersi. Solo un Istituto Nazionale di Architettura può affrontare il compito: è nell’interesse di tutti ampliare e qualificare i consumatori di architettura, la massa di gente che usa i nostri prodotti.
L’obiettivo massimo è invece programmare l’iniziativa economica nel campo edile fino a portarla a scala e a livello urbanistico. Bisogna guardare al domani, a imprese assai più vaste di quelle del «villinetto» che si trasforma in palazzina, dell’attico che sporge o del superattico che viola il regolamento edilizio. Queste forme di speculazione minuta sono uno strascico artigianale, un residuo del mondo di ieri: nel futuro ci troveremo di fronte a iniziative massicce, a programmi edilizi che investono centinaia e centinaia di ettari. Gli intellettuali, ingegneri e architetti devono scegliere: porsi ai margini della realtà, o alla testa delle forze imprenditoriali. L’idea dell’Istituto Nazionale di Architettura è una sfida: sono capaci gli architetti di concepire e dar forma a grandi piani edilizi proficui per chi li intraprende, e insieme utili per il paese e per l’arte? Se non lo sono, l’ambizione di creare un Istituto di Architettura è illusoria e assurda, ma c’è di peggio: è sbagliata la struttura della nostra professione, il mestiere dell’ architetto si riduce a un’attività parassita di disturbo. Il mondo va avanti, gli architetti rimangono indietro. Accadono cose straordinarie. Nell’ultimo congresso del Partito Socialista, Riccardo Lombardi dichiara: «il socialismo non si fa più con gli scioperi, ma attraverso il controllo degli investimenti statali», sovvertendo la concezione tradizionale classista e aprendola ai temi del New Deal; ma gli architetti arrivano all’ultimo momento, a programma edilizio già elaborato, quando tutto o quasi è già compromesso.
Il mondo cammina, con o senza architetti. Il caso del grande parco archeologico di Roma ne è un sintomo. Se il Piano Regolatore lo avesse previsto e imposto, non sarebbe mai stato attuato, perché un’urbanistica paternalista incontra l’opposizione di tutte le forze economiche.
Siccome però il parco è stato pensato nell’ambito di un programma economico, pare che i lavori stiano per cominciare. È buona o cattiva l’idea del parco archeologico? Non si può rispondere in astratto; bisogna mettersi a tavolino, fare i calcoli, precisare il costo del miracolo, abbassarne il prezzo se fosse esoso. Né più né meno di quanto fa un Walter Reuther, capo dei sindacati operai americani del CIO, quando tratta con il presidente della General Motors. Non lo apostrofa con male parole, non lo ricatta con la minaccia di scioperi, che suonerebbe ridicola in tempi di automazione; gli dimostra che, ricontrollati i bilanci, i profitti della General Motors sono aumentati, che i salari, di conseguenza, devono essere elevati anche perché il miglioramento del tenore di vita della classe operaia serve alla General Motors per incrementare gli acquirenti. La lotta di classe, negli Stati Uniti, si avvia a diventare una competizione scientifica e tecnica tra i centri studi dei complessi industriali e quelli dei sindacati operai. Nel campo dell’architettura, invece, dove sarebbe folle pensare a uno sciopero dei consumatori o a una serrata dei produttori, si persiste in un atteggiamento di falso puritanesimo, si dice no a tutto ciò che propongono gli operatori economici (salvo poi a fare sì come professionisti privati), non si offrono alternative; non riconoscendo i diritti dell’iniziativa economica, non si tenta nemmeno di integrarli con quelli dell’architettura. C’è qualcuno che possa tentare da solo? No, il tentativo può essere compiuto unicamente da un Istituto Nazionale di Architettura che nasca su questa ispirazione. Avrà successo? È dubbio. Ma è chiaro che da questo Istituto e dalla sua fortuna dipende, in larga misura, l’avvenire dell’architettura, e anche dell’urbanistica italiana.
Non a caso, tra i colleghi presenti, si contano molti urbanisti. Io credo che il bilancio culturale dell’INU sia decisamente in attivo. Ma se l’efficacia del suo operato non è proporzionale alla passione e all’intelligenza dimostrate dagli urbanisti, ciò dipende dal fatto che, una volta elaborato un Piano Regolatore, anche il migliore dei piani, esso non trova rispondenza nell’iniziativa economica, non riesce a farsi realtà.
Un Istituto di Architettura è la necessaria integrazione dell’Istituto di Urbanistica e ne rafforza l’azione. Tra il Piano Regolatore e il lavoro degli architetti vi è uno iato, un vuoto che sconfigge il piano e sminuisce il senso e il significato dell’attività architettonica. Questo vuoto va riempito, sulla traccia della strategia di alcune planning commissions americane, e ciò è il compito di un Istituto di Architettura: a monte, nell’interesse di assetti urbani e rurali che poi vengono configurati e orchestrati nei piani; a valle, nell’interesse della professione, dell’architettura, dell’arte. Questo è l’obiettivo massimo: pianificare la libera iniziativa economica in modo tale da sostanziare la pianificazione urbanistica. Se ciò accadesse, finalmente cultura, economia e politica troverebbero un punto di convergenza.
Non vorrei che il miraggio dell’avventura ci facesse dimenticare le difficoltà da superare. Sono molte, e non riguardano le critiche, i pettegolezzi di questo o quel consiglio dell’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, di qualche Collegio o Associazione. Questi sono piccoli ostacoli, sorti su equivoci facilmente dissipabili, su risibili malignità, su quel costume italico per il quale, ogni volta che si propone una cosa nuova, tutti si domandano: che cosa c’è sotto? E, quando scoprono che non c’è niente, tentennano la testa con gravità e dicono: chissà cosa c’è sotto! Non sono questi gli scogli che preoccupano. Allarma invece un altro tipo di opposizione occulta che deriva dai settorialismi in cui è scisso il mondo architettonico. Diciamolo francamente; poiché i vari protagonisti della produzione architettonica vivono in compartimenti stagni, contro l’idea di un Istituto Nazionale di Architettura che spezzi gli attuali frazionamenti, e porti il discorso su un altro livello, sono schierati tutti:
– sono contro i tradizionalisti, perché temono che questo Istituto cada nelle mani di una minoranza di architetti moderni, facinorosi, eversivi;
– sono contrari gli architetti moderni che non riescono a capire perché chi più si oppone alla cattiva architettura auspichi l’ingresso nell’Istituto di tutti i professionisti, anche dei peggiori;
– sono contrari gli architetti nel loro insieme, monumentalisti e moderni, perché vedono nella presenza forse soverchiante degli ingegneri edili nell’Istituto una condizione di inferiorità;
– ma gli ingegneri sono a loro volta contrari, perché sospettano che gli architetti, in un Istituto di Architettura, prevalgano, e già alcuni hanno fatto il calcolo di quanti ingegneri appartengano al comitato promotore rispetto agli architetti;
– ingegneri e architetti nel loro insieme sono poi contro l’Istituto di Architettura perché non vogliono i costruttori, oppure non vogliono i critici d’arte e meno ancora gli amatori di architettura, dizione che chiaramente include anche i geometri;
– i costruttori sono contro. Per varie ragioni: anzitutto, perché non intendono sottoporre agli architetti e agli ingegneri le loro iniziative; poi perché, nel loro stesso ambito, i piccoli temono di essere soffocati dai grandi, e i grandi temono che i piccoli, alleandosi con gli ingegneri e gli architetti, acquistino troppo peso;
– sono contrari anche i banchieri, gli industriali, gli operatori economici, avendo il vago sentore che, in un Istituto del genere, saranno degli eterni accusati, e perché attribuiscono agli architetti ogni qualità tranne la ragionevolezza. La lista potrebbe continuare. Sono contrari tutti, perché un Istituto di Architettura infrange i privilegi di categoria, non fa gli interessi di nessuno, non può essere comprato o dominato da nessuno; infine, perché un Istituto organicamente articolato è un’istituzione, e si paventano le istituzioni in quanto ci si trova benissimo con il sottogoverno.
Tale è la situazione: per creare un Istituto Nazionale di Architettura bisogna invertire il senso delle forze che determinano l’architettura del paese. Oggi sono forze centrifughe, di parte: occorre che si trasformino in fattori dell’equazione architettonica. Ma per realizzare questo obiettivo ci vuole coraggio, spregiudicatezza, visione.
E concludo. Che cosa avverrà ora? I casi, come sempre, sono due: o questa assemblea conferma che la nostra iniziativa è opportuna e urgente, e allora nella cronaca e nella storia dell’architettura italiana si leggerà: «1959, ottobre 26: si costituisce l’Istituto Nazionale di Architettura». Oppure, niente. Nel secondo caso, che non spaventa nessuno, anzi è segretamente auspicato perché esonera da un’altra fatica, l’Istituto Nazionale di Architettura non si crea. La discussione intristisce, le beghe e le gelosie settarie mortificano i temi del dibattito, tutto si diluisce e stempera: l’Istituto non si fa, e nessuno si sente offeso o sconfitto. L’idea non è attuata, ma non è nemmeno sciupata: sarà ripresa domani, magari in altre forme, da persone migliori di noi. Anche senza alcun risultato immediato, questa riunione non sarà stata inutile: è nata un’idea che ha mobilitato le forze dell’architettura italiana, provocando dissidi, pettegolezzi, entusiasmi, e pure consensi e opposizioni, perché è viva, moderna, coraggiosa. L’idea di un Istituto Nazionale di Architettura sarà rimasta un sogno, ma un sogno esplicitato, chiarito, discusso, comunque stimolatore. Diceva Teodoro Herzl, fondatore non di un Istituto, ma di uno Stato: «I sogni non sono poi così diversi dalla realtà, come qualcuno crede; tutte le imprese degli uomini, all’inizio, sono dei Sogni».
-
Accademico di merito dell’Accademia Linguistica di Belle Arti di Genova.
Scomparsa di Frank Lloyd Wright. Commemorazione a Venezia.
Scomparsa di Frank Lloyd Wright
 Istituto Universitario di Architettura Venezia, 10 aprile 1959
Istituto Universitario di Architettura Venezia, 10 aprile 1959
Ieri mattina, a Taliesin West, in Arizona, Frank Lloyd Wright, quasi novantenne, ha chiuso il suo lavoro. E la notizia spaventa, è giunta improvvisa e imprevista tanto gli anni sembravano non incidere sulla sua personalità e sulle sue incredibili capacità creative. Perciò siamo tutti impreparati a commemorarlo: non possiamo dire di lui che è vissuto troppo poco, né troppo, e neppure abbastanza. Aveva raggiunto un livello di maturità umana, civile e artistica nel quale la nozione del tempo è distrutta, e con essa quella di un progresso. Si può parlare di un primo periodo della sua attività, culminante nel primo decennio del nostro secolo con l’epopea delle Prairie Houses. Si può individuare un secondo periodo, dal 1915 al 1932-34, caratterizzato da un ricerca plastica, da una volontà di possesso della natura e del messaggio dei materiali. Ma è impossibile parlare di una vecchiaia, come invece si può per tanti altri maestri ancora viventi. Dopo la Casa sulla Cascata e gli Uffici Johnson a Racine, le opere di Wright si susseguono in una sequenza che sfugge ai rapporti di causa ed effetto, e sono “doni” che egli elargisce ad un mondo in cui sente di essere tanto più solo quanto più è applaudito e onorato.
Il lavoro di Wright poteva terminare con ciascuna di questa opere, senza distinzione. Si è chiuso con due edifici ed un libro: un museo e una sinagoga, e un volume intitolato “A Testament”. Aveva bisogno di altre prove, di altre affermazioni, di altro successo? No, Wright da molti anni sentiva di aver compiuto la sua missione, di aver donato al mondo una visione dell’architettura come strumento ed espressione di una democrazia in cui l’individuo è sovrano, di aver concretato questa visione in ogni possibile modo. Non era felice ma, figlio di un missionario, aveva imparato sin da bambino a non ricercare la felicità, o a intenderla soltanto nella fenomenologia quotidiana, nell’esperienza lenta del lavoro. Aveva avuto un’aspirazione: quella di creare una scuola, una comunità di giovani capaci di continuare la sua via. La Fondazione di Taliesin era questo?
Diceva pubblicamente di sì, ma in privato confessava di dubitarne, e non si trattava dell’impossibilità di trasmettere metodi o principi della composizione architettonica, quanto metodi e principi di vita. I giovani che, da ogni paese del mondo, andavano a Taliesin non erano mediocri sul terreno professionale, ma su quello umano. Appartenevano a generazioni di cui Wright non poteva comprendere i problemi, ad un’America ormai remota dal pionierismo e a un’Europa avvilita da decenni di dittature e di guerre. Egli intuiva che i suoi principi non potevano essere applicati nella loro rappresentazione architettonica, senza realizzarsi prima in un sistema di vita coraggioso, intrepido, scevro di calcoli, di conformismi, di convenzioni. I giovani accettavano la sua architettura e, per entusiasmo e amore, ripetevano il suo pensiero; ma la loro struttura morale non poteva reggere a lungo ad una situazione intimamente artificiosa, per sostenere la quale la volontà non basta, ma occorre la vocazione. Artificioso risultava anche il tentativo di produrre a Taliesin condizioni di vita diverse da quelle attuali, fondando una comunità libera e isolata dal mondo, in cui ognuno potesse ritrovare le proprie energie spontanee per scaricarle poi nell’attività architettonica. La presenza di un genio conferiva alla comunità di Taliesin una coloritura paternalistica, di cui Wright si rendeva conto. Perciò, in questi ultimi anni, la speranza di veder continuare il suo lavoro era in larga misura svanita o si era appena attenuata. Ritrovano l’uomo e l’opera in una specie di serena scommessa. L’America e il mondo si erano finalmente svegliati. Non per abbracciare le idee di una vita o di un’architettura organica, ma per riconoscere la grandezza del suo apostolo. E Wright pensava che questo fosse un mezzo per spiegarsi, in fondo, e persuadersi della necessità di una nuova cultura. Ogni suo edificio significava un passo avanti nella lunga strada di questa affermazione: che fosse la sua architettura anziché le sue idee a prevalere non aveva in fondo importanza perché la sua architettura riassumeva e proiettava non solo le sue idee, ma una totale concezione della vita. Da ogni angolo della terra nelle ultime ventiquattro ore sono partiti migliaia di telegrammi diretti a Taliesin. Un’ora dopo la morte di Wright le agenzie giornalistiche europee chiedevano dichiarazioni agli architetti che avevano conosciuto, amato, seguito il maestro. Avviene sempre così; ma è sembrato ieri che si organizzasse addirittura uno sfruttamento pubblicitario sulle emozioni di ciascuno di noi, quando era il momento per riflettere silenziosamente.
Perché non c’è davvero nulla da commemorare su di lui, commemoriamo noi stessi, affranti, mutilati dalla sua scomparsa. È evidente che per noi Wright è stato molto più di un grande architetto, da ammirare o da illustrare; ha costituito un vettore, un motivo, una linea-forza infranta con la quale non la mera storia architettonica, ma la storia in generale appare disperatamente impoverita. In una società che corre il continuo pericolo di essere sommersa dal proprio scetticismo, dalla propria pigrizia, dalla propria viltà, potevamo rivolgere il pensiero a Wright e dire: «C’è lui a dimostrare che l’individuo è sovrano e che la libertà è un principio operante, attualissimo, indispensabile a tutti. In una civiltà in cui si diventa vecchi a venti anni, potevamo indicare lui vitale e indomito, incapace di ripetersi e di imitare se stesso a 90 anni». Persino in quegli sciagurati che individuano lo scopo della vita nel successo potevamo incuneare un dubbio, proprio dimostrando come Wright ne avesse raggiunto uno massimo senza deflettere dai suoi principi, senza mai confondere -questo era il suo fondamentale principio- il bello con il curioso.
Insomma Wright incarnava l’esempio prima che dell’architettura, della vita dell’architetto, condizione di ogni architettura.
1960
Primo ternato nel concorso per la cattedra di Storia dell’arte e Storia e stili dell’architettura Professore di ruolo a Venezia.
Professore di ruolo a Venezia
 Primo concorso per la cattedra di Storia dell’Architettura bandito dall’università italiana: primo della terna vincitrice. Il merito (o l’errore?) va ascritto a Giulio Carlo Argan e a Giuseppe Samonà, cui si è associato Salvatore Caronia Roberti, costringendo così perfino Giovanni Muzio e Mario Salmi a votare favorevolmente. Quasi in contemporanea, “maturità” al concorso per la cattedra di Storia dell’Arte Medievale e Moderna indetto dalla Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo.
Primo concorso per la cattedra di Storia dell’Architettura bandito dall’università italiana: primo della terna vincitrice. Il merito (o l’errore?) va ascritto a Giulio Carlo Argan e a Giuseppe Samonà, cui si è associato Salvatore Caronia Roberti, costringendo così perfino Giovanni Muzio e Mario Salmi a votare favorevolmente. Quasi in contemporanea, “maturità” al concorso per la cattedra di Storia dell’Arte Medievale e Moderna indetto dalla Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo.
-
Maturità nel concorso per la cattedra di Storia dell’arte medievale e moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia.
-
Accademico cultore dell’Accademia Nazionale di San Luca. Fonda e dirige l’Istituto di Storia dell’architettura a Venezia.
Pubblicazione di “Architectura in Nuce”.
1961
Studio professionale A/Z con Errico Ascione e Vittorio Gigliotti.
Studio professionale A/Z, con Errico Ascione e Vittorio Gigliotti
- Ponte Garibaldi, Roma
- Perugia
- Stazione di Napoli
- Biblioteca “Luigi Einaudi” Dogliani
Con Italo Balletti, Maria Calandra, Antonio Di Carlo, Lisa Ronchi e Luciano Rubino. Un «vermicone» aperto, che risucchia lo spazio qualificandolo, e preme sull’intorno animandone l’insipido vuoto suburbano.
PROGETTO PER PONTE GARIBALDI, ROMA.
Con Carlo Cestelli Guidi, Antonio Di Carlo, James Ferris, Domenico Gentiloni Silverj e Myron Goldsmith. Disegno modernissimo, che tuttavia utilizza la pila centrale esistente abbassandola a una quota appena sollevata rispetto al fiume. Archi a superfici rigate, impalcato in precompresso che si prolunga fino a poggiare sui muraglioni affrancati dalle mediocri «spalle».
La cadenza romana è data dal peso figurativo dei «vuoti» incorniciati dagli elementi strutturali: sono gli spazi che determinano la «solidità» del ponte, come accade negli esempi antichi. A questa ardita soluzione è stato preferito il consolidamento dell’attuale, goffo ponte, perdendo così l’occasione di inverare, nel centro di Roma, un gesto di qualità.
PIANO REGOLATORE DI PERUGIA.
Con Mario Coppa. La metodologia di Montagnana applicata a una città non-murata, diramantesi sul territorio. La tutela del centro storico è garantita da una strategia periferica che prevede una nuova direzionalità, oggetto, anni dopo, di un grande concorso internazionale promosso mediante la pubblicazione delle tavole Messaggi Perugini.
STAZIONE FERROVIARIA DI NAPOLI CENTRALE.
Con Bruno Barinci, Massimo Battaglini, Corrado Cameli, Mario Campanella, Carlo Cocchia, Giulio De Luca, Marino Lombardi, Pier Luigi Nervi, Luigi Piccinato, Giuseppe Vaccaro, Ugo Viale. Frutto di tre progetti premiati ex aequo nel concorso del 1955, malgrado le invadenze della burocrazia statale e le pecche dell’esecuzione strutturale, comunica l’intenzionalità originaria: non un fabbricato, ma una piazza coperta che consente un fluido scambio fra treni e città.
Il grattacielo a tre braccia, curato particolarmente da Giuseppe Vaccaro, vitalizza l’inerte slargo antistante con un accento verticale, asimmetrico, coagulo visuale anche per le strade limitrofe. Dopo le stazioni di Firenze e di Roma, un ulteriore contributo alla battaglia contro il monumentalismo e lo spreco che caratterizzano gran parte dell’edilizia pubblica italiana.
BIBLIOTECA ”LUIGI EINAUDI” DOGLIANI.
Con lo Studio A/Z e la collaborazione di Nello Renacco, Ruggero Altavilla e Michele Pagano. Di notte e di giorno, una promenade tra i libri scesi finalmente in strada e disponibili a tutti. Struttura metallica integralmente prefabbricata eseguita a Napoli sotto la supervisione di Vittorio Gigliotti: un prototipo di biblioteca popolare, ubicabile in qualsiasi viale o piazza. Immagine dichiaratamente wrightiana nell’esistenza delle orizzontali, negli sfalsamenti parietali, negli incastri e negli angoli indentati. Eppure, nessuno rileva questa franca ispirazione al linguaggio del genio americano; forse perché, essendo cosciente in ogni fibra, risulta spontanea. All’inaugurazione sono presenti Giulio Andreotti, Giuseppe Pella, Giuseppe Medici, Giacinto Bosco, Cesare Merzagora e, naturalmente, moltissimi autori della casa editrice Giulio Einaudi, tra i quali Carlo Levi.
1962
-
Accademico Onorario dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.
-
Membro della Commissione Nazionale per la Programmazione Economica.
1963
Chiamata alla cattedra di Storia dell’Arte e Storia e Stili dell’Architettura alla Facoltà di Architettura di Roma.
Chiamata alla cattedra di Storia dell’Arte e Storia e Stili dell’Architettura della Facoltà di Architettura di Roma
Prolusione, Aula Magna del Rettorato dell’Università di Roma, 18 dicembre 1963.
Figlio di un’antichissima comunità romana, una cui scuola del I secolo a.C. -«scuola», perché «scuole» si designano tuttora i nostri templi- sta risorgendo sul ciglio dell’autostrada per Fiumicino, è stato per me motivo di sincera e inattesa gioia esser chiamato alla cattedra di Storia dell’Architettura di Roma, dopo la lunga diaspora veneziana. Ed è motivo di commozione svolgere la lezione introduttiva in quest’aula adiacente alla Facoltà di Lettere e Filosofia dove, sull’altra sponda di Valle Giulia, un maestro indimenticabile, Lionello Venturi, mi chiamò, quindici anni or sono, a tenere il mio primo corso universitario nella Scuola di Perfezionamento in Storia dell’Arte. La gioia è però velata di un profondo rimpianto, proprio per la diaspora veneziana, vitale, lieta e corroborante, ove, raccolto attorno a un uomo di eccezionali virtù, un folto gruppo di profughi del movimento moderno, ostracizzati dalle Facoltà di Architettura delle loro città, ha sperimentato per oltre un decennio una didattica architettonica nuova, fondata su un clima di organica e antipaternalistica collaborazione tra docenti e studenti, l’unico clima che permetta una valida produzione di cultura e perciò avvii a una radicale riforma delle strutture universitarie.
Il bilancio degli anni di lavoro nell’officina di Venezia è schematicamente riassunto nel titolo di questa prolusione. Che non vuol essere una lezione accademicamente conchiusa, tale da riscuotere un generale consenso, ma al contrario una vera e propria prolusione, densa di interrogativi che non trovano ancora risposta, di problemi in sospeso, di ipotesi controverse e proposte polemiche. Un discorso meno elegante e austero di quanto si usi in queste occasioni, ma forse atto a stimolare un dibattito sull’impostazione stessa dell’intero insegnamento architettonico, su un orientamento didattico inedito nelle nostre Facoltà che certo implica qualificazioni, approfondimenti e specie verifiche nelle aule e sui tavoli da disegno.
La storia come metodologia del fare. Questo assunto, formulato sul piano teoretico, può sembrare largamente condiviso. Nessuno pensa più che, per formare prosatori o poeti, si debba insegnare il «bello scrivere» secondo le vecchie regole puriste della retorica, e non la storia della letteratura; o, per educare pittori e scultori, sia utile insegnare le categorie e i precetti della bellezza secondo le antiche estetiche normative e non la storia dell’arte; o ancora, che si possano allevare filosofi dispensando nozioni sugli schemi scolastici, e non rielaborando la storia del pensiero, la storia stessa della filosofia. Analogamente, nessuno può più credere che si possano formare architetti impartendo ricette compositive, cognizioni tecnologiche cosiddette obbiettive e istruzioni sul modo di disegnare. L’arte contemporanea ha, del resto, travolto grammatiche e sintassi e con esse l’intero bagaglio delle ideologie, dei parametri estetici assoluti, e delle relative strumentazioni per acquisirli.
A parole, siamo tutti d’accordo: l’insegnamento dell’architettura va storicizzato perché il metodo storico è il solo che ammetta un riscontro scientifico e, prima ancora, una comunicazione di esperienze.
Ma se è facile concordare su una formula generica è quanto mai arduo applicarla in concreto; tanto che nessuna scuola di architettura del mondo ci è ancora riuscita, neppure in grado approssimativo. Basti ricordare che in molte Facoltà europee ed americane si istituì la distinzione che ancora persiste tra corsi di «Storia dell’Architettura» e di «Teoria dell’Architettura»; e se in Italia ciò non accadde, non è già perché la storia avesse investito e saturato il campo della «teoria», ma proprio per la ragione inversa, perché la storia era rimasta una disciplina aristocratica, avulsa dagli impegni operativi, e la progettazione, se non si basava più su teorie pretestuosamente oggettive, si affidava però a teorie ancor più pericolose ed arbitrarie, e cioè alle incerte pseudo-teorie dei singoli docenti di composizione. Ne è conferma un fatto: questa situazione, culturalmente disintegrata che si protrae nel mondo da cinquant’anni determinando una crisi di fondo nelle scuole di architettura, esplode soltanto ora con virulenza in Italia: perché l’accademia si è prolungata da noi per decenni, sostenuta da quell’autarchica boria provinciale che ha escluso il paese, per quasi un secolo, dal corso creativo e civilmente impegnato della storia dell’architettura.
Com’è noto, la tensione tra una storiografia cieca e reazionaria e il movimento moderno sboccò in una clamorosa frattura nel programma didattico del Bauhaus. Poiché la storia era intesa come insegnamento astorico degli stili, inutile agli effetti della formazione dell’architetto, Walter Gropius coraggiosamente la espulse dal curriculum di Weimar e di Dessau.
Nelle altre scuole rimase, ma come disciplina largamente estrinseca; nozionale; informativa, nei casi migliori, magari anche formativa ma ai fini di una cultura generale, non nell’interesse specifico del fare la nuova architettura. Lo prova la circostanza che mentre, sia pur lentamente, gli architetti moderni conquistarono le cattedre di Composizione o di Design, quelle di Storia dell’Architettura restarono per lungo tempo monopolio di studiosi talvolta preparatissimi ma di regola disimpegnati rispetto ai temi della produzione contemporanea; tuttora le cattedre di storia affidate a docenti calati nell’attualità dell’architettura non superano, nel mondo, la dozzina.
Il problema, del resto, non può esaurirsi nel sostituire docenti misoneisti con studiosi consapevoli del fatto che ogni vera interpretazione del passato nasce ed è sollecitata da una partecipazione intima all’arte contemporanea. In tal caso, non occorreva coprire la cattedra di Storia dell’Architettura a Valle Giulia; bastava indurre gli studenti-architetti a seguire i corsi di storia dell’arte della Facoltà di Lettere e filosofia, svolti da un maestro, anzi da un protagonista del rinnovamento storiografico in materia d’arte ed anche di architettura. Il nodo del problema non è questo.
Un’analisi comparativa di numerose scuole di architettura europee ed americane offre il seguente risultato: quando la Storia dell’Architettura è insegnata da docenti moderni, appassionati, partecipi del fare contemporaneo, gli architetti che ne derivano sono più avvertiti, articolati e pensosi; quando si resta nel tipo di insegnamento accademico sono meno colti, più rudimentali. Ma, nell’un caso e nell’altro, la storia non incide, non serve o serve in modo indiretto, non si riflette in una metodologia della progettazione.
Come si vede, benché tutti concordino sull’esigenza di storicizzare l’insegnamento architettonico, sul terreno applicativo siamo all’anno zero.
È sciocco tentare di nasconderci lo stato di disintegrazione culturale in cui versiamo.
L’esito di un insegnamento non storicizzato se non a parole, e di un fare in conseguenza sganciata da ogni metodologia scientifica, è eloquentemente proiettato nello scenario delle nostre città e campagne. Non richiede commenti dacché urla la sua denuncia. Uno scenario infame di arbitrii senza costrutto, di intenzioni oscure e corrotte, di velleitarismi e di noia. Una scenario in cui cento e più anni di storia dell’architettura moderna, segnati da straordinarie personalità creatrici e da grandiose esperienze sociali, restano affatto estranei nei contenuti e nell’espressione, quasi che un’eruzione di ignoranza li abbia sommersi.
Anche sotto il profilo formale, che, del resto, sempre accusa errori di contenuto, si moltiplicano le sovrapposizioni di lessici diversi, di etimi contraddittori, in una folle ed insulsa commistione di linguaggi al cui confronto. L’eclettismo ottocentesco appare un gioco virtuoso di gentlemen dilettanti.
Qui siamo nell’informe, in una architettura senza fonti, senza riferimenti e senza metodi, forse l’architettura dell’affluent society, ma di un’affluent society non solo colma di insicurezze, ma pregna di viltà.
Di un panorama così squallido, a-sociale, incivile e perciò stesso antiestetico non possiamo obbiettivamente ascrivere l’intera colpa alle Facoltà di Architettura reazionarie. Almeno di concorso al reato va incriminato il movimento moderno, che giustamente ha minato le scuole di vecchio tipo, ma poi ha avuto il torto di non impegnarsi nell’impostazione di un nuovo tipo di scuola, e perciò di una moderna didattica.
Le attenuanti sono invero scarse. Perché i maestri dell’architettura moderna Wright, Le Corbusier, Gropius, Mies, Aalto – o credevano sinceramente in una metodologia architettonica a-storica, e quindi in un insegnamento non storicizzato, ed allora avevano il dovere di formulare una grammatica e una sintassi per l’architettura moderna, sostituendo ai precetti accademici nuove e più attuali dottrine, sull’esempio di quanto tentarono Schönberg, Brecht, Eliot e, a suo modo, van Doesburg; oppure credevano in una metodologia storica del fare architettonico, ivi compreso il loro fare, ed allora avevano il dovere di formulare questo nuovo metodo e, anziché espungere la storia dal Bauhaus o lasciarla in quarantena, dovevano farsi essi stessi storici, varcando gli apodittici enunciati funzionalisti, tecnicistici e formali, e strumentando una critica atta a penetrare nella realtà architettonica a tutti i livelli, dalla pianificazione del territorio alla modanatura e al segno più minuto dell’immagine.
Invece, come agirono questi maestri? Si disinteressarono del problema esclamando, come Le Corbusier, « Je m’en fiche! ». Oppure dalla scuola di tipo istituzionale tornarono alla scuola-bottega; scuola-studio, scuola-atelier, dominata non da un metodo, ma da una personalità che solo un’élite di studenti poteva seguire, e perciò stesso sorda alle istanze di un’educazione di massa. Per due decenni gli Stati Uniti hanno offerto una pluralità di scuole-studi di questo tipo perché numerose figure del movimento moderno erano compresenti in America ed impegnate nell’insegnamento. Chi ammirava Gropius, frequentava la Harvard University; chi preferiva Mies van der Rohe s’iscriveva all’Illinois Tech, per apprendere da Wright si andava a Taliesin. E, in fondo, tra scuole di antica tradizione come Harvard e come Taliesin non v’era differenza, quando in ambedue incideva un protagonista della nuova architettura su un limitatissimo numero di allievi.
In Europa, specie nei paesi ove il sistema universitario era più autoritario, rigido, paternalistico e anti-democratico, la frattura tra scuola e cultura, mediata benché non risolta negli Stati Uniti dalla presenza dei maestri, divenne un baratro. La vera cultura si espresse fuori delle scuole, attraverso un’autoeducazione antitetica a quella universitaria. L’incomunicabilità fu assoluta. Da un lato, la Facoltà di Architettura di Roma, che non si abbonava nemmeno alla rivista «Casabella Costruzioni», l’unico organo autentico del movimento moderno italiano; dall’altro, Terragni e Pagano, le più significative personalità di questo movimento, che non insegnarono mai nell’università.
Anche la generazione di mezzo, quella che oggi sta tra i 55 e i 65 anni, ereditò un atteggiamento di diffidenza verso la scuola. Non è un caso che gli Albini, i Belgiojoso, i Gardella, i Libera siano entrati nell’università solo dopo l’ultima guerra. Il motivo estrinseco, il pervicace ostracismo, non occorre ricordarlo. Ma vi è anche una ragione intima, più inafferrabile ma non meno importante: sono entrati nell’università quando hanno sentito che le certezze razionaliste del 1920-30, e cioè i principi fondati su una metodologia a-storica, venivano in loro stessi a crollare. La scuola diviene un tema bruciante per il movimento moderno e i suoi artefici nel momento in cui il razionalismo entra in crisi, e tale crisi attesta che della scuola è più facile dir male che fare a meno. Con questo, però, non abbiamo fatto nemmeno un passo avanti rispetto all’argomento di cui discutiamo. Abbiamo soltanto constatato che il problema esiste, che ha una sua remota origine e una complessa vicenda, che non ha ancora trovato una soluzione né in Italia né fuori; e che spetta a noi, nel prossimo futuro e cominciando oggi stesso, contribuire a risolverlo. Ma come?
Tre anni or sono, concludendo il saggio “Architectura in nuce” auspicavo che il processo di storicizzazione del movimento moderno, eluso dai maestri e dalla generazione di mezzo, potesse essere portato a fondo in una fase culturale in cui, dopo la lunga astenia storica, gli architetti, specie i più giovani, sentono l’urgenza di una metodologia scientifica, verificabile, del loro fare, consona ad una educazione di massa che rifiuti di degradarsi.
L’antica accademia consentiva all’allievo di scegliere tra lo «stile greco», lo «stile gotico», lo «stile barocco»;l’accademia moderna ci ha saputo insegnare, più o meno efficientemente, lo «stile razionalista», lo «stile organico», i modi compositivi puristi o neoplastici. Ebbene, se la nuova didattica sa passare dagli «stili» alla storia concreta e dinamicamente intesa, avvalendosi di una critica capace di recuperare l’intera prospettiva del passato in chiave ed in funzione dei compiti contemporanei, e se questa critica è condotta con criteri scientifici, e cioè è aperta, problematica, ricettiva di nuovi apporti ed anzi tale da stimolarli e nutrirli, lo studente-architetto sarà in grado di operare scelte circostanziate, continuamente alimentate ed incentivate da una ricerca operativa che tenga conto e rispetti anche le probabilità, le intenzionalità, il caso e l’azzardo, ma eviti gli sprechi, le evasioni, quella serie di piccoli errori, di sbagli meschini, di arbitrii inconsistenti che discende da un insegnamento agnostico e si riflette poi nel volto stolido delle nostre città. La scuola –dicevo- può almeno offrire, nel collegamento, anzi nella fusione tra corsi di storia e corsi di progettazione, un sostituto dell’esperienza che ogni giovane acquisterebbe se potesse frequentare gli studi dei maestri antichi e moderni per apprendere il metodo del loro fare. Se non riusciamo nemmeno a tanto, i corsi di storia e di composizione potranno essere brillantissimi, stimolanti, appassionati, ma il loro successo sarà affidato al fascino di una personalità o di un’altra, non ad una nuova metodologia controllabile e trasmissibile.
A me sembrava di aver indicato una strada utile, degna di essere sperimentata. La proposta non ha sollevato obbiezioni; tutti anzi hanno mostrato di apprezzarla ripetendo che l’insegnamento architettonico va storicizzato. Ma i più, dopo aver sottoscritto questa tesi, non ne tengono alcun conto e prolungano un insegnamento empirico, artigianale, talvolta mirabile nei suoi singoli capitoli, ma privo di ogni esplicita metodologia. Il distacco tra storia e composizione permane anche quando le discipline sono rinnovate, e i docenti, per preparazione e tendenza, sono affini: sembra impossibile far comprendere che il problema più scottante per le Facoltà di Architettura oggi non è tanto quello di svolgere delle buone lezioni di storia, o dei buoni corsi di progettazione architettonica ed urbanistica, quanto di individuare il nodo in cui la storia penetra, fonde nella composizione divenendone la componente metodologica.
Evidentemente, occorre che l’indicazione sia ampliata ed approfondita, e forse proprio l’esperienza dell’arte, dell’architettura di questi ultimi anni lo consente. Certo, l’argomento è complesso e dispersivo, ma tenterò almeno di sottoporre alla vostra attenzione tre punti che appaiono acquisibili:
1. è a tutti noto che il concetto dell’arte come mero raptus lirico, esente da ogni processo razionale, cosciente e verificabile è stato travolto con gli ultimi residui del romanticismo. Non occorre elaborare su questo, poiché in ogni ramo della moderna speculazione filosofica, dallo storicismo post-crociano alla fenomenologia, il momento artistico è stato liberato dagli inceppi della vecchia entificazione metafisica, e recuperato al campo della conoscenza intelligibile, cioè demitizzato. Questo sviluppo del pensiero filosofico sull’arte ha un enorme peso sui fondamenti stessi dell’architettura: demolisce il trinomio vitruviano, ed anche il binomio funzionalità-esteticità, nel formarsi del prodotto e del giudizio sul prodotto; riporta l’atto creativo o inventivo dal limbo dell’irrazionale e dell’inconscio, sul terreno responsabile delle scelte, in ogni fase della programmazione architettonica e urbanistica; rompe insomma l’antitesi e finanche la distinzione tra contenuti e forme individuando proprio nella invenzione dei contenuti, nell’interpretazione creativa dei programmi, il punto di applicazione specifico dell’intervento dell’architetto, e la matrice dei risultati artistici del suo lavoro;
2. l’attività figurativa non è diretta che in casi eccezionali alla creazione poetica. Di norma, è attività critica, commento più che invenzione. Il carattere critico della produzione artistica impegnata nella dinamica e nella trasformazione della realtà, già largamente intuito nel passato, fu confermato dal Ragghianti nel saggio sui Carracci, ed è stato ampiamente verificato da tutti i moderni storici d’arte. In sede filosofica, il Croce stesso, nella sua terza estetica, fu spinto ad integrare il concetto di poesia con quello di letteratura; ma le correnti fenomenologiche, marxiste e neorazionaliste hanno indagato a fondo la natura di questa attività critica dell’arte, sorrette e stimolate dalle ricerche semantiche e linguistiche. Di questa acquisizione però, di un’architettura critica, scientificamente controllabile, nelle nostre Facoltà si tiene tuttora pochissimo conto;
3. anche quando l’attività artistica risulta in una creazione poetica, compiendo uno scatto nella storia della cultura, tale creazione non è mai «pura», autonoma, disincagliata dalla sua storicità. È un salto che nasce da un lungo travaglio critico.
Alla distinzione crociana tra poesia e struttura in Dante, esaminato il canto di Farinata, Antonio Gramsci rispondeva: «Senza la struttura non ci sarebbe poesia e quindi anche la struttura ha valore di poesia».
In tale constatazione sta l’elemento emergente della ricerca storica e degli scavi linguistici di questi ultimi anni. Non c’è figura di poeta o di genio che sfugga ad una precisa determinazione storica se la critica è capace di penetrarla. Un processo di demistificazione è in atto, vince l’idolatria; illumina i modi espressivi degli artisti, compresi i più grandi. Persino Michelangiolo, che è apparso finora la personalità più avulsa dal contesto culturale e perciò meno storicizzabile, attraverso un’intelligenza matura può essere dimostrato fino ai più alti e singolari scarti della fantasia.
È insita, del resto, negli stessi artisti quest’urgenza di demitizzare la loro produzione. Scriveva Schönberg: «Il bisogno di un consapevole controllo dei nuovi mezzi e delle nuove forme sorgerà in ogni artista. Egli vorrà coscientemente conoscere le leggi e le regole che governano le forme da lui stesso concepite “come in sogno”. Per quanto grande sia la forza di persuasione di questo sogno, la certezza che quelle nuove sonorità sognate obbediscano alle leggi della natura e del nostro pensiero spinge il compositore sul sentiero della ricerca. Egli deve trovare, se non le leggi e le regole, almeno i mezzi capaci di giustificare il carattere dissonante di quelle armonie, e il loro succedersi». Ed aggiungeva: «Si dovrebbe poter insegnare l’arte di esprimersi con efficacia e chiaramente»; «Il vero genio creativo non ha mai difficoltà a controllare con la mente i suoi sentimenti».
Ebbene, se la moderna critica storica sa definire non solo le culture artistiche e i linguaggi, non solo le poetiche, ma lo stesso processo del fare artistico nelle sue pieghe formative più sottili ed individuate, se è capace non solo di partire dall’esito artistico per ricostruirne la formazione, ma anche di indicare o almeno di cogliere una formazione o da una cultura l’intero raggio delle sue virtualità, assumendo appunto i criteri della ricerca scientifica in una «rete di esplorazione» che lascia ampio margine alle probabilità, alle ipotesi, al caso e persino all’ignoto, l’alienazione è sconfitta: siamo alle soglie di una reintegrazione architettonica e quindi didattica: la storia può diventare realmente la metodologia operativa dell’architetto. Ma quale storia?
Il discorso, scaturito da un’analisi dello stato dell’insegnamento architettonico in generale, torna a questo punto alla disciplina storica. È evidente che in un indirizzo didattico così orientato, tutti i professori divengono docenti di storia. Ma proprio per questo occorre che la disciplina esca dal suo guscio nobile e paludato, s’immerga nella realtà del presente, sia estesa, approfondita, articolata e, in larga misura, strumentata in modo diverso.
Cominciamo proprio dalla strumentazione. Il travaso storia-design non è unidirezionale. Se la storia trova uno sbocco come componente metodologica della progettazione, a sua volta la progettazione prolunga nella storia i suoi criteri e i suoi strumenti; ciò che significa: propone un’operazione storico-critica di tipo nuovo, una storia dell’architettura redatta con gli strumenti espressivi dell’architetto e non più soltanto con quelli dello storico d’arte.
Sembra questo un fattore caratterizzante di una rinnovata storia dell’architettura. Da anni le nostre Facoltà sostengono che la storia per gli architetti va insegnata da architetti che vivano direttamente i fenomeni del fare architettonico, e sappiano quindi ricostruirli dall’interno del loro processo in ogni aspetto programmatico, funzionale, tecnico ed espressivo. La rivendicazione, parzialmente legittima ai tempi in cui la storia dell’arte usava interpretare l’architettura come mero fatto plastico, non è giustificata oggi che, almeno nei suoi migliori cultori, investiga gli organismi architettonici anche nei loro contenuti e nel loro contesto. Come, per seguire un corso qualificato di storia dell’arte, basterebbe che gli studenti-architetti venissero alla Facoltà di Lettere e Filosofia, così, per una critica dei loro lavori, basterebbe che un docente di storia dell’arte si recasse alla Facoltà di Architettura per discutere i progetti nel tempo della loro formazione ed anche allo stato della loro intenzionalità. La storia dell’architettura insegnata da architetti è valida solo nella misura in cui sappia estrinsecarsi, oltre che con gli strumenti verbali e scritti della storia dell’arte, in una critica operativa grafica e tridimensionale; nella misura cioè in cui induca a pensare architettonicamente. Il che non ha nulla in comune, sia ben chiaro, con la massa di inutili disegni riproduttivi che si esigevano nei vecchi corsi di Storia dell’Architettura. E ha ben poco a che vedere anche con quei tipi di disegni che schematizzano gli organismi architettonici, i loro impianti, le loro sequenze spaziali, i loro incastri volumetrici. Qui si tratta proprio dell’inverso, di esprimere un pensiero critico, di ricostruire il processo formativo di un’architettura con i mezzi dell’architettura, cioè di progettare una critica architettonica come si progetta un edificio.
È un’ipotesi di lavoro ancora largamente da esplorare. Ma gli esperimenti condotti a Venezia, e quelli paralleli di alcune scuole nord-americane attestano la sua concretezza. Occorre tuffarsi con fiducia in questo compito. Perché è evidente che la convergenza tra corsi di storia e corsi di composizione sarà enormemente favorita, e forse anzi assicurata da un’identità della strumentazione espressiva. Da un lato, progettazione di pensieri critici, riflessioni storiche architettonicamente espresse; dall’altro, progettazione architettonica e urbanistica, condotta scientificamente e cioè attraverso una metodologia fondata sulla critica storica.
In questa prospettiva, un adeguamento culturale dell’architettura, e quindi dell’insegnamento architettonico, è possibile; bisogna afferrarla subito, oggi, qui a Roma, nella fortunata occasione dell’integrazione del corpo docente non solo nei corsi di Storia, ma anche in quelli di Composizione e di Urbanistica, nelle temperie inquiete di un rinnovamento delle strutture universitarie promosso dagli studenti.
Una nuova strumentazione della critica architettonica è dunque essenziale, se si vuole che la storia divenga guida e metodologia del fare. Ma la strumentazione non basta. Occorre che la storia dell’architettura ampli l’orizzonte dei suoi interessi, sia estesa a comprendere: a) la storia dell’edilizia minore; b) la storia dell’urbanistica; c) la storia del paesaggio, cioè del territorio non edificato; d) la storia delle esperienze architettoniche extra-europee.
Su questi obiettivi è facile mettersi d’accordo, ma è quanto mai arduo conseguirli in modo organico.
L’edilizia minore è stata oggetto di innumeri contributi negli ultimi anni, ma solo ben pochi servono a democratizzare la storia dell’architettura. I più costituiscono il trasferimento in sede critica di una tendenza inconsistente del linguaggio, ispirata alla cosiddetta «edilizia spontanea» o indigena o dialettale, con cui si tentò di recuperare in ritardo e senza autentico impegno, l’esperienza realistica.
La storia dell’urbanistica, questo grandioso ponte tra storia economico-sociale e storia dell’arte, si è sviluppata notevolmente, ma non ha risolto alcuni problemi metodologici di fondo nell’interpretazione del processo formativo delle città; tanto che i criteri di giudizio rimangono assai incerti e la maggior parte delle storie dell’urbanistica risulta dalla giustapposizione di più storie estrinsecamente collegate.
Quanto alla storia del paesaggio, se non è intesa come storia della pittura di paesaggio, ma come esito di una simbiosi tra modificazioni agrarie e interventi architettonici, è ancora quasi interamente da elaborare specie per ciò che attiene all’Italia.
Le antiche culture orientali e centro-americane, infine, quando sono trattate, costituiscono un apporto prevalentemente nozionale, non riescono a rompere la barriera psicologica che chiude la storia nell’area europea, e perciò non giungono a suscitare una coscienza mondiale della vicenda architettonica.
L’estensione meccanica della disciplina è dunque agevole; non così l’organica compenetrazione degli argomenti. Allargando il campo dell’indagine, passando -come pur dobbiamo fare- dalla storia dei monumenti e delle personalità a quella degli ambienti, delle strutture urbane, dei territori e della loro programmazione economica e sociale, dai linguaggi europei o di matrice europea a quelli di tutte le civiltà umane, c’è il serio pericolo di restare sommersi da una serie di enciclopedie, peraltro superficiali e scarsamente utili. Si rischia di traslare al passato, ai vari livelli e aspetti storici, un atteggiamento.
agnostico, di mera registrazione, che è diffuso anche nei riguardi delle vicende architettoniche contemporanee: l’atteggiamento che tutto spiega e giustifica, che accetta tutti i fenomeni per buoni, rinunciando ad operare giudizi di valore, e, ciò che più importa, scelte. Una storia siffatta, per erudita che sia, è in realtà inconcludente e demagogica, può servire a camuffare l’empirismo e il vuoto metodologico dell’insegnamento architettonico, non a colmarlo; è una contraffazione di comodo della fenomenologia, non offre alcun indirizzo preciso, e tanto meno scientifico al fare contemporaneo.
Ecco perché, se la progettazione ha urgente bisogno della storia per forgiare una metodologia critica matura, la storia a sua volta esige l’illuminazione costante dell’arte nel suo farsi per scegliere e sviluppare le sue angolazioni interpretative. La dialettica è continua, l’incastro indissolubile in una prospettiva in cui l’obbiettivo di fare la storia s’identifica, negli strumenti e nei metodi, con quello di fare l’architettura.
Questa è l’ipotesi di lavoro per i prossimi anni; questa l’offerta, la proposta, la sfida che la Storia dell’Architettura pone ai corsi di Composizione e di Urbanistica, in effetti a tutti i corsi, compresi quelli attinenti alla tecnologia e alla scienza delle costruzioni. Qui sta la chiave della riforma didattica che dobbiamo operare se finalmente le Facoltà di Architettura devono cessare di essere un ibrido connubio tra scuole di disegno o di arti e mestieri, scuole di ingegneria e scuole di storia dell’arte; se vogliamo cioè che l’architetto cessi di essere una figura eclettica, un po’ artistoide, un po’ tecnico, un po’ uomo d’affari, un po’ politico, un po’ colto, insomma un po’ di tutto, quel po’ che serve a renderlo disponibile ad ogni pretesa della classe dominante, o della burocrazia dominante, comunque del potere e del privilegio.
Siamo giunti all’ultimo argomento di questo discorso. Abbiamo visto che il metodo della progettazione deve rinnovarsi, e non può farlo che attraverso la critica; e che, all’inverso, la storia va rinnovata nella sua strumentazione e nei suoi contenuti per diventare metodologia della progettazione.
Resta un ultimo problema, di ordine etico: perché si vuole questa reintegrazione culturale? Quale ne è lo scopo di fondo e il movente segreto? Che cosa c’è dietro questa tensione di rinnovamento così esplosiva nelle Facoltà di Architettura, questa volontà di conferire una dignità nuova alla figura dell’architetto, e di fare dell’architettura e dell’urbanistica non un’attività demiurgica, ma certo un’attività contestatrice delle attuali strutture e in parte profetica, come diceva Edoardo Persico, di una società più giusta?
In sede morale, le risposte possono essere molte. Io mi fermerò su una sola, e sarà tale da far inorridire i crociani della mia specie. Lo scopo sta nel ridurre e, al limite, nell’eliminare gli immensi sprechi di cui la storia è tremendamente carica. Lo scopo sta nell’opporsi alla dilapidazione di un patrimonio rivoluzionario che la pigrizia, l’alterigia, l’insofferenza mortificano e cancellano se non è difeso e rivitalizzato costantemente da una critica capace di ribatterlo sui tavoli da disegno.
Di queste dilapidazioni ogni epoca è pregna. Ne citerò due esempi emergenti, l’uno antico e l’altro moderno, a conclusione di questo discorso. Il primo riguarda Michelangiolo, il secondo Frank Lloyd Wright.
Nel 1529, nell’ora spiritualmente più tesa, struggente e creativa della sua vita, Michelangiolo traccia i piani per le fortificazioni di Firenze. Le concezioni spaziali, strutturali e paesaggistiche inverate nei fogli di Casa Buonarroti sono travolgenti, sconfinano oltre ogni esperienza del periodo barocco, oltre l’espressionismo, oltre l’informale.
Proteso nell’ideale della libertà repubblicana che assume nel suo animo le dimensioni di un mito laico, Michelangiolo si affranca da ogni commercio con la tradizione, recide ogni scambio coi lessici rinascimentali già posti in crisi, anzi in stato d’accusa, nella Laurenziana, e crea un linguaggio inedito anticipando una visione dell’architettura che, a quattro secoli dalla sua morte, non è ancora pienamente acquisita.
Le cavità che egli plasma nelle muraglie delle fortificazioni, e scava nei baluardi e nei puntoni, libere da ogni geometrismo, da ogni memoria sintattica e grammaticale, cariche di pressioni e di strappi dilatanti, ferite da asole di luce, sono quanto di più coraggioso abbia offerto la storia dell’architettura mondiale. I suoi moduli strutturali, nella materia corrosa fino agli estremi sforzi, nelle colate di forme spasmodicamente marcate, rispondono ad un’intuizione sbalorditiva delle moderne teorie dell’elasticità. E ancora il suo senso prodigioso della progettazione territoriale, degli spazi esterni alla città concepiti come forze che penetrano e determinano la forma delle masse, del paesaggio che aggredisce, s’avventa sulle mura, e che l’architettura elettrizza in un gesto poi ripercosso sui colli e in pianura, non trova paragoni nella storia posteriore, poiché anche il Vauban impallidisce al confronto in quanto razionalizza un processo che Michelangiolo aveva lasciato aperto, non-finito.
Ebbene, da anni, è per me motivo di perenne stupore e sgomento il fatto che di questi disegni, di questa straordinaria offerta culturale, la critica di Michelangiolo per quattro secoli non si sia nemmeno accorta.
È un fatto inverosimile, incredibile.
Il Condivi narra a lungo dell’azione di Michelangiolo in difesa di Firenze, ma non accenna agli schizzi delle fortificazioni. Il Vasari, che pur tanto si interessa di ingegneria militare, specie nella “Vita” del Sanmicheli, li ignora. Nessuna menzione nel dialoghi di Francisco de Hollanda, nelle cronache di Marcantonio del Cartolaio, di Giambattista Busini, di Benedetto Varchi, nella “Vita di Niccolò Capponi” di Bernardo Segni, nelle “Istorie della città di Firenze” di Iacopo Nardi, nelle “Istorie fiorentine” di Scipione Ammirato; insomma in tutta la letteratura del Cinquecento è come se questi progetti non fossero mai esistiti.
Il silenzio si perpetua, senza eccezioni, nei tre secoli successivi, benché il Bottari nel 1760 riportasse l’apprezzamento del Vauban per le fortificazioni buonarrotiane, e il Milizia, otto anni dopo, ne parafrasasse il brano. Bisogna arrivare al saggio del Riva Palazzi del 1875 per trovare un’indicazione di questi fogli, cui peraltro l’autore attribuisce un rilievo affatto secondario.
Tacciono gli specialisti di ingegneria militare: o li trascurano, come il Rocchi e il Borgatti, oppure li liquidano con poche osservazioni marginali.
La congiura include gli storici d’arte e i cultori di storia architettonica. Benché il Gotti nella “Vita di Michelangiolo” pubblicata nel 1875, avesse catalogato i fogli delle fortificazioni, il Geymüller li ignora nella monografia del 1904, e così Dagobert Frey nel volume del 1923, e così il Berenson in “The Drawings of the Florentine Painters”, e paradossalmente persino Karl Frey, nella raccolta dei disegni michelangioleschi. Si stenta veramente a crederlo: nel 1927, quando lo Steinmann e il Wittkower danno alle stampe la ponderosa bibliografia michelangiolesca, nessuno schizzo delle fortificazioni era mai stato pubblicato. Sembra che nessuno, dal 1529 al 1927, li abbia mai visti: se fossero stati trafugati e nascosti, o ascritti ad altri, la loro fortuna critica non sarebbe stata diversa poiché, per quattro secoli, nessuno ebbe occhio ed animo per riconoscerli e recuperarli al mondo dell’architettura.
Avvenne di peggio. Quando finalmente, nel settembre del 194O, Charles de Tolnay pubblicò diciotto disegni delle fortificazioni, l’impresa apparve rivelatrice; ma poiché questi progetti sconvolgevano l’interpretazione tradizionale dello sviluppo artistico di Michelangiolo, minando i pregiudizi circa il suo essere prevalentemente uno scultore e circa il suo giungere all’architettura solo a tarda età, accadde che, malgrado l’evidenza documentaria, vinsero i pregiudizi, tanto che negli stessi saggi del Tolnay ed anche nella recente monografia dell’Ackermann, l’esame dei disegni per le fortificazioni fiorentine rimane estrinseco, non opera quella radicale revisione della critica michelangiolesca che i documenti impongono.
L’interrogativo è invero allarmante: perché questo sperpero di un raggiungimento linguistico e poetico di tale, immensa, entità?
Michelangiolo stesso ne subì le conseguenze. Dopo l’assedio e il crollo della Repubblica, egli rientra nell’alveo del classicismo romano, torna a contestarne la grammatica e la sintassi proporzionale nel Campidoglio, a Palazzo Farnese, a San Pietro, nell’estremo furore di Porta Pia, e infine in quella apocalittica «rinuncia all’architettura» di Santa Maria degli Angeli, dove la poetica del non-finito fonde con quella delle rovine, cogliendo la virtualità di uno spazio quasi senza intervento.
Tutti sanno perché ciò avvenne: per la delusione e l’offesa, per l’involuzione culturale che sfociò nell’Inquisizione e nella censura.
Ci sono cento spiegazioni sociologiche, intellettuali, linguistiche, tutte plausibili. Ma non eliminano il sospetto che se la critica si fosse accorta di quella scoperta, e avesse confortato e sostenuto Michelangiolo, forse egli non avrebbe abbandonata la ricerca; che se, più tardi, la critica avesse riconosciuto e preservato questo linguaggio rivoluzionario, un enorme travaglio sarebbe stato risparmiato al mondo. Le forme aperte delle fortificazioni potevano forse evitare di essere corrotte e monopolizzate in chiave di persuasione barocca, oppure la proposta michelangiolesca, conculcata dall’Inquisizione ma mantenuta viva dalla critica almeno come ipotesi e come alternativa, poteva essere recuperata nel corso successivo della storia. Non so, nessuno può sapere, ma nessuno, credo, può idealisticamente acquietarsi di fronte a questo colossale esempio di spreco, di dissipazione, di viltà e di incoscienza critica, che consentì di svirilizzare e obliterare un linguaggio protestatario ed eversivo consegnandolo al potere.
L’umana vicenda in architettura brulica di valenze non utilizzate, di ipotesi lasciate in sospeso, di moti liberatori esplosi e subito dopo inibiti e soffocati. A un grado tale da indurre allo sconforto e all’esasperazione.
Non appena un poeta propone una nuova idea, la massa dei mediocri e dei pavidi s’affretta a corromperla. Triste e naturale.
Ma è qui che la critica storica deve intervenire, impedendo che un patrimonio rivoluzionario sia avvilito in una cronaca meschina e insignificante. La critica, se non vuol ridursi alla passiva registrazione di ogni esperienza, se non vuol rinunciare a promuovere, a costituire la metodologia del fare architettonico, se non vuol essere una critica conformista, che non sa mai dire no e quindi dice no solo di fronte alle cose serie, qui deve resistere e rilanciare.
Ebbene, io temo che anche oggi un grave pericolo soverchi l’architettura, ed è l’inclinazione a dissipare il patrimonio conquistato da un secolo di movimento moderno, e in specie da un genio di michelangiolesca statura, quello di Wright.
Il fenomeno presenta impressionanti analogie con quello del tardo Cinquecento ed invero assistiamo a un dilagare del manierismo. Mentre Le Corbusier si chiude in uno splendido ma incomunicabile monologo e Mies ripiega su impianti classicistici, e Gropius cede ai vernacoli e all’imperio del business, ed Aalto si appaga di variazioni neo-empiriche, l’architettura del mondo, da due decenni, in una follia di evasioni, di contorsioni e di arbitrii, dilapida le valenze rivoluzionarie dei maestri del razionalismo europeo e del genio di Wright.
Perdiamo tempo a dibattere la cronachetta di esperimenti graziosi, curiosi, interessanti come indizi psicologici o come aggettivazioni formali. Elogiamo il gusto di Louis Kahn, di Eero Saarinen; di Kenzo Tange, di Paul Rudolph, consideriamo grandi eventi la Torre Velasca, o la Rinascente in Piazza Fiume o la chiesa dell’autostrada del Sole; personalità e prodotti senza dubbio degni di citazione che però alienano le concezioni spaziali del movimento moderno ponendole a servizio della pubblicità e della speculazione fondiaria, invece di proiettarle su scala urbanistica e territoriale in funzione dei nuovi compiti sociali. Sia chiaro: la critica storica non può essere disponibile per questa operazione di spreco e di alienazione.
Forse l’epoca delle grandi personalità creatrici è superata, come molti asseriscono in base a non so quale certezza. Forse la produzione edilizia di massa e la ristrutturazione dei territori impongono non solo il lavoro in équipe nel senso interdisciplinare, ma proprio l’arte di gruppo. Se ciò è vero, la tesi qui sostenuta acquista di attualità, poiché è evidente che l’arte di gruppo nasce da un impegno critico più che creativo, e quindi esige un metodo scientifico, una critica coraggiosa ed aperta, capace di opporsi allo sfacelo dei valori del passato antico e recente, capace di iniettare nella produzione di massa le qualità che i grandi architetti hanno attinto nella produzione di élite, garantendo così un coerente travaso del linguaggio poetico nel linguaggio d’uso. Una critica insomma disposta a lottare contro la tendenza al consumo gratuito dei valori rivoluzionari.
Nel panorama di questi valori emerge sovrana l’architettura di Wright, frutto di una tenace, eroica ricerca che ha tradotto il vuoto come grandezza negativa, «materiale e cubica» per usare i termini del Riegl, in uno spazio di «grandezza infinita e priva di forma», ciò che significa in cavità elaborate per essere socialmente fruite, la cui formazione aperta nasce dai contenuti; una ricerca che, in nome di questo messaggio di libertà, anzi di liberazione, ha scarnificato la scatola muraria fino a renderla diaframma in un paesaggio continuo e umanizzato; e le strutture ha integrato in un’orchestrazione statica che si identifica con quella spaziale.
Per questo apporto, per questa idea, Wright, come Michelangiolo, fu perseguitato, offeso, deriso; espulso dal mondo ufficiale, dalle metropoli, dall’università, ridotto per un decennio alla fame. Per mezzo secolo fu ostracizzato dal capitalismo americano, ed ora il neocapitalismo tenta di cancellarne l’eredità.
Sarebbe invero un atto di autolesionismo, da parte di coloro che intendono costruire una società nuova, rinunciare all’uso, per questa società, di un linguaggio di tale portata. Nessuno storicista, nessun marxista serio può auspicare uno spreco del genere se già in tempi non di disgelo, ma anzi glaciali, Lukacs precisava che la sovrastruttura artistica non si limita a rispecchiare la realtà, ma assume posizione attiva pro o contro una determinata base. Anche ammettendo che tutta l’arte sia sovrastruttura, il linguaggio dell’architettura moderna è tanto attivo contro la base da poter esser conculcato dai poteri dittatoriali, paternalistici e neocapitalistici, ma non comprato al di là delle sue apparenze. Il fatto è che, dalle “Prairie Houses” dell’inizio del secolo alla “Miniatura”, dal capolavoro di Falling Water al Museo Guggenheim, dalle case modeste per il cittadino medio ai grattacieli alti un miglio, l’arte di Wright, in cinquecento e più edifici realizzati, ha forgiato uno strumento di tale forza liberatrice, di tale energia propulsiva che l’atto originariamente protestatario è sboccato in un’anticipazione concreta, verificabile, di un mondo nuovo, libero dai privilegi.
Per questa libertà dello spazio socialmente fruito lottarono tutti i grandi architetti della storia, contro il dispotismo, l’oligarchia, i principi, i vincoli dei materiali e delle strutture, la retorica degli stati teocratici e delle dittature moderne, la mediocrità burocratica e l’usura fondiaria. Per questa libertà degli spazi nelle case per tutti, nelle città programmate nell’interesse di tutti, su un suolo di tutti, dettero la vita, nei campi di concentramento e nella Resistenza, Giuseppe Pagano, Gian Luigi Banfi e, a soli ventiquattro anni, lo studente di architettura Giorgio Labò.
Già, nella storia dell’architettura moderna, il linguaggio è inscindibile dai contenuti rivoluzionari. Per questo, la critica ne rifiuta lo sperpero e ne promuove il rilancio.
È tutto. Sul terreno etico, la proposta che la nuova storia dell’architettura, intesa come metodologia del fare contemporaneo, esprime, può essere racchiusa in due parole: in luogo di un pessimismo rassegnato e di un’arte di consolazione, un’architettura impegnata, di un ottimismo ribelle.
Grazie.
Piano Regolatore di Roma.
Il Piano di Roma è approvato: inizia il sabotaggio
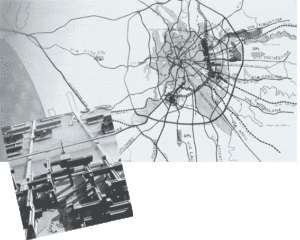 “L’architettura – cronache e storia” n. 90 anno 1963, “Editoriali in Breve”
“L’architettura – cronache e storia” n. 90 anno 1963, “Editoriali in Breve”
Qualche mese fa, apparve sui giornali la notizia che l’A.N.A.S. aveva accordato alla Società Autostrade Romane la concessione di un contributo per il primo tratto della Roma-Adriatica, cioè per il tronco che collegherà la capitale a Tivoli, Arsoli e Torano. Il tracciato di questo tronco, secondo il piano tecnico di massima che ha accompagnato la domanda della S.A.R., prevede l’attraversamento di Roma a raggera, con percorsi sopraelevati sugli impianti ferroviari e sulle zone verdi con diramazioni Termini-Tiburtina, Termini-Salaria, Termini-Ciampino e Termini-Tirreno. La gravità dell’iniziativa è evidente. Una serie di sopraelevate non previste dal Piano Regolatore ne mina la struttura; il piano di Roma poi è imperniato sulla costruzione di un grande «Asse Attrezzato» la cui realizzazione deve avere precedenza assoluta; proporre una rete. di sopraelevate significa sabotare l’Asse Attrezzato alla cui costruzione invece l’A.N.A.S. dovrebbe contribuire. Lo scandalo acquistò risonanza nazionale attraverso un articolo pubblicato su «L’Espresso». Ad esso seguì un’interrogazione parlamentare dell’on. Claudio Cianca, il quale chiese al Ministro dei Lavori Pubblici: a) se sia conforme alle regole, che dovrebbero guidare la pubblica amministrazione, la concessione di un contributo statale ad una società privata per la costruzione di un’opera della quale non vi è ancora un progetto preciso ed approvato; b) se la procedura anomala non stia a significare accettazione di fatto, da parte dell’A.N.A.S., del Piano presentato dalla S.A.R. e quindi .anche della sopraelevata urbana, per definire la quale si attende un deliberato di una commissione interministeriale appositamente costituita; c) se la commissione predetta può avere competenza in materia di Piano Regolatore di Roma e sovvertire ciò che è stato approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici e togliere valore di sostanza alla deliberazione del Consiglio Comunale, che dovrebbe pronunciarsi sulla opportunità o meno del cosiddetto «Asse Attrezzato» previsto dal Piano Regolatore della capitale, Asse Attrezzato che diverrebbe inutile o perderebbe il carattere di soluzione accentrata ed organica del traffico metropolitano, qualora dovesse realizzarsi l’autostrada interna al territorio comunale secondo il piano tecnico della S.A.R.; d) quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare per imporre il rispetto della legge e far fallire le manovre di quanti non hanno rinunciato a prendere iniziative per compromettere più di quanto non sia compromesso, l’assetto urbanistico della capitale». A questi circostanziati quesiti il Ministero dei Lavori Pubblici ha risposto in forma quanto mai evasiva ed equivoca. Ecco il testo della risposta: «L’autostrada abruzzese è stata compresa nel piano di quelle da realizzarsi con il contributo dello Stato ai termini dell’art. 2 della legge 24-7-1961, n. 729, ma il relativo progetto è ancora in fase di studio da parte della S.A.R. aspirante alla concessione della costruzione e dell’esercizio dell’autostrada in parola». Fin qui, la risposta è abbastanza chiara, benché non vi sia alcuna esplicita smentita -ciò che è sospetto- di quanto i giornali hanno pubblicato in base a fonti ufficiali. Ma il peggio viene ora: «Per quanto riguarda il tratto che interessa l’abitato di Roma, esso dovrà essere definito in armonia al Piano Regolatore di Roma e quindi col pieno assenso dell’Amministrazione Comunale della capitale». Che cosa significa questo discorso? L’Amministrazione Comunale ha approvato un Piano Regolatore che non include affatto questa rete di sopraelevate.
Come può dare il suo «pieno assenso» al progetto, «in armonia al Piano Regolatore»?
Il Ministero dei Lavori Pubblici deve attenersi alle leggi resistendo alle proposte di varianti dei piani urbanistici. In questo caso, invece, sta provocando il sabotaggio di un piano, salvo poi ottenere l’avallo formale di quella parte dell’Amministrazione Capitolina che mal digerisce il fatto che Roma abbia un assetto urbanistico decente.
-
Honorary Corresponding Member del Royal Institute of British Architects. Membro del Comitato Centrale della Gescal.
1964
Celebrazioni e mostra del quarto centenario della morte di Michelangiolo.
Mostra su Michelangiolo Architetto
Michelangelo in prosa
Presentazione della mostra
18 febbraio 1964. Cade quest’anno il quarto centenario della morte di Michelangiolo. Il presente fascicolo ne apre le celebrazioni. È giusto che l’iniziativa parta da un organo di architettura moderna: serve a convalidare il secondo tempo del moto di rinnovamento, quello impegnato nella storicizzazione del fare contemporaneo, in una critica attiva e promotrice che sa allargare i suoi orizzonti al passato, e brucia i residui estrinseci dell’avanguardia ma ne difende e stimola l’impulso.
Ragionare su Michelangiolo non significa concedersi ad un mero atto contemplativo, divagando rispetto ai problemi che questa rivista affronta ogni mese. All’inverso, offre un mezzo fecondo per riesaminare i temi più attuali e pregnanti da un osservatorio solo in apparenza distaccato. Spogli dell’aureola eroicizzante e delle retoriche fumosità sparse dalla letteratura encomiastica, i progetti e gli edifici di Michelangiolo pongono interrogativi urgenti agli architetti moderni, e perciò esigono una rilettura condotta in chiave della nostra sensibilità. Precisiamo gli obbiettivi: chi studia Michelangiolo è immediatamente incitato ad affrancarsi dai precetti accademici e dalle regole classicistiche, anche da quelle del XX secolo; di più, afferra o almeno intuisce che vi è un metodo per compiere l’operazione.
Basti accennare ad alcuni quesiti critici. Anzitutto, la poetica del non-finito, oggetto di molteplici interpretazioni nel campo della scultura, ma tuttora da indagare sul terreno della fenomenologia architettonica. Nessun edificio di Michelangiolo fu portato a termine: alla Laurenziana manca l’ambiente a pianta triangolare nel fondo della sala di lettura; il Palazzo Senatorio è privo del baldacchino che doveva raccogliere i vettori ascendenti dello scalone e, del resto, il disegno del Campidoglio venne sconvolto persino nelle uniformi cadenze dei volumi laterali e nelle loro testate; la mole dei Farnese restò senza fronte posteriore e, peggio, senza la prevista connessione all’altra sponda del Tevere. San Pietro, com’è noto, fu dilacerato dal prolungamento della navata che ne sovvertì l’impianto stereometrico anche in relazione al perno di San Giovanni dei Fiorentini; infine il Vanvitelli distrusse l’immagine di Santa Maria degli Angeli còlta e trascelta nella narrazione delle terme dioclezianee. Nessuno crede più che si tratti di accadimenti fortuiti; sono conseguenze di uno specifico atteggiamento creativo, di una poetica appunto il cui arcano movente è affatto sfuggito alla critica accademica, ma che noi oggi possiamo recuperare. Ostili all’opera chiusa, isolata dal contesto ambientale, immune alle trasformazioni del tempo, degli uomini e degli usi, ci rivolgiamo alla storia per individuarvi i riferimenti di un’intenzione vivida e calzante, ma ancora largamente inespressa. Ed ecco ergersi il non-finito michelangiolesco, il metodo di una “formazione” che rifiuta di serrarsi entro una “forma” oggettiva, e s’affida alla crescita organica, ad una legge di sviluppo aperto di cui ha fornito la matrice.
Come urbanista, Michelangiolo è quasi interamente da scoprire. Ma il suo processo di formazione della città può essere illuminante per noi. Non tracciò un Piano Regolatore, poiché era ribelle alle concezioni statiche sia dell’arte che della vita sociale. Agì per polarizzazioni architettoniche, fulcri di un sistema capace di espandersi poi spontaneamente: confermò il centro civico sul colle capitolino; quello residenziale attorno alla piazza Farnese; quello religioso a San Pietro. Rettificò la strada Pia costruendo una porta cardine dell’Asse che dal Campidoglio si prolunga nella Nomentana; ne dilatò l’incidenza in direzione di Santa Maria degli Angeli, e quindi della campagna, di Santa Maria Maggiore, dell’Esedra. La vocazione al non-finito valse a frenarlo dall’ambizione di ideare una forma urbana astratta, ma dalla basilica vaticana a Sant’Agnese fuori le Mura intervenne mediante una serie di grandiosi cantieri atti ad enucleare “emergenze” architettoniche destinate a guidare la crescita della città. È un criterio da meditare ed approfondire, da verificare anche in scala territoriale, specie in una fase dell’urbanistica moderna in cui si punta sui centri direzionali, sui nuclei e sulle aree di industrializzazione.
Anche confinando il discorso all’architettura nel senso restrittivo del termine, comprendere a fondo Michelangiolo appare oggi vitale. In primo luogo, perché in un’età manieristica quale attraversiamo il suo esempio è rivelatore: alla crisi del classicismo rinascimentale egli offrì una risposta anomala e discorde, eversiva e non solo elegantemente deformatrice. Scevra di compiacimenti virtuosistici e di metafisiche fughe, questa risposta aggredisce ogni canone proporzionale, comprime e dilata, comunque carica di energia esplosiva la materia spalancando l’involucro murario; soverchia e mina la “scatola” plastica finanche quando assume le dimensioni di una montagna, come nell’abside vaticana.
Il secondo motivo riveste un’importanza maggiore. Si suole ripetere che Michelangiolo è scultore anche quando architetta. È un luogo comune che non ha riscontro nei fatti, poiché il suo genio creativo culmina proprio nella formazione degli spazi e nel manipolare la luce che li invera. Del resto, si osservino i fogli delle fortificazioni fiorentine: neppure il più ardito artista barocco ha mai inventato simili cavità informali. Vincent Scully, nove anni fa, propose un raffronto tra Michelangiolo e Wright, ma in verità nemmeno il maestro di Taliesin ha concepito ambienti di tale libertà travolgente, paesaggi edilizi così inediti, strutture tanto scarnificate e protese. Non solo Le Corbusier, Gropius o Mies, ma anche l’espressionismo più spregiudicato ed eretico impallidisce al cospetto.
Questi rapidi cenni critici servano come invito a sfruttare le manifestazioni di quest’anno per rileggere, con occhio moderno, le opere di Michelangiolo. Il programma delle celebrazioni comprende libri, mostre, dibattiti, congressi, films. Per ciò che attiene all’architettura, è in corso di stampa presso l’editore Einaudi un grosso volume cui hanno contribuito Giulio Carlo Argan, Franco Barbieri, Aldo Bertini, Sergio Bettini, Renato Bonelli, Decio Gioseffi, Roberto Pane, Paolo Portoghesi, Lionello Puppi. È stato redatto dall’Istituto di Storia dell’Architettura di Venezia che lanciò per primo, sin dal lontano ottobre 1960, un appello diretto ad utilizzare la scadenza del ’64 come una grande occasione di cultura. L’Italia ufficiale, tronfia, accademica ed improvvisatrice, manca anche questa volta all’appuntamento culturale; ma il richiamo ha stimolato numerosi studiosi ed alcuni istituti universitari.
A Venezia gli studenti di architettura hanno lavorato per tre anni su Michelangiolo raccogliendo un ingente materiale documentario e critico che sarà esposto in una mostra e più tardi conservato ed arricchito in un museo a Querceta. In queste pagine s’illustra una piccola parte del loro lavoro, dando il maggior risalto alle fotografie riprese dai ponteggi costruiti per condurre i rilievi, ed ai modelli eseguiti con l’assistenza del pittore Mario Deluigi. Un esperimento didattico nuovo, questo ultimo, in cui la critica architettonica si esplica non in parole, ma nel linguaggio stesso degli architetti, nella realtà tridimensionale.
Questo fascicolo è dedicato agli studenti dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia non solo perché pubblica i loro modelli, ma perché è stato compilato nel momento in cui, chiamato all’Università di Roma, ho lasciato, con indicibile rimpianto, la cattedra di storia tenuta per quindici anni. Specie nel corso degli studi michelangioleschi abbiamo sperimentato una temperie scolastica che prefigura una riforma, nelle strutture e nel costume. Abbiamo mostrato che la riforma è concretamente possibile, e cioè che: 1) l’università è capace di produrre cultura, non solo di trasmetterla, ed anzi nell’impegno produttivo sta lo strumento idoneo per apprendere; 2) il coordinamento tra le discipline in cui oggi si smembra l’insegnamento architettonico è attuabile, a condizione che il metodo che lo ispira sia quello storico; 3) nell’officina universitaria così riformata scompare la distinzione tra docenti e studenti, che è ancora largamente intesa come distinzione di casta. Chini a decifrare i fogli di Casa Buonarroti, non c’erano professori né allievi: ricercavano insieme.

 English
English