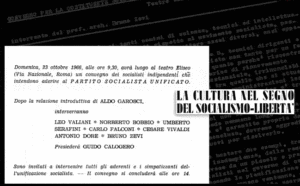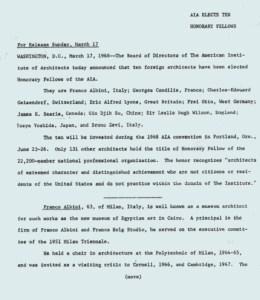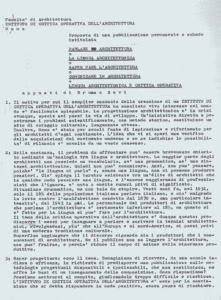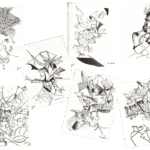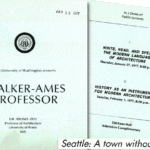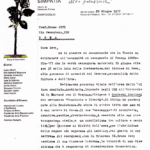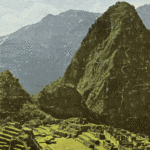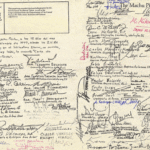Biografia: 1965-1977
1966
1967
Expo Universale di Montréal.
Padiglione italiano all’Expo Universale di Montréal nel 1967.
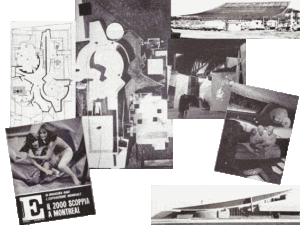 Con Giulio Carlo Argan, Michele Guido Franci, Vincenzo, Fausto e Lucio Passarelli, consulenti; Bruno Munari, Leonardo Ricci, Carlo Scarpa, Emilio Vedova, progettisti; Antonio Antonelli, Manfredo Greco, Franco Piro e Sara Rossi, per la progettazione esecutiva.
Con Giulio Carlo Argan, Michele Guido Franci, Vincenzo, Fausto e Lucio Passarelli, consulenti; Bruno Munari, Leonardo Ricci, Carlo Scarpa, Emilio Vedova, progettisti; Antonio Antonelli, Manfredo Greco, Franco Piro e Sara Rossi, per la progettazione esecutiva.
Come veicolare la realtà contraddittoria dell’Italia moderna? Polarizzandone i tre aspetti nella struttura del padiglione, e simbolizzandoli mediante opere d’arte fissate sul tetto-tenda, che la folla proveniente dalla metropoli vede dall’ alto.
Polo della poesia, affidato a Carlo Scarpa: vocazione lirica, modanatura personalizzata fino allo spasimo. E, sopra, la sfera corrosa di Arnaldo Pomodoro.
Polo del costume, linguaggio aggressivo, inquieto, neorealista o, meglio, neoespressionista, scavo manuale e gestualità materica, brutalista, remota da ogni geometria elementare, memore della tradizione artigiana: Leonardo Ricci e, sul tetto, una colata in ceramica di Leoncillo.
Polo dell’industrializzazione, design, grafica.
Dunque, Bruno Munari e all’esterno, sulla cresta della curva, una scultura metallica trasparente di Leonardo Carlucci.
Tensione tra i poli, spazio distrutto, fremente di luci e colori: il percorso drammatizzato dal pittore Emilio Vedova.
Presidente dell’International Technical Cooperation Centre (fino al 1970).
Studio “Asse” per le ricerche sull’Asse Attrezzato e il nuovo Sistema Direzionale di Roma, con Vinicio Delleani, Mario Fiorentino, Riccardo Morandi, Vincenzo, Fausto e Lucio Passarelli, Ludovico Quaroni.
Asse Attrezzato e nuovi centri direzionali di Roma
 Con Vinicio Delleani, Mario Fiorentino, Riccardo Morandi, Vincenzo, Fausto e Lucio Passarelli, Ludovico Quaroni.
Con Vinicio Delleani, Mario Fiorentino, Riccardo Morandi, Vincenzo, Fausto e Lucio Passarelli, Ludovico Quaroni.
Lavoro promozionale per salvare Roma dalla rovina, dimostrando la fattibilità di quanto previsto dal Piano Regolatore del 1962, tuttora additato a esempio nella cultura urbanistica internazionale.
Una capitale vertebrata da un sistema direzionale scorrevole e flessibile, culminante nei fulcri di Pietralata e Centocelle raccordati all’Eur e ai quartieri che recingono il centro storico.
Nella carenza di iniziative statali e comunali, si configura un coraggioso intervento metropolitano che, da un lato, preserva le zone antiche e, dall’altro, evita la devastazione del territorio.
Asse Attrezzato e poli direzionali per “Roma 1970”
“Avanti!”, 3 febbraio 1968
Il compagno Bruno Zevi pubblica sull’ultimo supplemento del settimanale “L’Espresso” un interessante articolo sulla situazione urbanistica romana, la sua storia recente e le sue prospettive in relazione anche alle celebrazioni ormai prossime per il centenario di Roma capitale. Dopo aver ricordato il compimento degli sventramenti dei “Borghi” e il forzato “pompaggio” in direzione dell’EUR, il compagno Zevi fa una rapida panoramica degli anni ruggenti della speculazione edilizia. Pubblichiamo di seguito alcuni brani della seconda parte dell’articolo in cui il compagno Zevi avanza alcune proposte (progetto dell’Asse Attrezzato e dei poli di Pietralata e di Centocelle) da realizzare in occasione di “Roma ‘70”: tali proposte ci trovano interamente consenzienti e ribadiscono quanto già prima auspicato da “Avanti!”
Il Piano Regolatore è ufficialmente adottato nel 1962: vittoria incontestabile della partecipazione socialista al Campidoglio. Del resto, il costume amministrativo cambia registro: gli scandali, i favoritismi, le costruzioni in deroga al regolamento edilizio, le lottizzazioni abusive si riducono sensibilmente. L’Assessorato al Patrimonio affronta il problema della 167 con larghezza di vedute, impegnando vastissime zone per i futuri quartieri economici e popolari. Benché la DC non ceda mai il controllo del Piano Regolatore, l’organismo malato di Roma, dopo quasi cento anni di ricadute, mostra un deciso miglioramento; comunque non si aggrava. Oggi, nel gennaio 1968, giace ibernato, in attesa di subire un’operazione che lo avii verso una guarigione almeno parziale. Senza un immediato intervento, però, sarà la paralisi.
Da cinque anni l’amministrazione ha assunto l’impegno di costituire un “Istituto Permanente per la Programmazione Urbanistica”, organo indispensabile per attuare il piano; ma la DC finora ha posto il veto, per potenziare il “Placido Martini”, i cui compiti non riguardano affatto la città. Ogni tanto, una bella dichiarazione della Giunta promette di rompere l’inerzia aggredendo il tema più importante, quello dell’Asse Attrezzato e dei centri direzionali. Poi non accade nulla. Ovviamente, l’iniziativa privata, non essendo convogliata nelle zone predisposte dal piano, non potendo costruire un solo edificio lungo l’Asse, preme per ottenere altri settori di espansione. Non solo: in mancanza di aree disponibili, il prezzo di quelle già destinate alla fabbricazione sale in misura esorbitante. È chiaro: dopo cinque anni dall’approvazione del Piano Regolatore, o lo si attua oppure lo sia annulla.
A Roma però si trova sempre un compromesso: invece di attuarlo o annullarlo, lo si corrompe. Si pensi ai nuovi centri di Pietralata e Centocelle, che il grande arco viario ad est dovrebbe congiungere all’EUR. Recentemente è stato bandito un concorso per il progetto di un ospedale a Pietralata e 25 ettari di Centocelle sono stati assegnati alla Facoltà di Ingegneria per la sua nuova sede. Cosa hanno a che vedere un ospedale e una Facoltà universitaria con i centri direzionali? E perché mai la Facoltà di Ingegneria deve situarsi fuori dalla seconda città universitaria, prevista a Tor Vergata? Senza un programma disegnato, plani-volumetrico, la stessa università è insidiata: i lettori già sanno che si tenta di mutilarne la superficie in omaggio a “vini tipici” inesistenti. Leggera ripresa nel 1962, andamento stazionario per un quinquennio, minaccia di cedimenti: tale è il referto urbanistico di Roma; un altro collasso sarebbe mortale.
Alla diagnosi, ancora per poco, può seguire una terapia. Verte su due iniziative:
a) l’Istituto di Pianificazione, una “authority” tecnicamente responsabile dello sviluppo metropolitano;
b) il progetto dell’Asse Attrezzato e dei poli di Pietralata e Centocelle. Per costituire l’Istituto, occorre volontà politica; la decisione spetta ai socialisti che lo hanno sempre propugnato pur senza riuscire a superare il veto D.C. Per l’Asse Attrezzato necessita forse anche un incentivo specifico. È offerto dalle celebrazioni di “Roma ‘70”.
Per il cinquantenario dell’Unità, nel 1911, l’Italietta modesta ed irrisa seppe incidere sull’organismo urbano, sistemò Valle Giulia e dette avvio ai quartieri Prati e Mazzini. Non vi è alcuna possibilità che l’Italia della prosperità e del benessere promuova un’impresa paragonabile. È troppo tardi; in due anni non si concreta qualcosa di valido. E tuttavia Roma potrebbe visualizzare il suo futuro progettando l’Asse Attrezzato ed iniziandone la realizzazione. Ecco un’idea: le celebrazioni si esplichino in un vasto cantiere, nella città qualitativamente nuova in corso di attuazione. E i visitatori siano chiamati a giudicare il plastico di Roma 2000 esposto sotto una tenda luminosa. Niente retorica, discorsi brevissimi, nessuna spesa inutile, bando alle parate; silenzio assoluto, per carità di patria, sulle nefandezze perpetrate negli ultimi cento anni.
Tale programma può essere concretato. Nella carenza di ogni intervento comunale, studiosi e professionisti, specie nell’ambito universitario, hanno elaborato ricerche, ipotesi di soluzioni, progetti di larga massima. Si tratta di coordinare gli apporti e di indire i concorsi. La stessa mostra delle proposte alternative costituirebbe un’attrattiva di “Roma ‘70”.
Siamo agli sgoccioli, ma l’amministrazione capitolina può ancora salvare la faccia, rilanciando il tema dello sviluppo urbano. È l’estrema prospettiva di una città il cui bilancio urbanistico conduce altrimenti alla disperazione.
Commemorazione di Paolo Rossi, studente architetto.
Commemorazione di Paolo Rossi studente-architetto
Aula Magna della Città Universitaria di Roma, 28 aprile 1967
 Si era iscritto alla Facoltà di Architettura per adempiere a una duplice vocazione: ricercava un’attività, un tipo d’impegno in cui il coraggio artistico potesse saldarsi al coraggio civile, e il fare incidesse immediatamente nella società contribuendo a trasformarla, prefigurandone il domani. Aveva capito sin da bambino, tramite l’esperienza dura e luminosa della Resistenza vissuta dai genitori, quanto diceva Elio Vittorini, cioè che nella dialettica densa di scarti e aritmie tra cultura e politica, v’è un momento in cui la cultura fonde con la politica, ed è il momento dei grandi eventi rivoluzionari. Dai genitori Enzo e Tina, pittori, aveva imparato a riconoscere sin da fanciullo, nella narrazione medioevale del tessuto urbano di Perugia, nei paesaggi dell’Umbria e nelle decantate versioni degli affreschi e delle pale gotiche e rinascimentali, lo scatto qualitativo che determina il trapasso tra realtà naturale e segno creativo. Ma aveva anche appreso che gli intellettuali e gli artisti non possono sottrarsi al compito di partecipare alle vicende, alle lotte, alle tragedie del mondo, senza devitalizzare il proprio apporto ed esaurirsi prematuramente. La storia come pensiero e come azione: egli sapeva che suo padre e sua madre, nell’ora epica della Resistenza, avevano abbandonato pennelli, tele e cavalletti, per gettarsi nella lotta partigiana e nella guerra di liberazione. Suo padre, fervente cattolico, si era trovato a fianco di innumeri amici laici in una stessa aspirazione di riscatto morale e civile, in quel grandioso moto popolare che associava uomini e donne di ogni ceto e provenienza in un uguale impeto di natura e carica religiosa. Lo sapeva Paolo: in quell’ora, Gramsci e Rosselli, Amendola, Gobetti, Matteotti e Donati, di là dalle ideologie e dai partiti, erano confluiti in un medesimo insegnamento, additando la tenacia di una stessa fede, la comune capacità di cosciente sacrificio.
Si era iscritto alla Facoltà di Architettura per adempiere a una duplice vocazione: ricercava un’attività, un tipo d’impegno in cui il coraggio artistico potesse saldarsi al coraggio civile, e il fare incidesse immediatamente nella società contribuendo a trasformarla, prefigurandone il domani. Aveva capito sin da bambino, tramite l’esperienza dura e luminosa della Resistenza vissuta dai genitori, quanto diceva Elio Vittorini, cioè che nella dialettica densa di scarti e aritmie tra cultura e politica, v’è un momento in cui la cultura fonde con la politica, ed è il momento dei grandi eventi rivoluzionari. Dai genitori Enzo e Tina, pittori, aveva imparato a riconoscere sin da fanciullo, nella narrazione medioevale del tessuto urbano di Perugia, nei paesaggi dell’Umbria e nelle decantate versioni degli affreschi e delle pale gotiche e rinascimentali, lo scatto qualitativo che determina il trapasso tra realtà naturale e segno creativo. Ma aveva anche appreso che gli intellettuali e gli artisti non possono sottrarsi al compito di partecipare alle vicende, alle lotte, alle tragedie del mondo, senza devitalizzare il proprio apporto ed esaurirsi prematuramente. La storia come pensiero e come azione: egli sapeva che suo padre e sua madre, nell’ora epica della Resistenza, avevano abbandonato pennelli, tele e cavalletti, per gettarsi nella lotta partigiana e nella guerra di liberazione. Suo padre, fervente cattolico, si era trovato a fianco di innumeri amici laici in una stessa aspirazione di riscatto morale e civile, in quel grandioso moto popolare che associava uomini e donne di ogni ceto e provenienza in un uguale impeto di natura e carica religiosa. Lo sapeva Paolo: in quell’ora, Gramsci e Rosselli, Amendola, Gobetti, Matteotti e Donati, di là dalle ideologie e dai partiti, erano confluiti in un medesimo insegnamento, additando la tenacia di una stessa fede, la comune capacità di cosciente sacrificio.
L’antifascismo liberale aveva porto la mano al marxismo e all’antifascismo cattolico, e da quell’incontro era emersa, confusa e contraddittoria, divisa tra slanci rinnovatori e obsolescenti strutture, la nuova Italia repubblicana.
Paolo era nato dopo tutto questo; apparteneva a una generazione intimamente perplessa. La tensione morale ch’egli assimilava nell’ambiente familiare trovava scarso riscontro in una società incline a dimenticare gli orrori della guerra, degli stermini di massa, delle camere a gas, pronta a evadere e dilazionare, anzi a dissipare l’eredità della Resistenza in una dolce vita priva di autentica felicità. Trasferire quell’antica tensione in termini di operosità quotidiana: questo era il problema dei giovani e Paolo voleva aggredirlo diventando architetto. Sognava di concorrere allo sviluppo di città e territori, comprendeva come un’umanità migliore presupponesse un diverso assetto urbanistico, ove le comunità non venissero più soffocate dal caos del traffico e dallo smog, ove la gente non vegetasse stipata nei dormitori costruiti dalla speculazione fondiaria, ove i bambini non fossero costretti a giocare per strada, e gli studenti a frequentare scuole sovraffollate, squallide, monumentali e assurde, didatticamente oppressive. Paolo giunse alla Facoltà di Architettura intellettualmente maturo e col suo straordinario fascino derivante da un fisico sportivo, esercitato all’alpinismo e allo scoutismo, da una mente sensibile alle più delicate pieghe dell’arte e ai più impegnati temi dell’urbanistica, da una fiducia nella vita e negli altri che lo aveva spinto a iscriversi alla Federazione Giovanile Socialista e ad accettare la candidatura nella lista dei Goliardi Autonomi. L’ultima fotografia di Paolo, prima di quel tragico 27 aprile, lo ritrae nel portico di San Giorgio al Velabro assieme a tre suoi colleghi, durante una sosta dal lavoro di rilievo di quel monumento. Lo si vede in un’espressione pensosa e, all’un tempo, venata di ironia: ha appena smesso di misurare quegli arcani spazi altomedievali, arrampicandosi spericolatamente sulle scale e lungo i cornicioni; ora scherza, pieno di vitalità e allegria. Le fotografie di Paolo successive a quella di San Giorgio al Velabro ci precipitano d’improvviso nei tafferugli del 27 aprile. Lasciamo così la sua immagine serena, i ricordi familiari, lo sport, la cultura, il movimento socialista e i Goliardi Autonomi, gli studi architettonici. Da vari mesi era allarmato per quanto avveniva nella nostra università. Assisteva a un inasprimento degli animi, e al dilagare della violenza. Constatava come tale situazione impedisse, sul terreno intellettuale, quel dialogo, quello scambio e confronto di idee dai quali soltanto può scaturire una cultura differenziata e feconda. Credeva nella non-violenza, sosteneva che bisognava evitare, certo fino al limite del possibile e non oltre, di scadere al livello degli avversari, puntava sulla possibilità di recuperarne almeno una parte inserendola in un circuito di cultura.
C’è una fotografia sintomatica tra le molte che lo ritraggono in mezzo agli scontri avvenuti davanti alla Facoltà di Lettere: Paolo è lì, al centro della mischia, trattiene un suo compagno che si sta lanciando contro uno studente dello schieramento opposto; è lì per frenare, per persuadere, per richiamare tutti alla ragione.
Il resto è cronaca, ormai documentata minuto per minuto. Viene colpito da un pugno estremamente violento che provoca un profondo ematoma al polmone sinistro con infiltrazione emorragica sottopleurica. Dice a tre suoi colleghi: sono stato colpito, non mi sento bene; ma pensa di farcela, di rimettersi in sesto e perciò, invece di recarsi a un pronto soccorso, si siede sul muricciolo della Facoltà di Lettere. Intanto, esce un gruppo di professori per protestare con la polizia che assiste senza intervenire adeguatamente alle aggressioni neofasciste. Paolo si alza in piedi, monta sul muretto con l’evidente intenzione di raggiungere gli amici impegnati nel concitato diverbio. In quel momento sviene, precipita in avanti, si schianta al suolo. Entriamo nel campo dell’imperscrutabile, e nessuno di noi intende forzare l’interpretazione dei fatti.
Nessuno di noi ha affermato che Paolo Rossi sia stato volontariamente ucciso: è stato percosso, ha resistito, come di regola accade, per una ventina di minuti; poi il colpo ricevuto gli ha fatto perdere i sensi, e non si è più ripreso, perché altrimenti, con la sua agilità sportiva, anche cadendo, avrebbe evitato di battere il capo. Paolo è morto a seguito di un trauma cranico-encefalico riportato nella caduta; la tragedia è inspiegabile senza tener conto di questa pesantissima componente di fatalità. Ma, proprio perché obiettivi nella ricostruzione dei fatti, ci siamo opposti, sdegnati e inorriditi, alle menzogne, alle insinuazioni, ai vergognosi, ignobili, turpi tentativi di far passare la sua morte come una disgrazia accidentale, avanzando prima la miserabile calunnia che fosse malato, e poi attribuendo l’ematoma toracico non al colpo infertogli, ma a un ferro o a un tubo, del tutto inesistenti, contro cui avrebbe urtato a terra, oppure a un’autolesione provocata da un arto. Gli atti dell’inchiesta giudiziaria e le relazioni medico-legali sono ancora coperti dal segreto istruttorio ma, dai medici dell’ospedale San Giovanni che lo assistettero nella camera di rianimazione ai numerosi esperti consultati, il verdetto è unanime: Paolo si trovava in perfette condizioni di salute; a terra non c’era nessun ferro e nessun tubo; se ci fosse stato, non avrebbe comunque potuto determinare un ematoma toracico di quel tipo. Sono state studiate tutte le ipotesi: che sia precipitato a testa in giù, oppure a piedi in giù, oppure di fianco con le più diverse inclinazioni; che il corpo, abbattendosi al suolo, sia rimbalzato nei più vari modi. Le perizie necroscopiche e medico-legali non devono escludere alcuna supposizione. Ma, dal momento che nessun ematoma polmonare così circoscritto e profondo può essere stato causato da un’autolesione, noi abbiamo il diritto di sollecitare la magistratura a concludere l’inchiesta sanzionando che si è trattato di omicidio preterintenzionale da parte di ignoti. I familiari di Paolo, i suoi compagni e maestri, l’università italiana chiedono un responso chiaro e ammonitore, tanto più giusto e necessario in quanto i genitori dichiararono, sin dal primo istante, di non volere vendette e condanne.
Che si trattasse di omicidio preterintenzionale fu subito intuito dagli studenti, dagli assistenti, dagli incaricati, dai professori di ruolo democratici di questo Ateneo. Il 28 aprile scattò il moto dell’occupazione.
Dal pontefice Paolo VI al presidente Saragat, dai membri del governo ai parlamentari e al Comune di Roma, dalle università italiane d’ogni regione alla stampa estera, tutti identificarono l’origine vera della morte di Paolo. Cinquantuno professori di ruolo rivolsero un appello al Presidente della Repubblica mettendo a disposizione le loro cattedre e i loro istituti, rifiutando di continuare l’insegnamento e la ricerca scientifica in un’atmosfera appestata dal teppismo tollerato e quindi indirettamente istigato dalle massime autorità accademiche. Il funerale fu un evento indimenticabile: migliaia e migliaia di persone accompagnarono le spoglie di Paolo in un lunghissimo giro attorno all’Ateneo; in testa al corteo, Pietro Nenni, che non era soltanto vice-presidente del Consiglio dei Ministri e leader di un grande partito popolare, ma anche un padre consapevole, per esperienza diretta, di cosa significhi perdere una figlia in un lager, nelle battaglie contro la bestialità dei fascisti. A sera, dopo l’interminabile, estenuante itinerario di quel pomeriggio torrido, Walter Binni pronunciò un discorso che merita di restare tra le più alte pagine della nostra letteratura civile. Pacato e tremendo, Binni parlava con quella serenità che discende dall’aver appena dominato una prorompente emozione: aveva conosciuto Paolo dalla nascita, era fraterno amico dei suoi genitori sin dagli anni vissuti a Perugia; ma in quel discorso seppe vincere l’angoscia che lo travolgeva, additò negli «straccioni della cultura» e nel neosquadrismo teppistico i responsabili diretti della morte di Paolo, parlò della distanza tuttora largamente esistente tra la Costituzione nata dalla Resistenza e la mentalità dei detentori di strumenti repressivi spesso nettamente contrari ai fini costituzionali, e tali perciò da incoraggiare e avallare arbitrii e sopraffazioni a danno dei democratici. E poi, nel silenzio drammatico di quell’immane assemblea, emise un giudizio «gravissimo e durissimo» sul rettore Ugo Papi: «un uomo – disse – di cui non intendo qui fare il nome, perché esso macchierebbe, con la sua vicinanza, quello del giovane morto per l’aggressione fascista»; un uomo di cui «non si sa se più condannare l’incoscienza e l’imprevidenza o la cosciente faziosità, l’assenza o la presenza negativa in queste tragiche giornate, quando egli, oltretutto, non ha neppure considerato doveroso venire di persona sul luogo della tragica vicenda, non ha ritenuto doveroso e umano prendere contatto diretto con i genitori di Paolo, recarsi dove un suo studente agonizzava e moriva, e viceversa si è preoccupato, con gesto inaudito nella storia dell’università italiana, di chiamar subito la polizia per invitarla a sgomberare con la forza la Facoltà di Lettere occupata pacificamente da studenti e docenti. E poi non si è vergognato di rilasciare a una stampa compiacente e interessata dichiarazioni patentemente false e insultanti per la memoria della vittima». Binni era mosso da una collera sacrosanta. Non attaccava un uomo, ma il sistema di conduzione universitaria autocratico e faraonico che questi rappresentava, e di cui anzi era divenuto personificazione e simbolo. «Quell’uomo è certamente, da un punto di vista morale e non solo morale, responsabile della morte di Paolo Rossi. Egli ne ha preparato la morte con infiniti atti di assenza e di presenza negativa, con l’incoraggiamento dato ai gruppi violenti e anticostituzionali, lasciandoli liberi di provocare e aggredire gli studenti democratici e inermi, di insultare docenti e uomini del più alto valore morale e intellettuale, tollerando e difendendo la presenza di scritte anticostituzionali in locali da lui controllati, rifiutando di prendere nella dovuta considerazione denunce precise degli organismi studenteschi democratici, proteste di illustri docenti, lasciate spesso villanamente senza risposta». Ho riguardato il testo del discorso di Binni, e più volte ho sentito l’impulso di limitarmi a rileggervelo, rinunciando a commemorare Paolo Rossi con altre parole.
Ma la drammatica giornata dei funerali non si concluse con l’orazione di Binni. Seguì una scena impressionante: mentre il chiarore del giorno si dileguava, mentre noi nell’aula dell’Istituto di Fisica tenevamo un convegno interFacoltà, mentre nei vari edifici universitari si perfezionava il meccanismo tecnico dell’occupazione, sul pronao del Rettorato un gruppo di studenti montava la guardia davanti alle decine e decine di corone disposte lungo le scalee e le pareti frontali. Quasi immobilizzati dall’angoscia, ma sicuri, impavidi, risoluti, quei giovani inveravano una determinazione nuova, sembravano incarnare l’autogoverno di un’università diversa, attestavano una svolta decisiva e irrinunciabile nella storia del nostro Ateneo.
Poi, in quella notte, presso tutte le Facoltà occupate si svolsero seminari e dibattiti, si riunirono comitati di studio, si elaborarono proposte di riforma e nuovi programmi: un lavoro protrattosi ininterrottamente nei giorni e nelle lunghe veglie. Si disse giustamente che era l’occupazione dei trenta e lode, dell’avanguardia della scienza e della cultura e, in effetti, si svolsero discussioni ad altissimo livello sulla riforma universitaria, vivificate dalle continue visite di ministri, sottosegretari, parlamentari, gruppi di professionisti, intellettuali, artisti, operai venuti a portare il segno della solidarietà del mondo del lavoro e della cultura extra-universitaria alla battaglia dell’Ateneo.
Nello stesso tempo, si era iniziata la raccolta di testimonianze sul teppismo e le violenze perpetrate da anni nella città universitaria, promossa e diretta da Ettore Biocca. Oltre cento dichiarazioni firmate sugli atti di oltraggio, vilipendio alle istituzioni, apologia del fascismo, minacce, intimidazioni, messe insieme in meno di una settimana, primo stralcio di un «libro bianco» sull’Università di Roma. Ebbene: occorre confessarlo. Benché ne avessimo sentore e ne conoscessimo qualche episodio, nessuno di noi sospettava che in un’università di un paese democratico potesse verificarsi una serie di illegalità, manifestazioni razzistiche, inni fascisti, volantini inneggianti al nazismo, soprusi di ogni genere, uso di armi contundenti, catene, martelli, bastoni, mazze, bottiglie riempite di terra e pezzi di vetro, aggressioni contro esponenti della Resistenza, studenti e studentesse democratici, allievi stranieri specie africani, tumulti, irruzioni nelle aule, oscenità, insulti e sputi. Le massime autorità accademiche conoscevano molte di queste cose, ripetutamente denunciate; ma si erano ben guardate dal renderle note, sia pure al corpo docente; le avevano, anziché represse, archiviate. Noi, leggendone le testimonianze presso l’Istituto di Biocca, ne ricevevamo come una zaffata di fango negli occhi. Io rimasi traumatizzato. Quella lettura provocava quasi una regressione psicologica: ricordai gli anni della guerra, quando si mormorava che gli ebrei convogliati nei campi di lavoro nazisti venivano sterminati, quando giungevano saltuarie e incerte notizie di eccidi in massa, quando si raccontava, vagamente, di camere a gas, di ciminiere che fumavano ininterrottamente, di un odore pestilenziale di cadaveri bruciati dilagante intorno ai campi per un raggio di chilometri. Nessuno allora ci aveva creduto, perché è inconcepibile l’assassinio di sei milioni di esseri umani, inverosimile; non ha riscontro nell’intera vicenda della storia, quindi nessuno può credere a orrori di tali dimensioni senza disperare della natura umana e del destino dell’uomo. Sono occorsi decine e decine di libri, migliaia di deposizioni, clamorosi processi, la scoperta di immani fosse di cadaveri, la pubblicazione dei documenti nazisti, fotografie a centinaia e riprese cinematografiche perché ci convincessimo che questo era vero, che non si trattava di cento persone, fatto già orrendo, né di mille, né di centomila, né di seicentomila, cifra già mostruosa, ma di dieci volte seicentomila, tre volte l’intera popolazione di Roma attuale. Ed è difficile, impossibile trasmetterne la nozione e la coscienza ai nostri figli e ai nostri allievi.
Ebbene, a cannocchiale rovesciato, in dimensioni microscopiche, inassimilabili a quelle ma non perciò meno allarmanti, il «libro bianco» di Biocca gettò luce su una condizione fino ad allora largamente ignorata, dimostrando come un gruppo sparuto di facinorosi criminali, composto anche da elementi estranei all’università, riuscisse a terrorizzare la vita dell’Ateneo. Fu la morte di Paolo Rossi a rivelare tutto questo, a determinare un’esplosiva riscossa delle forze democratiche, a svegliare il Parlamento e il governo, a imporre un radicale mutamento di costume nella direzione universitaria, malgrado il persistere di anacronistici e sordidi apparati.
Un anno è trascorso, e di quanto è avvenuto negli ultimi dodici mesi si possono dare valutazioni diverse. Certo, il processo di rinnovamento e democratizzazione delle strutture universitarie si sviluppa con snervante lentezza, mentre la riforma, attuata a pezzi e bocconi, a forza di tira e molla e di compromessi, rischia, se non di peggiorare la situazione, di burocratizzarla in un sistema non meno autoritario dell’attuale. C’è ancora molto, moltissimo da fare in un paese in cui, come è accaduto nell’agosto scorso, i giornali cosiddetti «indipendenti» pubblicano a lettere cubitali, in prima pagina, su titoli di quattro o cinque colonne, l’annuncio dell’archiviazione dell’istruttoria sulla morte di Paolo Rossi, vituperando i professori e gli studenti che occuparono l’università, accusandoli di sfruttare una tragedia per le loro «mene politiche» e quando viene la smentita ufficiale, e anzi l’istruttoria, secondo le nostre richieste, si trasforma in un procedimento formale, non pubblicano nemmeno la notizia, oppure la pubblicano non in prima pagina, riservata evidentemente ai falsi, ma in una pagina interna, in poche righe, con un titolo minuscolo, in modo che quasi nessuno la legga. Eppure Paolo Rossi non è morto invano. La svolta segnata dall’occupazione e il conseguente cambiamento del rettore non sono stati privi di effetti fondamentali e ormai irreversibili. Malgrado motivi di salute ne abbiano limitato l’attività, la presenza del nuovo rettore ha registrato un sostanziale mutamento di clima nell’Ateneo; le forze democratiche hanno trovato in lui un interlocutore schietto e liberale, con cui discutere e magari polemizzare, ma non un muro, un oppositore prevenuto, ipocrita e disonesto. L’inaugurazione dell’anno accademico ha visto il professore Gaetano De Martino commemorare con sincere e commosse parole Paolo Rossi; sono state abolite alcune manifestazioni in cui il teppismo trovava occasione di esprimersi; si è ottenuta, certo mediante una lotta tenace delle organizzazioni democratiche, la gestione diretta della mensa e della Casa dello Studente; si è ribadito il programma di convocare periodicamente il corpo accademico e le rappresentanze delle varie categorie universitarie, avviandosi così a un diverso metodo, a un costume antitetico a quello fin qui propugnato. Dobbiamo riconoscerlo: la chiusura dell’università in segno di lutto, e un’assemblea di questo genere in cui, nell’Aula Magna dell’Ateneo, si commemora Paolo Rossi ma insieme si celebra la Resistenza, presenti alcuni dei suoi massimi protagonisti, non erano nemmeno concepibili durante il vecchio rettorato rabbioso, mentre lo sono oggi perché alla pressione delle forze democratiche ha corrisposto una precisa presa di posizione del rettore. Forse non basta, tuttavia oggi ai genitori di Paolo dobbiamo dire: come voi volete, i colpevoli della sua morte resteranno «senza volto», nessuno sarà condannato; ma Paolo non ha speso invano la sua breve esistenza. Senza retorica, egli continua a vivere perché ha trasmesso in noi, giovani e maestri, qualcosa del suo vigore. Voi contate che il sacrificio di vostro figlio serva ai compagni della sua età e a noi delle generazioni più anziane; di questo oggi potete avere certezza. Gli studenti che montavano la guardia alle corone di Paolo, prefigurando l’immagine di un autogoverno universitario nella società di domani, non hanno smobilitato. E, quanto a noi docenti, possiamo ripetere quel che disse il rettore di un’altra università rivolgendosi ai suoi studenti che l’occupavano proprio a seguito della morte di Paolo: «Ogni dittatura fiorisce per l’opera di pochi e il cedimento di molti… La difesa della libertà necessita ogni giorno di esempio e di coerenza… Tutte le volte che noi maestri mancheremo su questa linea di libertà, richiamateci anche con estrema energia; sarà questo il miglior modo per ricordare e onorare degnamente lo studente Paolo Rossi».
E per finire: la morte di Paolo non ha soltanto risvegliato le coscienze assopite degli universitari democratici, ha anche prodotto un fenomeno circoscritto ma forse di maggior rilievo. Scuotendo alcuni giovani militanti delle organizzazioni di estrema destra e neofasciste, li ha come liberati da quel complesso di inferiorità che li induceva al teppismo, ha loro indicato un’alternativa d’azione. Ricordo, tra gli studenti occupanti, alcuni esponenti di quelle organizzazioni che avevano improvvisamente rotto con esse per passare sul fronte democratico. A un anno dalla morte di Paolo Rossi, nel nome della sua giovane esistenza stroncata, parta da qui un appello agli studenti che ancora si abbandonano alla violenza: il vero coraggio non sta nell’aggredire e nell’insultare, ma nel costruire giorno per giorno una comunità colta e libera, anzitutto nell’ambito degli atenei. Alla prassi dell’odio e della faziosità si contrapponga il messaggio della non-violenza e della cultura, e serva almeno a qualcuno per valicare il fossato che ci divide: da questa parte è il coraggio, la coraggiosa pazienza e, in ultima analisi, la felicità di creare, tra innumeri ostacoli e sofferenze, quel mondo nuovo della scuola per cui un loro compagno, a venti anni, ha perduto la vita.
1968
Il '68 alla Facoltà di Architettura.
Lettera al Rettore
“Avanti!”, 8 febbraio 1968
 Il compagno Bruno Zevi, ordinario di Storia dell’Architettura all’Universdità di Roma, ha indirizzato una lettera aperta al rettore per esprimergli, innanzi tutto, la sua più viva sorpresa in merito alla intransigente posizione assunta dal Senato Accademico sulla occupazione in corso di alcune Facoltà.
Il compagno Bruno Zevi, ordinario di Storia dell’Architettura all’Universdità di Roma, ha indirizzato una lettera aperta al rettore per esprimergli, innanzi tutto, la sua più viva sorpresa in merito alla intransigente posizione assunta dal Senato Accademico sulla occupazione in corso di alcune Facoltà.
Dopo aver suggerito di convocare al più presto l’intero corpo accademico, affinché la questione venga presa in esame con maggiore ampiezza di vedute e con maggiore serenità, il compagno Zevi –nella sua lettera- prosegue occupandosi, in particolare, della situazione esistente alla Facoltà di Architettura. Ecco i punti sui quali ha creduto opportuno mettere l’accento:
1) Malgrado i numerosi tentativi fatti negli scorsi anni da alcuni di noi, nulla è cambiato nella conduzione della Facoltà, degli Istituti e dei corsi. Tutto è rimasto come trent’anni or sono: il piano degli studi, il numero degli esami, le frequenze, la struttura. Quattro anni fa, presentammo un programma per la riforma del Biennio, concepito sulle linee rivendicate oggi dal movimento studentesco: fu respinto dal Senato Accademico e vanificato dal Ministero. Nulla, assolutamente nulla di sostanziale è mutato.
2) Il movimento studentesco è quindi perfettamente giustificato quando dichiara la sua sfiducia nelle trattative con i professori. Le forze tese al rinnovamento dell’università, studenti come docenti, sono state sempre mortificate dal Consiglio di Facoltà, dal Senato Accademico o dal Ministero. Io ammiro e condivido, egregio Rettore, il Suo proposito di aprire un colloquio attivo, da pari a pari, con gli studenti. E tuttavia dobbiamo riconoscere che, dopo tante esperienze fallimentari, la sfiducia degli studenti nella fecondità di tale colloquio è pienamente spiegabile. Sta a noi riconquistare la fiducia degli studenti.
3) L’arma dell’occupazione, legale o meno che sia, è la sola disponibile per il movimento studentesco. Anche sotto il profilo pratico perché, con i nostri assunti e anacronistici programmi di studio, con un carico di oltre 35 esami, col sadismo di molti cattedratici, gli studenti normalmente non hanno nemmeno la possibilità di riunirsi, di discutere, di conoscersi, di organizzarsi. La scuola così pianificata li opprime. L’occupazione, quindi, per illegale che possa essere formalmente, è legittima da un punto di vista morale, culturale e direi persino esistenziale. Se non comprendiamo questo, vuol dire che siamo proprio fuori gioco rispetto alle condizioni culturali attuali, e perciò siamo incompetenti per la funzione dell’insegnamento.
4) Il movimento studentesco, a me pare, si articola in due tendenze: la prima ha per slogans «contestazione globale», «potere agli studenti», e cioè ritiene che la creazione di un’università nuova, moderna, democratica esiga come premessa la paralisi di quella attuale, mediante l’occupazione permanente; la seconda, invece, mantiene ancora la speranza di poter rinnovare il sistema trasformandolo radicalmente dall’interno, anche con la collaborazione del corpo accademico o almeno di una sua parte. Mentre a Venezia e a Torino la prima tendenza prevale, mi pare che a Roma la seconda sia consistente ed abbia la possibilità di affermarsi. Ma la sua affermazione dipende da noi.
5) Non si tratta di aprire un colloquio, di istituire commissioni per la riforma, di iniziare trattative. Queste sono rivendicazioni antiche del movimento studentesco: respinte quando furono avanzate, non possono essere oggi riproposte con successo dai professori. Occorre uno scatto coraggioso: un periodo sperimentale durante il quale le Facoltà, con l’apporto di tutte le componenti universitarie, possano trasformare programmi, conduzione, struttura. Se vogliamo salvare la situazione, dobbiamo ottenere questo dal Ministero: piena liberà, per un periodo di due o tre anni, di riformare la scuola nei corsi, nel metodo, negli esami, nella struttura.
Nei suoi due ultimi punti sulla situazione ad Architettura, il compagno Zevi scrive infine. Primo: il Ministero, quasi sempre sordo alle proposte di rinnovamento avanzate dai professori, ogni tanto cade di fronte al movimento studentesco. Con tanti clamorosi precedenti, vi è motivo di ritenere che il Ministero sarebbe oggi pronto ad accettare due o tre anni di sperimentazione scientifica e didattica, se il rettore dell’Università di Roma, sostenuto dal Corpo accademico, se ne facesse propugnatore. Sono sinceramente convinto che non ci sia altro da fare: certo, potremmo reprimere l’occupazione, ma ne avremmo un’altra domani, e questa assurda lotta si radicalizzerebbe ancor più.
Secondo: è evidente che l’Università di Roma non significa «città universitaria» nel limite territoriale del termine. La polizia, perciò, deve seguire nelle sedi delle Facoltà decentrate di Architettura, Ingegneria, Magistero, ecc., le stesse direttive seguite nella città universitaria.
«È superfluo aggiungere –questa la conclusione della lettera del compagno Zevi al rettore- che, a giudizio mio e di molti colleghi non si deve, in alcun modo, far ricorso alla polizia per sgombrare le Facoltà occupate, anche se l’occupazione si protrarrà a lungo. Della Facoltà di Architettura ho notizie dirette: malgrado la permanenza, giorno e notte, di centinaia di studenti, la Facoltà non è mai stata così ordinata, pulita, culturalmente attiva com’è ora; si arriva al punto che gli studenti, prima di fare una telefonata, versano 45 lire per non gravare sulle finanze della Facoltà. Un intervento della polizia, in queste condizioni, alla luce di questo comportamento esemplare, non sarebbe soltanto controproducente, ma sostanzialmente ingiustificato e imperdonabile».
1970
-
Membro del World Committee for Jerusalem.
Pubblicazione del libro "Erich Mendelsohn opera completa".
1971
Pubblicazione di "Cronache di Architettura".
“Cronache di Architettura” volumi I-II-III
Laterza, Bari 1971
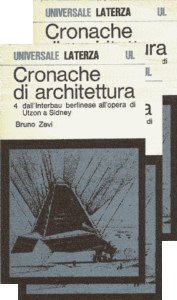 Le “Cronache” di Zevi, architettura settimanale
Le “Cronache” di Zevi, architettura settimanale
“Corriere della Sera”, 31 ottobre 1971, Franco Borsi
Si suole considerare che l’incidenza di libri costituiti da raccolte di articoli sia relativamente modesta anche quando il nome dell’autore gode di una certa fortuna e garantisce di per sé stesso l’aspetto diffusionale. Oppure quando la qualità stilistica, le preziosità da “elzeviro” sembrano garantire la resistenza al tempo al di là di quelle che si dicono le “occasioni militanti”. Un’autentica eccezione a questa regola è costituita dalle “Cronache di architettura” di Bruno Zevi di cui sono usciti nell’Universale Laterza i primi tre volumi (dalla scomparsa di Le Corbusier all’Habitat di Montréal, pp 692 lire 2300; dalla ricostruzione di Gerusalemme agli scioperi generali per la casa, pp 824 lire 2300; Indici pp 237 L. 1500) e la cui collana completa prevede altri cinque volumi a copertura del decennio ‘55-’65.
Già durante l’unica interruzione della rubrica di Zevi su “L’Espresso”, in coincidenza con la guerra di Israele, fu notato come si sentisse la mancanza di un autentico servizio documentario nel campo dell’architettura e dell’urbanistica che desse un quadro completo dei problemi del settore: da quelli della storia dell’architettura alla documentazione degli edifici più significativi sorti nel mondo ai problemi figurativi di arredamento e design alla battaglia per il verde, alla difesa ambientale e al restauro, ai rapporti su mostre, congressi e concorsi, a interventi più strettamente polemici ed occasionali di politica urbanistica, agli aspetti legislativi.
Uno stile incisivo
Se si considera che nel campo dell’editoria la diffusione di un migliaio di copie per libri di architettura ed urbanistica è già un successo, che la stampa quotidiana, salvo le polemiche locali o il filone della denuncia per le deturpazioni paesistiche o i centri urbani, non registra in modo sistematico -salvo rare eccezioni- una problematica di proposta e di intervento in questo campo, si può ben dire che la rubrica di Zevi sia stata la più solida testa di ponte della cultura architettonica sull’opinione pubblica. Ciò si deve alla continuità e alla completezza del panorama offerto; ma si deve anche al carattere stimolante, allo stile tagliente e incisivo, alla capacità di registrare e di prendere sul serio, salvo rare omissioni, anche eventi minori o pubblicazioni che vanno appena al di là della comune ricerca universitaria, ma che nel loro complesso assumono un preciso valore e danno l’idea di un importante contesto culturale.
Si potranno rilevare pezzi più o meno felici, si potrà consentire più o meno alle tesi specifiche, alle valutazioni critiche, ma ciò che rende indubbiamente preziosa questa raccolta di “Cronache di architettura” è appunto questa instancabile aggressività documentaria e presenza polemica.
In un momento in cui la tormentata crisi delle Facoltà di architettura e della stessa tavola di valori sulla quale si era pure faticosamente costruita ed affermata la figura dell’architetto nel mondo contemporaneo danno l’avvio ad una campagna di facile svalutazione e denigrazione, questo libro costituisce anche una opportuna efficace risposta.
A chi si domanda o meno chi è l’architetto oggi e che cosa fa, quali sono i suoi problemi specifici, consigliamo di sfogliare questi libri. Soprattutto gli Indici.
1973
Pubblicazione di "Il linguaggio moderno dell’architettura".
- Il linguaggio moderno dell’architettura
- Le sette invarianti dell’architettura applicate a Bruno Zevi da Jean Marc Schivo
“Il linguaggio moderno dell’architettura”
Guida al codice anticlassico
Einaudi, Torino 1973; ripubblicato in “Leggere, scrivere, parlare architettura”, Marsilio, Venezia 1997. Edizione inglese “The modern language of architecture” University of Washington Press, Seattle-London 1978; Van Nostrand Reinhold Company, New York-Cincinnati-Toronto-London-Melboume 1981; Da Capo Press, New York 1994. Edizione spagnola: “El lenguaje moderno da la arquitectura”, Editorial Poseidon, Barcelona 1978. Edizione francese: “Le langage moderne de l’architecture”, Dunod, Paris 1981. Edizione portoghese: “A Linguagem moderna da arquitectura” Publicações Dom Quixote, Lisboa 1984. Edizione ebraica: Massada, Tel Aviv 1984. Edizione greca: Atene 1985. Edizione cinese: 1992.
1976
Teleroma 56, la prima stazione televisiva indipendente che trasmette a Roma dal 29 luglio.
Quinto potere
 Una notte del giugno 1976, lo psicanalista Guglielmo Arcieri irruppe, raggiante: «Hanno liberalizzato l’etere! Vogliamo organizzare una stazione televisiva indipendente?». Risposta: senza aspettare un minuto; di questi tempi, occorre conquistare ogni centimetro quadrato di libertà.
Una notte del giugno 1976, lo psicanalista Guglielmo Arcieri irruppe, raggiante: «Hanno liberalizzato l’etere! Vogliamo organizzare una stazione televisiva indipendente?». Risposta: senza aspettare un minuto; di questi tempi, occorre conquistare ogni centimetro quadrato di libertà.
Il 29 luglio, la Teleroma 56 iniziava le trasmissioni, prima stazione indipendente della capitale. Letti due o tre saggi sulla «natura del messaggio televisivo» (durata massima dell’attenzione, 10 minuti; dinamizzare, rendere spettacolare persino uno sbadiglio ecc.), decidemmo per il contrario: commenti politici e programmi culturali di 60 minuti, talora di 90. Risultato: malgrado l’ibernazione RAI-TV, gli italiani non sono idioti, la cultura ha un mercato anche nei mezzi di comunicazione di massa.
Obiettivo: fare della Teleroma 56 il trampolino di lancio di un’Università dell’Aria. Per il semplice motivo che, se l’università è divenuta di massa, l’unico modo di risolverne la didattica è attraverso i massmedia. Lapalissiano, ma indigeribile per i baroni, i vice-baroni, gli aspiranti-baroni.
Sicché, per ora, il trampolino è lì, ma nessuno si tuffa. Non ha importanza. Se lo strumento è disponibile e aperto al dissenso, vale, comunque usato. Un orgasmo, SVP?
«Alto gradimento».
-
Relatore sull’architettura al Congresso per il bicentenario americano, promosso dalla Smithsonian Institution di Washington, D.C.
Commemorazione del 16 ottobre 1943.
Commemorazione del 16 ottobre 1943
 Nel 1976, poche settimane dopo la sua nomina a Sindaco di Roma, Giulio Carlo Argan espresse il desiderio che la ricorrenza del 16 ottobre 1943 – accerchiamento del ghetto da parte delle SS naziste e conseguente deportazione di 1.091 ebrei romani nei campi di sterminio – fosse celebrata, per la prima volta dopo la liberazione, in Campidoglio. Si stabilì di affidare il compito a due oratori, uno designato dal Comune, l’altro dalla Comunità Israelitica. Stranamente, ambedue gli enti indicarono lo stesso nome.
Nel 1976, poche settimane dopo la sua nomina a Sindaco di Roma, Giulio Carlo Argan espresse il desiderio che la ricorrenza del 16 ottobre 1943 – accerchiamento del ghetto da parte delle SS naziste e conseguente deportazione di 1.091 ebrei romani nei campi di sterminio – fosse celebrata, per la prima volta dopo la liberazione, in Campidoglio. Si stabilì di affidare il compito a due oratori, uno designato dal Comune, l’altro dalla Comunità Israelitica. Stranamente, ambedue gli enti indicarono lo stesso nome.
Impegno al presente
Il 7 marzo del ’44, quasi sei mesi dopo la data che commemoriamo e diciassette giorni prima dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, uno studente di architettura, Giorgio Labò, fu trucidato dalle SS tedesche al Forte Bravetta. Artificiere dei Gap, scoperto mentre, insieme al suo compagno Gianfranco Mattei, fabbricava esplosivi per la resistenza romana in un laboratorio improvvisato in via Giulia 43-A, era stato condotto nel carcere in via Tasso, cella n. 31 del quinto piano. Durante il tragitto, scorgendo casualmente per strada un amico, gli gridò: «Telefona ad Argan, perché avvisi i miei». Il padre, accorso da Genova, non riuscì a rivedere Giorgio, unico figlio. Consultò don Antonio Soranno, il cappellano che assisteva alle esecuzioni naziste; e questi tirò fuori dalla tasca un blocco di appunti dove era annotato quanto il giovane gli aveva detto prima di morire:
«Labò Giorgio di Mario
n. a Modena il 29 maggio 1919
studente di architettura
andare dal prof. Argan, via Giacinto Carini 66
Monteverde, filobus 129
pregarlo di informare la famiglia
che lui è passato con la massima serenità».
Prendo avvìo da questo episodio perché lega la lotta partigiana a quella dell’architettura e dell’arte moderna, la politica alla cultura in una convergenza che Elio Vittorini identificava solo nei periodi rivoluzionari. Il fatto che oggi la tragedia del 16 ottobre venga ricordata in Campidoglio, perché il Sindaco di Roma è la stessa persona cui Giorgio Labò chiedeva di comunicare la sua scomparsa ai genitori, dà la piena, emblematica misura dello scarto etico-qualitativo compiuto dall’amministrazione della città di cui gli ebrei sono i più antichi abitanti.
«Più volte io ho percorso il ghetto di Roma – scriveva Gregorovius nel 1853 – e la sua popolazione mi è parsa, tra le rovine della città, degna di osservazione, anzi l’unica rovina ancora vivente… Un popolo ebraico ancora vivo e non distrutto prega l’antico Iddio di Gerusalemme. Questo Dio era pertanto più potente del Giove capitolino».
La nostra è invero una comunità atipica, non «errante» come la maggioranza delle comunità israelitiche del mondo, ma radicata nei secoli, anzi nei millenni, in questi luoghi, in contesti sociali di cui ha costituito il barometro delle libertà civili. Minoranza religiosa tenacemente fedele alle tradizioni, ma sostanzialmente laica al confronto delle superstizioni idolatriche circostanti, gli ebrei, tra schiaccianti condizionamenti ed abissali miserie, hanno avuto e hanno un solo vantaggio: non occorre loro alcuna fatica per riconoscere il grado di intolleranza o di democrazia raggiunto nella città e nel paese, in quanto ogni posizione dogmatica, ogni ideologia totalitaria o totalizzante, sia essa pagana, cattolica, illuminista o materialista volgare li ferisce direttamente e tende ad annientarli. Non hanno scelte, né valide alternative, offrono un coagulo contro il quale infierisce automaticamente, e senza possibilità di scampo, qualsiasi moto reazionario e liberticida, un microcosmo che anticipa, nei suoi disagi e nel suo dolore, le lacerazioni e le sofferenze dell’intera collettività. Pagano per primi: i 1.259 ebrei romani deportati il 16 ottobre -363 uomini e 896 donne e bambini, di cui tornano solo 14 uomini e una donna- annunciano la temperie criminale dell’occupazione nazista. Sei milioni di martiri nei campi di sterminio miniaturizzano, sebbene in proporzione abnorme macroscopica, le decine di milioni di morti della seconda guerra mondiale, non meno che i 73 ebrei sui 335 assassinati alle Fosse Ardeatine.
Io non rievocherò gli eventi spettrali del settembre-ottobre 1943, poiché sono documentati in saggi e libri esaurienti. L’estorsione di 50 chilogrammi di oro, il 26-28 settembre; l’invasione degli uffici della Comunità, l’asportazione dei registri, del materiale d’archivio e di oltre due milioni di lire, il giorno seguente; il saccheggio della biblioteca e di quella del collegio rabbinico, perpetrato dal 30 settembre in poi; ed infine, la razzia atroce, l’accerchiamento del ghetto alle 5 del mattino ad opera di reparti speciali della polizia tedesca espressamente inviati da Berlino, gli sgherri sguinzagliati nelle case del quartiere per strapparne a forza gli abitanti, mentre altri militi hitleriani catturano gli ebrei residenti anche in zone remote dal Portico d’Ottavia, le scene di strazio, di brutalità, di infame violenza che si moltiplicano con sconvolgente crescendo nei mesi dell’occupazione, durante i quali i deportati salgono a 2.091. Questi ed altri dati sono fissati in pagine di numerose pubblicazioni, che si rileggono ogni volta con sbigottimento c raccapriccio, perché narrano con nomi, cognomi, indirizzi, minuto per minuto, una vicenda delittuosa che va oltre il limite della credibilità e dell’immaginazione. L’incubo del 16 ottobre e delle Fosse Ardeatine vince la dimensione del tempo.
Anche a distanza di trentatré anni, ognuno di noi s’identifica con gli scomparsi, stupito ed attonito che una sorte inspiegabile l’abbia separato dal destino dei suoi fratelli. Almeno per quanto riguarda la mia generazione, quella di Giorgio Labò, siamo e ci sentiamo fortuiti sopravvissuti, e questo ci induce a vivere nel disperato, quasi colpevole, tentativo di sostituire, col nostro impegno, qualcuna di quelle vite perdute.
Il tempo, semmai, gioca proprio in senso contrario a quanto si potrebbe prevedere: rende quei ricordi sempre meno credibili, tanto da esigere un’integrazione fantastica, poeticamente evasiva. Sarebbe interessante constatarlo esaminando l’intensità di coinvolgimento, di adesione alla cronaca, degli scrittori che hanno ricostruito la giornata del 16 ottobre. Mi limiterò a citare due esempi ben noti, che rappresentano forse i poli estremi del diorama ottico e rievocativo. Il primo, ovviamente, riguarda Giacomo Debenedetti, finissimo critico letterario di cui, troppo tardi, viene oggi riconosciuta la statura anche in quegli ambienti accademici che ne ostacolarono con protervia l’affermazione. Debenedetti registra:«Lungo i marciapiedi, i tedeschi: a occhio e croce, forse un centinaio. Nel mezzo della via stavano gli ufficiali, che disposero sentinelle armate a tutti i canti della strada…Le file vengono sospinte verso la goffa palazzina delle antichità e belle arti, che sorge al gomito del Portico d’Ottavia di fronte alla via Catalana, tra la Chiesa di Sant’Angelo e il Teatro di Marcello. Ai piedi della palazzina si stende una breve area di scavi, ingombra di ruderi, qualche metro più bassa della strada. Entro questa fossa venivano raccolti gli ebrei, e messi in riga ad aspettare tre o quattro camion, che facevano la spola tra il ghetto e il luogo dove era stabilita la prima tappa… dei camion veniva abbassata la sponda destra e si cominciava a fare il carico. I malati, gli impediti, i restii erano stimolati con insulti, urlacci e spintoni, percossi con i calci dei fucili. Un paralitico con la sua sedia venne letteralmente scaraventato sul camion, come un mobile fuori uso su un furgone da trasloco. Quanto ai bambini, strappati dalle braccia delle madri, subivano il trattamento dei pacchi, quando negli uffici postali si prepara il furgoncino. E i camion ripartivano, né si sapeva per dove; ma quel loro periodico tornare, sempre gli stessi, faceva supporre che non si trattasse di un luogo troppo lontano. E questo nei “razziati” poté forse accendere una specie di speranza. Non ci mandano via da Roma, ci terranno qui a lavorare…La razzia si protrasse fino verso le 13. Quando fu la fine, per le vie del ghetto non si vedeva più anima, vi regnava la desolazione della Gerusalemme di Geremia…Verso l’alba del lunedì, i razziati furono condotti alla stazione di Roma Tiburtino, dove li stivarono su carri bestiame, che per tutta la mattina rimasero su un binario morto… Il treno si mosse alle 14. Una giovane che veniva da Milano per raggiungere i suoi parenti a Roma racconta che a fara Sabina (ma più probabilmente a Orte) incrociò il “treno piombato” da cui uscivano voci di purgatorio. Di là dalla grata di uno di quei carri, le parve di riconoscere il viso di una bambina sua parente. Tentò di chiamarla, ma un altro viso si avvicinò alla grata, e le accennò di tacere. Questo invito al silenzio, a non tentare più di rimetterli nel consorzio umano è l’ultima parola, l’ultimo segno di vita che ci sia giunto da loro».
Per un temperamento delicatissimo, proustiano, sensibile fino allo spasimo alle cadenze e ai suoni verbali, come Giacomo Debenedetti, scrivere frasi e pagine così scabre, quasi neorealistiche, dovette implicare uno sforzo immenso, una violenza inibitoria su sé stesso. Ma non esisteva altra via narrativa all’indomani di quella giornata tremenda. Dopo Auschwitz non c’è più posto per la poesia, diceva Brecht, e Debebedetti sembrava riecheggiare la tesi: dopo il 16 ottobre non c’è più posto per la letteratura. Non c’è neppure il tempo di conferire alla cronaca uno spessore storico, e francamente ripugna ipotizzare la lettura attraverso filtri estetizzanti.
A distanza di qualche decennio, il 16 ottobre diviene, ne “La storia” di Elsa Morante, macabra fiaba, irrealtà dissennata. Ida, la protagonista del romanzo, apprende che «del quartiere del ghetto, svuotato interamente di tutta la carne giudia, non c’era restato altro che lo scheletro». È terrorizzata, ma «le sue paure contraddittorie rincorrevano alla fine una cometa misteriosa, che la invitava in direzione dei giudii: promettendole, laggiù in fondo, una stalla materna, calda di respiri animali e di grandi occhi non giudicanti, solo pietosi. Perfino questi poveri giudii di tutta Roma, caricati sui camion dai tedeschi, stanotte la salutavano come dei beati che, all’insaputa degli stessi tedeschi, si avviavano, per una splendida turlupinatura, verso un regno orientale dove tutti sono bambini, senza coscienza né memoria…». Poi, come ricorderete, la folle scorribanda fino alla Stazione Tiburtina, inseguendo la signora Di Segni, «moglie di un certo Settimio», che non risponde ai suoi appelli, anzi «la guarda con l’occhio ostile e torvo di un’alienata che rifiuti ogni rapporto con la gente normale», chiusa com’è «nella sua solitudine grande e furiosa d’intoccabile, che non aspetta aiuto da nessuno». Un vocio misterioso, perché ne è invisibile la causa,«richiamava insieme certi clamori degli asili, dei lazzaretti e dei reclusori; però tutti rimescolati alla rinfusa, come frantumi buttati dentro la stessa macchina». Nella Morante ogni avvio descrittivo sconfina nel surrealismo, nella pazzia onirica. «L’interno dei carri, scottati dal sole ancora estivo, rintronava sempre di quel vocio incessante. Nel suo disordine, s’accalcavano dei vagiti, degli alterchi, delle salmodie da processione, dei parlottii senza senso, delle voci senili che chiamavano la madre, delle altre che conversavano appartate, quasi cerimoniose, e delle altre che perfino ridacchiavano. E a tratti su tutto questo si levavano dei gridi sterili agghiaccianti…». Ida tuttavia evade, non riesce a sostenere la vista di una realtà così inaudita da sembrare inventata. Infatti «tutto questo misero vocio dei carri la adescava con una dolcezza struggente, per una memoria continua che non le tornava dai tempi, ma da un altro canale: di là stesso dove la ninnavano le canzoncine calabresi di suo padre, o la poesia anonima della notte avanti… Era un punto di riposo che la tirava in basso, nella tana promiscua di un’unica famiglia sterminata». Ida assiste all’episodio culminante, al tentativo forsennato della signora Di Segni di salire sul treno, sente i suoi urli «Apritemi! Nun ce sta gnisuno, qua? Io so’ giudia! Devo partì pur’io! Fascisti! Fascisti! Aprite!». Ma presto è distratta da Useppe e, del resto, dopo pochi giorni, nella stanzona di Pietralata, «degli ebrei, e della loro sorte, già non si parlava più».
C ‘è dunque un evidente distacco tra l’ottica di Giacomo Debenedetti e quella di Elsa Morante, e non si giustifica col semplice fatto che Debenedetti era un critico. Dopo trent’anni, il ricordo del 16 ottobre ha bisogno di essere esorcizzato in un processo di graduale sublimazione. Questo, sul terreno letterario. E in quello politico e culturale? Ecco: dopo trentadue cerimonie, quando, per volontà del nuovo Sindaco di Roma, la deportazione e il massacro degli ebrei romani vengono rievocati in Campidoglio, quasi per siglare il giuramento che la data del 16 ottobre non sarà mai dimenticata nella storia di questa città, io credo che commemorare non basti più. Occorre che questi cumuli di cadaveri ci spingano ad agire, anche controcorrente, anche sfidando l’impopolarità, i motivi di attrito, anche al rischio di essere tacciati di inserire argomenti inopportuni, «stonati», in una riunione solenne che potrebbe concludersi a questo punto, tra la commozione generale, senza sollevare problemi controversi e inquietanti. Ma sembra necessario accennarne perché il 16 ottobre è e, allo stesso tempo, non è una data isolata, eccezionale, avulsa dal contesto e quindi degna di un rituale sincero e tuttavia infecondo in termini di azione. politica e culturale. Riassume e simbolizza un’antichissima storia, romana e mondiale, tutt’altro che conclusa trentatré anni fa: quella dell’antisemitismo nelle sue plurime versioni e mascherature. È evidente che aggredire il tema dell’antisemitismo, hic et nunc, a Roma e in Italia, risulta spiacevole e mortificante più per chi parla che per chi ascolta. Ma i morti ci costringono a trattarne, in tre angolazioni suscettibili di polemiche e dissensi, che attengono:
1) allo Stato d’Israele, alla sua politica, in generale al sionismo;
2) al Concordato e ai Patti Lateranensi, cioè alla posizione della Chiesa dopo il Concilio Vaticano;
3) all’urgenza di una revisione delle tesi marxiste sulla questione ebraica.
Il taglio con cui cercherò di analizzare questi argomenti concerne solo indirettamente la difesa e l’incolumità della minoranza ebraica romana. Riguarda soprattutto l’antisemitismo come sintomo, come infallibile sismografo della società civile. Io sono ebreo, sionista convinto ed uomo della sinistra; ma i tre problemi che qui propongo esorbitano da queste connotazioni, ci interessano come cittadini di Roma e del mondo. Jean Paul Sartre chiude il magistrale saggio «L’antisemitismo» affermando: «Bisognerà dimostrare a ciascuno che il destino degli ebrei è il suo destino, non ci sarà un francese libero, finché gli ebrei non godranno la pienezza dei loro diritti; non un francese vivrà in sicurezza, finché un ebreo in Francia e nel mondo intero potrà temere per la propria esistenza». Theodor Adorno è ancora più esplicito: «L’antisemitismo è uno schema rigido, anzi un rituale della civiltà, e i pogrom sono i veri assassinii rituali. Essi provano l’impotenza di ciò che potrebbe frenarli, della riflessione, del significato, e infine della verità… solo nella liberazione del pensiero dal dominio, nell’abolizione della violenza, potrebbe compiersi l’idea che è rimasta, finora, non vera: essere l’ebreo un uomo. Sarebbe il passo dalla società antisemita, che spinge l’ebreo come gli altri nella malattia, alla società umana. Superata la malattia dello spirito che alligna sul terreno dell’autoaffermazione intocca dalla riflessione, l’umanità diverrebbe, dall’universale “altra razza”, finalmente il genere che, come natura è tuttavia più che mera natura, poiché prende coscienza della propria immagine. L’illuminismo stesso, divenuto padrone di sé e forza materiale, potrebbe spezzare i limiti dell’illuminismo».
Ecco, non con l’illusione dì «superare la malattia dello spirito» di cui parla Adorno, ma almeno per captarne le matrici, merita esaminare brevemente i tre aspetti dell’antisemitismo attuale; non vedo strada migliore per assumersi l’eredità dei morti del 16 ottobre, e dei milioni di morti, ebrei e non-ebrei.
La nascita dello Stato d’Israele, che l’Unione Sovietica fu il primo paese a riconoscere, è il prodotto concreto, naturale e miracoloso, di questa tragica eredità. Nessun ebreo autentico può non essere sionista, poiché il sogno del ritorno a Gerusalemme fa parte integrante, ineliminabile, della tradizione, direi dell’antropologia ebraica. Questo sogno è passato dal livello religioso a quello politico come conseguenza di due millenni di persecuzioni, e specificamente in seguito al fallimento dell’ideologia illuminista. II famoso processo Dreyfus, collegato agli orrendi pogrom dell’Europa orientale, ha determinato lo scatto. Se non si fosse costruito il «focolare ebraico» in Palestina, il 16 ottobre 1943 i deportati ebrei di Roma sarebbero stati molto più numerosi; forse, nei vagoni piombati descritti da Giacomo De Benedetti e da Elsa Morante sarebbero stati rinchiusi, lo dico rabbrividendo, anche i miei genitori e le mie sorelle, che si salvarono trasferendosi in terra d’Israele. Viceversa, se la Gran Bretagna, potenza mandataria, l’avesse permesso, e se la maggioranza degli ebrei europei, a cominciare dai tedeschi, non fossero stati sordi all’appello sionista, i sei milioni dei lager nazisti sarebbero scesi a cinque, quattro, tre, forse nessuno, perché uno Stato d’Israele, proclamato nel 1939 anziché nel ’48, avrebbe forse potuto esercitare una pressione atta a mobilitare l’opinione pubblica internazionale contro la strage. Né basta. Il collegamento tra ebrei romani e Stato d’Israele s’incarna nella figura di Enzo Sereni, pioniere del sionismo, esponente del movimento comunista dei kibbutzim, che, durante la guerra, per partecipare alla resistenza italiana, si fece paracadutare presso Firenze e finì a Dachau.
Da questi dati di partenza dobbiamo prendere le mosse per riflettere sui dissensi che si verificano, nell’ambito della sinistra europea, sulla politica dello Stato d’Israele. Non è questa la sede per esaminarli analiticamente, ma tacerne significherebbe tradire i morti del 16 ottobre. Certo, è più facile commuoversi per gli ebrei morti che per quelli vivi, per i perseguitati e gli sconfitti che per coloro che combattono per sopravvivere. Ma non si può pretendere che gli israeliani depongano le armi, arrendendosi a chi dichiara di volerli distruggere e ha tentato più volte di farlo. Il conflitto tra israeliani e palestinesi angoscia gli ebrei più dei non-ebrei, perché lo Stato d’Israele non può vivere senza pace nel Medio Oriente, senza un accordo di convivenza e poi di fratellanza con gli arabi e, in primo luogo, con i palestinesi. Tuttavia, un accordo non si raggiunge rifiutando di riconoscere il diritto all’esistenza dell’altro, dopo aver esasperato la tensione mantenendo i palestinesi in campi di concentramento, mentre decine di migliaia di ebrei, residenti da secoli nei paesi arabi, ne venivano cacciati, ma trovavano asilo e cittadinanza nello Stato d’Israele. Non si favorisce la pace, e quindi una convivenza, possibile e necessaria, fra israeliani e palestinesi subendo i ricatti del petrolio, schierandosi indiscriminatamente da una parte contro l’altra, e costringendo l’altra a cercare altri appoggi e solidarietà. Per triste che sia, la politica degli Stati va giudicata obiettivamente, nel terreno delle forze e degli equilibri. Abbiamo assistito ad avvenimenti imprevedibili e paradossali, al patto Hitler-Stalin, all’alleanza Mao-Nixon in Angola, e tutti sono stati giustificati o almeno spiegati alla luce dello stato di necessità o dei bilanciamenti di potere. Solo quando si tratta dello Stato d’Israele, si vorrebbe una politica rinunciataria, idillica, astratta, suicida, che magari rifiutasse le armi americane per non essere accusata di collusione con l’imperialismo occidentale, mentre le nazioni arabe sono armate fino ai denti da altre fonti e anche dalla stessa fonte. Malgrado la guerra del Kippur, che vede l’Egitto e la Siria sferrare un attacco nel giorno del digiuno, certi giornali continuarono a parlare sistematicamente e solo di «israeliani aggressori» come per millenni nelle chiese si è parlato di «perfidi giudei». Anche a proposito della tragedia del Libano, sembra spiacere ad alcuni che non si possa accusare Israele di armare la Siria; e abbondano i corrispondenti dal Libano che cercano, con sottili allusioni o con smaccata distorsione della verità, di interpretare la difesa israeliana dei propri confini come un contributo ai massacri che suscitano l’indignazione degli ebrei non meno di quella di ogni uomo civile. Certo, è legittimo dissentire dalla politica israeliana e criticarla; essendo Israele un paese democratico, l’unico di quell’area, molti israeliani dissentono e criticano. Ma l’antisionismo è una mascheratura dell’antisemitismo e, peggio, è un veleno che si propaga. È recente la notizia di uno sciopero di impiegati di una casa editrice per bloccare la traduzione di un libro sull’episodio di Entebbe, con l’alibi che sarebbe «così filosionista» da rasentare «il razzismo».
Siamo dunque alla censura sull’informazione, mentre in edicola si può comprare, in edizione economica, il «Mein Kampf» di Hitler. Ripeto e sottolineo: qui non si denuncia l’antisemitismo per difendere gli ebrei cui, nel corso dei secoli, sono stati ascritti tali e tanti crimini, da far apparire quello di essere sionisti tra i più blandi tautologici, pari all’essere circoncisi. Ma l’antisionismo esaspera l’antisemitismo, porta alla discriminazione e alla censura, fenomeni pericolosi prima per gli ebrei, poi per tutti gli uomini liberi. Lo attestano due fatti: uno di gravità incalcolabile, la crescente ondata di antisemitismo nei paesi dell’est; l’altro minore ma degno di rilievo anche perché verificatosi a Roma, le bottiglie incendiarie lanciate contro la Sinagoga in strumentale concomitanza di una manifestazione della sinistra. E notate: quest’ultimo episodio è stato accompagnato da un altro gesto non meno ignobile: il fuoco appiccato agli indumenti e ai medicinali raccolti per i palestinesi del Libano. Ha scritto «l’Unità» in un corsivo intitolato «Barbari»: «Non si può escludere che tanto il vergognoso attentato contro la sinagoga ebraica come l’incendio alla sede del Gups risalgano, se non alla stessa mano, a uno stesso disegno diretto a creare allarme, disordine e confusione e magari a suscitare fantasmi di antiche, indegne, discriminazioni respinte per sempre dalla coscienza democratica del nostro popolo». Esatto: sembra assurdo che palestinesi ed ebrei vengano attaccati simultaneamente, ma in fondo è logico e comunque istruttivo. I fascisti approfittano sempre delle situazioni equivoche e l’antisionismo viscerale ne favorisce le nefande azioni. Sarò telegrafico sul secondo punto riguardante la Chiesa cattolica il cui secolare antisemitismo fa da armonico sfondo alla giornata del 16 ottobre. Il Concilio Vaticano ci ha sollevato dalla condanna di popolo deicida. È molto: dopo duemila anni, abbiamo smesso di essere gli assassini di Cristo, siamo assolti per insufficienza di prove. Questo però non ci rende ancora cittadini pari agli altri, poiché il Concordato firmato dal fascismo e i relativi Patti Lateranensi ci mantengono sempre, insieme alle altre minoranze religiose, e ai laici, in situazione di inferiorità, soggetti alle conseguenze dei privilegi riconosciuti alla Chiesa e ai suoi ordini nelle scuole statali e confessionali, negli enti assistenziali pubblici e cattolici. Anche in questo caso, la denuncia del Concordato non concerne gli ebrei in quanto tali, che, abituati a ben altre discriminazioni, trovano quelle attuali di entità quasi negligibile. La denuncia del Concordato concerne gli italiani, e specie i romani, ad ogni scala: senza l’abolizione dei privilegi ecclesiastici non si può concretare nessuna riforma seria, né sanitaria, né scolastica, né fiscale, né urbanistica, perché quei privilegi non lo consentono. Ciò è stato dimostrato tante volte che è inutile indugiarvi. In materia, la condizione ebraica altro non è che la cartina di tornasole dell’indipendenza e del carattere laico della Repubblica Italiana.
E vengo all’ultimo punto, il più spinoso: l’urgenza di una revisione delle tesi marxiste sulla questione ebraica. Problema delicato, che esigerebbe un’ampia e approfondita disamina, ma che va almeno posto come problema senza ulteriori dilazioni, nel comune interesse dell’ebraismo e del marxismo. È noto che Carlo Marx scrisse, nel 1843, un famigerato libello su « La questione ebraica» in cui si legge, per citarne solo due frasi, che «il denaro è il glorioso Dio d’Israele, di fronte al quale nessun altro dio può esistere» e che «l’emancipazione sociale dell’ebreo è l’emancipazione della società dal giudaismo». Questo rozzo o, a dir poco, ambiguo sfogo giovanile, purtroppo non mai smentito dal Marx maturo, fondatore del socialismo scientifico, è stato spiegato o come ricezione, dovuta ad ignoranza, dello stereotipo dell’ebreo mercante avido di denaro, secondo i pregiudizi ispirati dalla tradizione cristiana e dall’illuminismo militante; oppure, in chiave psicanalitica, come sentimento di colpa per il rifiuto della tradizione avita, come rimozione della parte «scomoda» della propria personalità, insomma come «odio ebraico di sé». Ciò sarà o non sarà vero. Il fatto grave però è che queste incrostazioni arcaiche e insieme infantili, questo aspetto nevrotico di Marx venticinquenne si è ripercosso in una sistematica diffidenza del marxismo rispetto al problema ebraico, in un’interpretazione dell’ebraismo e della sua cultura che Antonio Gramsci avrebbe definito peculiare del «materialismo volgare». Dei complessi di colpa, dell’«odio di sé in quanto ebreo» di Marx può importare poco; del resto, ha trovato un bilanciamento nell’ambito familiare, perché sua figlia. Eleonor Marx, in completo disaccordo del padre e con Engels, soleva iniziare i suoi discorsi ai lavoratori dichiarando «Io sono ebrea», quando in realtà non lo era. Risulta invece di vitale interesse che si proceda ad un integrale ripensamento marxista della questione ebraica. Non è un argomento meramente teorico e dottrinario, perché, come l’antisemitismo cattolico, le tesi di Marx hanno avuto e continuano ad avere deleteri riflessi, trovando eco in quelle di Bauer e Kautsky, nella posizione di Lenin, rispetto al Bund ebraico, in quella di Stalin e di altri marxisti, persino di un marxista ebreo, Abram Léon, il quale, dopo aver appartenuto al movimento della gioventù sionista-marxista, prima rigettò il sionismo, poi l’ebraismo, infine fu ucciso nel 1945, all’età di ventisei anni, nel lager di Auschwitz. Ebbene, se abbiamo avuto un Concilio Vaticano che ha cancellato l’onta di popolo deicida, è lecito chiedere un’assise marxista che, alla luce del pensiero gramsciano, smentisca una visione così ottusa, falsa, dannosa dell’ebraismo e porti, sono parole di Gramsci, al «riconoscimento del diritto per le comunità ebraiche dell’autonomia culturale (della lingua, della scuola, ecc.) ed anche dell’autonomia nazionale nel caso che una qualche comunità ebraica riuscisse, in un modo o nell’altro, ad abitare un territorio definito». Un profondo fermento rinnovatore qualifica in questi anni i partiti comunisti occidentali. L’eurocomunismo o l’eurosocialismo riproblematizza principi, come la dittatura del proletariato, che sembravano intoccabili. E, dunque, questo è il momento, quando i valori della cultura non sono più meccanicamente considerati sovrastrutturali e si sceglie la via del pluralismo, per realizzare una svolta decisiva del pensiero marxista ufficiale sulla questione ebraica, per decretare che il problema ebraico non va risolto con la scomparsa, con l’assimilazione forzosa, con l’annientamento l’autoannientamento degli ebrei in quanto tali, ciò che ha provocato e provoca laceranti discriminazioni antisemite. Gramsci sembra incitare a questa svolta scrivendo: «Se la filosofia della prassi (il marxismo) afferma teoricamente che ogni “verità” creduta eterna e assoluta ha avuto origini pratiche e ha rappresentato un valore “provvisorio” (storicità di ogni concezione del mondo e della vita), è molto difficile far comprendere “praticamente” che una tale interpretazione è valida anche per la stessa filosofia della prassi… La proposizione del passaggio dal regno della necessità a quello della libertà deve essere analizzata con molta finezza e delicatezza… La stessa filosofia della prassi tende a diventare una ideologia nel senso deteriore, cioè un sistema dogmatico di verità assolute ed eterne; specialmente quando…esso è confuso col materialismo volgare». Forse, l’iniziativa di questa revisione del pensiero marxista sulla questione ebraica potrebbe partire proprio dall’Italia di Gramsci, e da Roma dove, indipendentemente dalle posizioni assunte rispetto al sionismo e allo Stato d’Israele, i comunisti sono stati sempre a fianco degli ebrei contro l’antisemitismo fascista, sono stati sempre i primi ad accorrere in ghetto per schierarsi con la resistenza ebraica contro il teppismo che ripetutamente, anche in questi anni, ha compiuto gesta canagliesche in quel quartiere. È comunque un’ipotesi da elaborare, e un auspicio.
Ho finito. La seconda parte del mio discorso sarà forse considerata, da molti, ebrei e non ebrei, inopportuna. Forse bastava ricordare il 16 ottobre in poche parole emotive espungendo argomenti scottanti e controversi. Mi spiace, ne chiedo scusa; ma parlare dei morti serve nella misura in cui il loro sacrificio contribuisca alla vita, alla crescita della libertà, all’edificazione di un panorama culturale e civile che eviti altre infamie, altri massacri, altre discriminazioni, altre idolatrie, altri dogmatismi, altre censure. E poi, il Sindaco di Roma, prima di essere Sindaco, è stato mio maestro e mi ha insegnato a non accantonare i problemi scabrosi e a non prostrare mai la cultura all’opportunismo politico. Anche per tale insegnamento, nutro per lui un affetto grandissimo e devoto. So che, in ogni ora difficile e in ogni situazione rischiosa, si può fare come Giorgio Labò, si può dire «telefona ad Argan», anche perché Argan sa benissimo che in ogni ora difficile e in ogni situazione rischiosa, può chiamare e contare con certezza su tutti e su ciascuno di noi.
1977
-
Lezioni alla Scuola di Architettura dell’Università di Washington a Seattle.
-
Relazione generale al congresso dell’International Council of Societies of Industrial Design, Dublino.
-
Premio Simpatia, conferito dal Comune di Roma.
-
Professore onorario dell’Universidad Naciónal de San Antonio Abad di Cuzco.
Carta urbanistica del Machu Picchu.
Carta urbanistica del Machu Picchu
12 dicembre 1977, ore 14,30: sullo spiazzo più alto del rudere incaico, il testo viene firmato da decine di artisti e studiosi. Perché questa nuova «carta», a distanza di quarantaquattro anni da quella formulata da Le Corbusier ad Atene nel 1933? Ci sono anzitutto quattro motivi:
a) città e regione. Nel 1933 il rapporto era di interdipendenza tra cose sostanzialmente diverse. Nel 1977 città e regione fondono, abbiamo la città-regione;
b) polifunzionalità. Nel 1933 poteva essere utile distinguere tra abitare, lavorare, ricrearsi e circolare. Nel 1977, di fronte ai guasti della settorializzazione urbana, l’impegno è di reintegrare;
c) comunicazione. Nel 1933 l’abitazione sembrava costituire la chiave della vita urbana. Nel 1977: la sopravvivenza degli aggregati sparsi nel territorio dipende dall’efficienza delle comunicazioni;
d) architettura. La Carta di Atene trascurava di parlare degli aspetti linguistici, perché la figura dominante di Le Corbusier faceva presupporre che l’architettura si esaurisse nel «gioco sapiente dei volumi puri sotto la luce». Nel 1977 la sfida consiste negli spazi sociali in cui vivere.
L’animus è poi profondamente cambiato:
«Atene 1933, Machu Picchu 1977. I luoghi significano. Atene incarnava la culla della civiltà occidentale. Il Machu Picchu simbolizza il contributo culturale di un altro mondo. Atene implicava la razionalità di Platone e di Aristotele, l’illuminismo. Il Machu Picchu rappresenta tutto ciò che sfugge alla mentalità categorica dell’illuminismo e non è classificabile nella sua logica. I nostri interrogativi sono infinitamente più numerosi e complessi di quelli affrontati dagli autori della Carta di Atene. Alcuni forse non hanno risposta…».
La Carta
Un cantore del Machu Picchu, in una delle sue brillanti metafore, definì la città perduta come “l’anfora più alta che contenne il silenzio”. Un gruppo di architetti ha affrontato l’ambizioso compito di rompere questo silenzio; tale è l’animus che ispira la presente Carta. Sono trascorsi quasi 45 anni da quando Le Corbusier e i suoi collaboratori del CIAM promulgarono un documento sulla teoria e la metodologia della pianificazione, che fu denominato la Carta di Atene. Molti fenomeni nuovi, emersi in questo periodo, richiedono un aggiornamento della Carta o un altro documento di portata mondiale, elaborato su basi interdisciplinari nell’ambito di una discussione internazionale che coinvolga intellettuali, professionisti, istituti di ricerca e università di tutti i paesi. Ci sono già stati alcuni tentativi di ammodernare la Carta di Atene. La dichiarazione che segue intende essere soltanto un dato di partenza per tale impresa. Essa riconosce anzitutto che la Carta di Atene del 1933 è ancora un documento fondamentale per la nostra epoca. Può essere aggiornata, ma non ripudiata. Molti dei suoi 95 punti sono tuttora validi, ciò che testimonia sulla vitalità e la continuità del movimento moderno, in urbanistica e in architettura. Atene 1933, Machu Picchu 1977. I luoghi significano. Atene incarnava la culla della civiltà occidentale. Il Machu Picchu simbolizza il contributo culturale di un altro mondo. Atene implicava la razionalità di Platone e di Aristotele, l’illuminismo. Il Machu Picchu rappresenta tutto ciò che sfugge alla mentalità categorica dell’illuminismo e non è classificabile nella sua logica. I nostri interrogativi sono infinitamente più numerosi e complessi di quelli affrontati dagli autori della Carta di Atene. Alcuni forse non hanno risposta. Ma è nostro dovere proporre almeno un indice preliminare dei problemi emersi nelle ultime decadi.
1. Città e regione
La Carta di Atene sancì l’unità essenziale delle città e delle loro regioni. Ma l’incapacità generale di affrontare la realtà e le esigenze della crescita urbana e delle trasformazioni socio-economiche induce a riaffermare questo principio in termini più specifici e pressanti. Oggi, in tutto il mondo, il fenomeno dell’urbanizzazione ha portato a un punto critico la necessità di un uso più efficace delle risorse naturali e umane. La pianificazione, quale strumento sintetico per analizzare i bisogni, i problemi, le possibilità e per guidare la crescita, lo sviluppo e i mutamenti urbani nei limiti delle risorse disponibili, è un obbligo fondamentale dei governi impegnati nel tema degli insediamenti umani. Nel contesto dell’urbanizzazione contemporanea, i piani devono esprimere l’unità dinamica delle città e delle circostanti regioni, non meno che le relazioni funzionali essenziali tra quartieri, comprensori e altre aree urbane. Le tecniche e la metodologia della pianificazione devono essere applicate a tutte le scale degli insediamenti umani – quartieri, città, aree metropolitane, regioni, nazioni – per orientare le localizzazioni, i tempi e le caratteristiche dello sviluppo. L’obiettivo del pianificare, in generale, cioè della programmazione economica, urbana e architettonica, è in sostanza l’interpretazione delle esigenze umane e l’approntamento di strutture e servizi urbani congeniali a una situazione sociale in sviluppo. Questa pianificazione richiede un continuo, sistematico processo di interazione tra progettisti, utenti, amministratori e politici. La mancanza di connessione tra programmi economici nazionali e regionali e piani urbanistici ha implicato uno spreco che ha ridotto l’efficacia di entrambi. Troppo spesso le aree urbane riflettono gli effetti secondari di decisioni economiche basate su strategie vaste e astratte, a lungo termine. Queste decisioni, a livello nazionale, hanno trascurato le necessità prioritarie delle aree urbane e l’interdipendenza operativa fra strategia economica generale e pianificazione del territorio. Perciò la maggior parte della popolazione non ha goduto i benefici potenziali della pianificazione urbanistica e architettonica.
2. La crescita urbana
Dal tempo della Carta di Atene, la popolazione mondiale si è raddoppiata, determinando una triplice crisi: ecologica, energetica e alimentare. Poiché il ritmo della crescita demografica nelle città è assai più rapido dell’aumento generale della popolazione, a questa crisi va aggiunto il decadimento urbano, sottolineato dalla penuria di case, dalla deficienza dei servizi pubblici e dei trasporti, dal deteriorarsi della qualità della vita. Le soluzioni urbanistiche proposte dalla Carta di Atene non potevano prevedere un fenomeno di tale portata, prodotto dall’esodo rurale che è oggi alla base dei problemi urbani. Si possono distinguere due specifiche caratteristiche del caotico accrescimento delle città: la prima corrisponde alle regioni industrializzate, dove gli abitanti economicamente più agiati emigrano verso i sobborghi, resi agibili dalla diffusione dell’automobile, abbandonando le aree centrali a nuovi immigranti che non hanno le capacità economiche e culturali per garantirne il mantenimento e i servizi; la seconda riguarda le regioni in via di sviluppo, le cui enormi città sono invase da una massiccia immigrazione rurale che s’insedia in zone marginali prive d’ogni genere di servizi e di infrastrutture. Questi fenomeni non possono essere risolti e neppure controllati con gli usuali strumenti e con le normali tecniche della pianificazione urbana. Dette tecniche tentano di incorporare le aree marginali nell’organismo della città e, in molti casi, le misure adottate per regolamentare la marginalità (introduzione di servizi pubblici, strade, case popolari ecc.) paradossalmente contribuiscono ad aggravare il problema, incentivando i movimenti immigratori. Le variazioni quantitative producono così fondamentali alterazioni qualitative.
3. Le funzioni integrate
La Carta di Atene suggerisce che la chiave dell’assetto urbano attiene a quattro funzioni basiche: abitare, lavorare, ricrearsi e circolare; i piani regolatori devono definire la struttura e la localizzazione di queste funzioni. Questo ha portato a una settorializzazione funzionale delle città, dove il processo analitico è stato scambiato con l’approccio sintetico atto a creare un ordinamento urbano. Di conseguenza, le relazioni interpersonali nella vita delle città sono state ostacolate al punto che ogni opera architettonica è divenuta un oggetto isolato e le interrelationi spaziali sono determinate principalmente dalla mobilità umana. L’esperienza degli ultimi anni ha evidenziato che lo sviluppo urbano non deve incoraggiare la divisione delle città in distinti settori funzionali, ma invece deve mirare a un’integrazione polifunzionale e contestuale.
4. L’abitazione
A differenza della Carta di Atene, noi giudichiamo che la comunicazione umana sia il fattore predominante nell’esistenza stessa della città. Pertanto, la pianificazione urbana e i programmi di edilizia residenziale devono tener conto di questo fatto. Consideriamo inoltre che la qualità della vita e la sua integrazione con l’ambiente naturale sia un fondamentale traguardo nella formulazione di spazi abitabili. Le case popolari non vanno intese come meri prodotti di consumo, sibbene come potenti strumenti di sviluppo sociale. La progettazione delle abitazioni deve avere la flessibilità necessaria per adattarsi alla dinamica sociale, facilitando la partecipazione creativa degli utenti; perciò dovrebbero essere progettati e prodotti in massa elementi edilizi assemblabili da parte dei fruitori, secondo il loro livello economico. Lo stesso spirito di integrazione che rende il problema comunicativo fra gli abitanti della città un elemento basico della vita urbana dovrebbe presiedere alla localizzazione e alla struttura delle aree residenziali dei diversi gruppi comunitari, evitando separazioni inaccettabili alla dignità umana.
5. I trasporti
Le città devono programmare e gestire un sistema di trasporti pubblici di massa, considerandolo un aspetto basilare della pianificazione urbana. Il costo sociale dei sistemi di circolazione va correttamente valutato nello studio dell’ampliamento delle città. La Carta di Atene fu esplicita nel definire la circolazione una fondamentale funzione urbana, ma implicò la sua dipendenza dall’automobile come mezzo di trasporto individuale. Dopo 45 anni, appare chiaro che la soluzione ottimale non consiste nel differenziare, moltiplicare e articolare le connessioni stradali. È ormai evidente, e va sottolineato, che la soluzione dei trasporti deve essere ricercata subordinando i mezzi individuali a quelli pubblici di massa. Gli urbanisti devono capire che la città è una struttura in sviluppo la cui forma non può essere definita, perché occorre prevederne la flessibilità e l’estensione. I trasporti e le comunicazioni producono una serie di griglie interconnesse che servono come un sistema articolato fra spazi interni ed esterni, e vanno progettate in maniera tale da ammettere una sperimentazione infinita nei mutamenti di forma ed estensione.
6. La disponibilità del suolo urbano
La Carta di Atene affermò la necessità di una legislazione che consentisse di utilizzare il suolo per fini sociali, subordinando gli interessi privati a quelli collettivi.
Malgrado i vari sforzi compiuti dal 1933 in poi, le difficoltà incontrate nell’esproprio delle aree fabbricabili continuano a frapporre un ostacolo rilevante alla pianificazione urbana. Si auspica perciò l’adozione di misure legislative efficienti, capaci di produrre sostanziali miglioramenti a breve termine.
7. Risorse naturali e inquinamento ambientale
Una delle più serie minacce contro la natura è determinata oggi dall’inquinamento ambientale che si è aggravato fino a raggiungere proporzioni senza precedenti, potenzialmente catastrofiche, quale diretta conseguenza di una urbanizzazione non pianificata e di un eccessivo sfruttamento delle risorse. In tutto il mondo, nelle aree urbanizzate la popolazione è sempre più soggetta a condizioni ambientali incompatibili con standards sanitari decenti e col benessere umano. Tra le caratteristiche inaccettabili delle odierne aree urbane si annoverano eccessive quantità di sostanze tossiche nell’atmosfera, nell’acqua e negli alimenti, nonché dannosi livelli di rumore. La politica di piano che sovrintende allo sviluppo urbano deve includere immediate misure per evitare che si accentui questa degradazione ambientale e per incentivare il restauro di un ambiente consono alle norme dell’igiene e del benessere umano. Queste misure possono e devono riflettersi nella programmazione economica e urbanistica, nella progettazione architettonica, nei criteri e nelle normative tecniche, in genere nella politica di sviluppo.
8. Tutela e preservazione dei valori culturali e del patrimonio storico-monumentale
L’identità e il carattere di una città sono formati, ovviamente, non solo dalla struttura fisica ma anche dalle connotazioni sociologiche. Per questo è necessario salvaguardare e conservare le pietre miliari della nostra eredità storica e i suoi valori culturali, onde riaffermare le peculiarità comunitarie e nazionali e/o quelle che assumono un autentico significato per la cultura in generale. Analogamente, è indispensabile che l’azione preservatrice, di restauro e riciclaggio di ambienti storici e monumenti architettonici, sia integrata nel processo vitale dello sviluppo urbano, anche perché questo costituisce l’unico modo di finanziare e gestire tale operazione. Nel processo di riciclaggio di queste zone va presa in considerazione la possibilità di innestarvi edifici moderni di alta qualità.
9. La tecnologia
La Carta di Atene si riferisce solo tangenzialmente al processo tecnologico, allo scopo di discutere l’impatto dell’attività industriale sulla città. Negli ultimi 45 anni, il mondo ha sperimentato un avanzamento tecnologico senza precedenti, che ha inciso sugli orientamenti e sulla pratica dell’architettura e dell’urbanistica. La tecnologia si è sviluppata in parecchie regioni del mondo e la sua diffusione ed efficiente applicazione sono un problema fondamentale della nostra epoca. Oggi lo sviluppo scientifico e tecnologico e le comunicazioni tra i popoli consentono il miglioramento delle condizioni locali e offrono maggiori possibilità di risolvere i problemi urbani ed edilizi. Il cattivo uso di queste possibilità porta spesso ad adottare materiali, tecniche e forme dettati dalla moda o da un’intellettualistica inclinazione alla complessità. In questo senso, l’impatto dello sviluppo tecnico e meccanico ha fatto sì che assai spesso l’architettura sia divenuta un processo per realizzare ambienti condizionati artificialmente, concepiti in funzione di un clima e di un’illuminazione innaturali. Ciò può costituire una soluzione per certi problemi, ma l’architettura deve essere il processo di creare un ambiente pianificato in armonia con gli elementi della natura. Dovrebbe essere chiaramente inteso che la tecnologia è un mezzo e non un fine. Va applicata per realizzare le sue potenzialità in seguito a un serio lavoro di ricerca sperimentale, compito che i governi dovrebbero prendere in considerazione. La difficoltà di usare processi altamente meccanizzati o materiali industrializzati deve implicare non una mancanza di rigore tecnico o di giusta risposta architettonica al problema da risolvere, ma una disciplina più approfondita nel pianificare le soluzioni realizzabili con i mezzi disponibili. La tecnologia costruttiva deve studiare la possibilità di riciclare i materiali al fine di trasformare gli elementi edilizi in risorse utili al rinnovo urbano.
10. L’attuazione dei piani
Le autorità pubbliche e la professione devono riconoscere che gli obiettivi del processo di pianificazione non si esauriscono redigendo piani regolatori urbani e regionali. È responsabilità dei governi e della professione perseguire l’attuazione dei piani e delle politiche su cui sono basati. Dato il costante processo di mutamento che incide sulle città e sulle aree urbane, le pubbliche autorità hanno anche l’obbligo di aggiornare e revisionare i piani di tempo in tempo, secondo le circostanze. Va anche compreso che ogni area urbana o regionale, nel processo di attuazione dei piani e delle politiche di sviluppo, deve raggiungere un proprio equilibrio rispetto all’ambiente, ai limiti delle risorse e alla forma fisica.
11. Progettazione urbana e architettura
La Carta di Atene non si occupò di design architettonico. Non era necessario, perché coloro che la firmarono concordavano nel definire l’architettura “le jeu savant des volumes purs sous la lumière”. La Ville Radieuse era composta di tali volumi; applicava un linguaggio architettonico di matrice cubista perfettamente coerente con la concezione e la metodologia di un pianificare volto alla scomposizione della città nelle sue parti funzionali. Durante le recenti decadi, l’architettura moderna è cresciuta. Il suo problema principale non è più il gioco visuale dei volumi, ma la creazione degli spazi sociali in cui vivere. L’accento ora non è sul contenente, ma sui contenuti; non sulla scatola edilizia isolata, per quanto bella e sofisticata essa sia, ma sulla continuità del tessuto urbano. Nel 1933, lo sforzo era diretto a disintegrare l’oggetto architettonico, e la città, nelle sue componenti. Nel 1977, mira a reintegrare queste componenti che, fuori della loro relazione, hanno perduto vitalità e significato. La reintegrazione, in architettura come in urbanistica, non è l’integrazione a priori tipica del classicismo. Va detto con franchezza che i vari tentativi di risuscitare revivals Beaux-Arts sono antistorici ad un grado grottesco, tanto da non meritare neppure di essere discussi. Ma sono sintomi di un consumo linguistico di cui dobbiamo tener conto, non per retrocedere ad una sorta di eclettismo ottocentesco, bensì per attingere uno stadio più maturo del movimento moderno. Per essere precisi, le conquiste degli anni Trenta, quando la Carta di Atene fu promulgata, sono ancora pienamente valide. Esse concernono: a) l’analisi delle funzioni e dei contenuti edilizi, b) il principio della dissonanza, c) la visione antiprospettica spazio-temporale, d) la disgregazione della tradizionale scatola edilizia, e) la riunificazione dell’ingegneria strutturale con l’architettura. A queste “costanti” o “invarianti” linguistiche ne vanno aggiunte altre due: f ) la temporalizzazione dello spazio, e g ) la reintegrazione edificio-città-territorio. Lo spazio temporalizzato è il massimo contributo di Frank Llovd Wright: corrisponde alla visione dinamica spazio-temporale del cubismo applicandola non solo ai volumi, ma anche agli spazi umani, non solo ai valori visuali ma anche a quelli sociali. Quanto alla reintegrazione edificio-città-territorio, è la naturale conseguenza della reintegrazione tra città e campagna. È giunto il momento di rivolgere un appello agli architetti affinché divengano pienamente coscienti dello sviluppo storico del movimento moderno, e cessino di moltiplicare panorami urbani obsoleti, composti da prismi monumentali, verticali od orizzontali, opachi, riflettenti o trasparenti. La nuova urbanistica esige una continuità edilizia, e questa implica che ogni elemento del continuum richieda un dialogo con gli altri elementi per completare la propria immagine. Il principio del “non-finito” non è nuovo. Fu indagato dai manieristi e, in forma esplosiva, da Michelangiolo. Ma adesso è un principio non meramente visuale, sibbene soprattutto sociale. L’esperienza dell’arte, nelle ultime decadi, ha dimostrato che l’artista non produce più oggetti finiti: si ferma a metà strada, o a tre quarti, del processo creativo in modo che lo spettatore non sia più in stato di passiva contemplazione dell’opera d’arte, ma divenga un fattore attivo del suo messaggio polivalente. Nel campo edilizio, la partecipazione dei fruitori è anche più importante e concreta. Significa che la popolazione deve partecipare attivamente e creativamente ad ogni fase del procedimento progettuale, al fine di integrare il lavoro dell’architetto. L’approccio non-finito non diminuisce il prestigio dell’urbanista o dell’architetto. Le teorie della relatività e dell’indeterminazione non hanno ridotto il prestigio degli scienziati. Al contrario, l’hanno accresciuto, perché uno scienziato non dogmatico è rispettato assai più del vecchio “deus-ex-machina”. Se la gente è coinvolta nel processo architettonico, il rilievo sociale dell’architetto ne risulterà elevato. E l’alimento per l’inventività architettonica sarà più grande e ricco. Infatti, se gli architetti si liberano dal precetto accademico della finitezza, la loro immaginazione potrà essere stimolata dall’immenso patrimonio dell’architettura popolare (Kitsch incluso), di quella “architettura senza architetti” recentemente tanto studiata. Anche qui, tuttavia, dobbiamo fare attenzione. Riconoscere che i vernacoli e i gerghi edilizi possono contribuire alla fantasia architettonica non significa imitarli. Una simile operazione, tanto di moda oggi, è folle quanto copiare il Partenone. Il problema è affatto diverso da quello dell’imitazione. È un fatto accertato che l’approccio più colto alla progettazione architettonica, proprio perché è libero da ogni convenzione – dagli ordini di Vitruvio e da quelli Beaux-Arts, come dai “cinque principi” corbusieriani del 1921 – incontra spontaneamente e si fonde con gli idiomi popolari. La partecipazione degli utenti renderà questo incontro tra linguaggio di alta cultura e linguaggio popolare più organico e autentico. A volta, per la loro monumentalità, le costruzioni sulle alture dell’antico Perù sono state paragonate alle piramidi egiziane. Fisicamente, per la grandiosità di ambedue le concezioni, il confronto è calzante. Ma queste furono edificate come monumento alla morte che esaltava la gloria del faraone, mentre quelle furono elevate per le comunità, come monumento alla vita. Vita sulle vette e morte in pianura esprimono, volumetricamente e spiritualmente, la rotta diversa di due grandi civiltà che edificarono per l’eternità.
Firmato:
Santiago Agurto Calvo, Perú; Fernando Belaunde Terry, Felix Candela, Chicago; Francisco Carbajal de la Cruz, Mexico, D.F.; George Collins, New York; Leonard J. Currie, Chicago; Jorge Glusberg, Buenos Aires; Mark Jaroszewicz, Florida ; Oscar L. de Guevara, Cuzco; Alejandro Leal Garcia, Mexico, D.F.; Reginald Malcolmson, Michigan, Ann Arbor; Dorn Mc. Grath, Washington, D.C.; Luis Miro Quesada Garland, Perù; Carlos Morales Machiavello, Perù; Guillermo Payet Garreta, Perú; Paulo Pimentel Morales, Caracas; Felipe Prestamo, Florida; Hector Velarde, Perú; Fruto Vivas, Caracas; Bruno Zevi, Roma; e da Manuel Ungaro Zevallos, Oscar Alvarez, Elizabeth Carrarco, Perú.

 English
English